Tecnologie conviviali - libro completo
Libro
Tecnologie conviviali
Milani
Cartaceo 16,15 € E-book 6,99 €
INDICE DEL LIBRO:
Prefazione
di Davide Fant
Il demone di TikTok
Mi presento sono il demone di TikTok / A me lasciati andare e non farai più flop / Occhio ai cuoricini, collezionane tanti / Entra nella gara, sarai tra i più importanti / Ti mostro chi ha successo così presto capirai / Come essere apprezzato e il tuo status alzerai / Trucco 1: mostra ammicca – sarà mica un dramma / Aggiungi doppi sensi e poi spamma / Trucco 2: sii simpatico – spingi sul ridicolo / Trucco 3: sii estremo – gioca col pericolo!
Quello che avete letto è la voce del demone di TikTok. L’abbiamo evocata con un gruppo di adolescenti. Siamo riusciti a materializzarla addirittura in forma di rap.
Non molti sanno che ogni applicazione, anzi, ogni tecnologia, contiene un demone, una presenza che può essere anche molto insidiosa perché ha il potere di influenzare i nostri comportamenti senza però esserne consapevoli. Possedere i poteri per percepirne la presenza è quindi più che mai importante: se percepiamo la direzione verso cui uno strumento vuole spingere il nostro agire possiamo attivare strumenti per resistergli, oppure scegliere di sostituirlo con un altro. Siamo liberi di giocare la nostra parte.
È per questo che gli adepti di circe, il Centro Internazionale di Ricerca per le Convivialità Elettriche, sono invitati nelle scuole, negli spazi culturali, incontrano gruppi di giovani e di meno giovani, per iniziare più persone possibile (quelle che lo desiderano…) a questa inusuale pratica emancipatoria.
Come ogni potere, non è immediato prenderne possesso. Ci vuole la pazienza che ogni iniziato deve mantenere, ci vuole un cambio di sguardo, lo sforzo di muoversi su una prospettiva diversa; e poi è necessario un gruppo di riferimento per confrontarsi, camminare insieme, perché nessuna liberazione è mai solitaria.
Come funziona? Non c’è qui lo spazio per raccontarlo nel dettaglio, ci saranno altre occasioni (accostarsi agli incantesimi è una cosa seria, ha bisogno del suo tempo). A ogni modo, per spoilerare un po’ il segreto, questa tecnica si basa su un approccio contrario a quello che solitamente abbiamo verso le applicazioni digitali, nel nostro caso i social network. Non bisogna concentrarsi sulle foto, sui video, sui testi postati, ma mettere piuttosto a fuoco ciò che passa in secondo piano nella percezione cosciente, ovvero gli elementi che formano la cornice di questi contenuti: tasti, funzioni, architettura estetica del software, oggetti e geometrie stabilite dal progettista, la «cornice» insomma. Ci vuole molta attenzione, non bisogna trascurare niente!
Ultimamente abbiamo anche una formula per lanciare questa consegna, per entrare in questa modalità; anche lei ha un ritmo, come tutti gli incantesimi (un ritmo «terzinato» come la trap…):
Svuota la mente – segui – lascia andare i pensieri / Prenditi il tempo per fare silenzio – ti voglio qui – attento / Affila lo sguardo – non è un azzardo – aguzza gli occhi come fari / Chiunque già sa – che’l demone sta – nascosto nei particolari / Sfuoca ogni contenuto – cancella ogni testo ogni foto / Cosa rimane lì in quella cornice qui c’è il segreto del gioco / Dimmi che vedi in che disposizione non gli hai mai fatto attenzione / Prenditi nota scopri che vento spira nell’applicazione.
Dopo aver svolto questo compito-rituale con disciplina potremo, attraverso pochi semplici passaggi, capire cosa è «importante» per quel particolare software, quali sono i suoi valori, e quindi in che direzione il suo «subdolo vento» ci vuole spingere.
Tornando a TikTok, potremo scoprire ad esempio, come è avvenuto durante il laboratorio, che:
– TikTok vuole che competiamo tra di noi per avere attenzione (l’app ci mostra di continuo il punteggio di quanto siamo visti e apprezzati: le view, i like).
– Per TikTok il valore dell’immagine è centrale (lo schermo riempie praticamente l’intero spazio disponibile, per l’app non siamo niente se non ciò che appare).
– TikTok vuole che troviamo soluzioni per attirare questa attenzione in pochissimo tempo, dobbiamo «colpire» (la durata dei video è imposta come molto breve).
Da qui è facile intuire che saremo portati a sviluppare (sempre con lo zampino del demone…) trucchetti per avere successo in questa competizione, posizionarsi bene al suo gioco. I modi per attirare immediatamente l’attenzione sono sempre gli stessi: mostrarsi belli, provocanti, oppure essere ridicoli, o ancora fare qualcosa di assurdo, estremo, pericoloso, stuzzicare eccitazione e attenzione morbosa.
Certo è possibile sforzarsi a non ascoltare il demone, e si può anche usare TikTok in altri modi, ma si è condannati all’irrilevanza, e presto ci si stanca. Ci si sente coinvolti quando si sta alle sue regole, quando si gioca sul filo del rasoio. Il piano è sempre inclinato nella direzione in cui il suo spirito ha deciso di accompagnarci.
«Ma allora…», dicono i ragazzi, «non è un caso se tutte le persone che vanno su TikTok si spingono fino al ridicolo, o provocano! E forse non è un caso neppure che quella ragazza ha fatto qualcosa di davvero rischioso e la cosa è andata a finire male… Forse qualcosa era già nell’app… ha un certo potere… e conosce bene le nostre vulnerabilità…».
Quando gli adolescenti si lasciano sorprendere da intuizioni del genere si apre uno spazio di movimento e di pensiero nuovo, sorge il desiderio di andare fino in fondo, di capire «come funziona», e se e come è possibile aprire spazi di resistenza e di libertà.
Non è solo una questione di adolescenti
Il demone non c’è solo per gli adolescenti ma per tutti: è un attimo e chiunque può essere coinvolto nella sua danza. Sarebbe facile, e in un certo senso un sollievo, pensare: «Sì, beh TikTok!…», «sì, beh gli adolescenti!…». Per rimanere nel mondo educativo e del sociale, pensiamo a quanto gli enti che si occupano di educazione e di comunità si siano fatti trascinare con leggerezza dal gioco dei social network con l’obiettivo di rendere visibile il proprio ente, di presentare come affascinanti le proprie attività; ma in questo modo non solo hanno nutrito il demone, ma hanno anche perso di vista la reale ricaduta per il proprio lavoro. «Più siamo visibili, più possiamo fare del bene» si ripete, ma è proprio vero o è il demone che vuole così? E intanto la cura dell’immagine diventa sempre più importante, e quello che postiamo diventa sempre più lo specchio privilegiato attraverso il quale percepiamo e diamo significato al nostro lavoro.
Oppure, sul fronte della scuola, non si può non citare la diffusione – accelerata dai vari lockdown – di piattaforme come Google Classroom, che promettono una più veloce comunicazione tra insegnanti e allievi, un comodo archivio per compiti, lezioni e consegne. In questo caso nel backstage si muove un demone che punta i riflettori sul controllo degli orari di consegna, sulle statistiche delle valutazioni degli studenti, che invita l’insegnante, con «spintarelle gentili», a passare a test a risposta chiusa che l’applicazione stessa correggerà, evitandogli fatica, rendendogli sempre più liscio e frictionless, come ci spiega Carlo Milani, il rapporto con il sapere dei discenti. L’insegnante non se ne accorge, ma curva il suo lavoro verso traiettorie che non ha mai deciso consapevolmente di inseguire.
Per un’educazione emancipante alla tecnologia
Il libro che avete tra le mani serve anzitutto a questo: a scovare demoni. Ci accompagna in un viaggio in cui, come nell’attività raccontata in apertura, si impara a guardare con occhi diversi le tecnologie: osservare con attenzione i dettagli, togliere gli strati, curiosare dietro gli schermi, per poi condividere quello che scopriamo. Ci propone una prospettiva rara, tanto più nel mondo educativo: quella di approcciare gli strumenti che fanno parte della nostra quotidianità focalizzando le dimensioni oppressive, di dominio, per poi aprire percorsi di emancipazione.
È un testo che non si limita alla parte teorico-critica, ma osa proporre nuovi sentieri percorribili, per quanto talvolta inconsueti. L’attività laboratoriale di cui ho raccontato è solo una delle tante declinazioni pratiche generate delle riflessioni che trovate nelle prossime pagine, una sfida cui da diversi anni ci stiamo dedicando – tra sperimentazione, ricerca, divertimento – insieme allo stesso autore e agli altri compagni di avventure di circe, più volte richiamata nel testo.
Quello in cui vi accingete a immergervi non è un libro di pedagogia, ma se letto in chiave prettamente pedagogica può portare ricchissimi stimoli, in particolare a chi è interessato a spingere la propria azione educativa nei territori di forme oppressive nascoste ai radar del discorso comune, e spesso anche degli addetti ai lavori, compresi i colleghi più attenti e sensibili.
Nelle scuole e nei contesti educativi si (stra)parla di tecnologia esaltando quelle abilità e competenze che i ragazzi devono possedere affinché si spalanchino loro le porte del futuro (lavorativo ovviamente), oppure se ne parla come risorsa che può rendere più efficace ed efficiente l’accumulo di sapere e di abilità. Ovviamente non manca anche la prevenzione dai rischi portati da questi ambienti, ma in un approccio declinato quasi sempre come lotta all’«usare male» i dispositivi: con loro possiamo perdere tempo, fare brutte cose o incontrare brutte persone che fanno fare brutte cose. In ogni caso lo strumento è sempre percepito come neutro (dipende da come lo usi…) e l’uomo è sempre chiamato a dominare, anzitutto la macchina, ottimizzando il guadagno che gli può portare, ma anche sé stesso, tenendo bene a mente che qualsiasi deviazione negativa avviene solo per colpa sua, perché non si è impegnato – leggi «dominato» – abbastanza (è scontato come in questo paradigma gli adolescenti non possano che uscirne male…).
Immersi in un panorama del genere risulta davvero un salto non da poco quello di percepire, come ci suggerisce Carlo Milani, le macchine come oggetti invece dotati di un proprio carattere, intrisi di «visioni del mondo situate», e decidere di abbandonare l’ossessione di dominarle (e dominare noi stessi nel nome della prestazione) per passare a uno sguardo conviviale e di cura.
L’autore ci invita a riconoscerci vulnerabili, a prenderci cura delle macchine, a riconoscere dinamiche di oppressione sottili (quei «demoni» che, come ci dice, sono tecnicamente nudge, esattamenti), a diffondere e condividere potere emancipante. Come cambierebbe l’educazione e la formazione se si scegliesse questa prospettiva?
Si tratta di integrare e re-inventare pratiche di empowerment, di avventurarsi in un territorio di ricerca, sperimentazione, che deve vedere alleate generazioni diverse.
Un punto saldo da cui possiamo partire, che ritorna e anima tutto questo libro, è l’attitudine hacker: quella curiosità, immaginazione, desiderio di gioco trasformativo di cui sono esperti i bambini, da cui non possiamo che imparare, da riscoprire e coltivare insieme.
Introduzione
Gli strumenti tecnici come esseri tecnici, partecipi dei meccanismi evolutivi. Dinamiche del potere tecnico: accumulato genera dominio, distribuito è presupposto di libertà possibili. L’alienazione tecnica oscilla in maniera schizofrenica fra tecnofilia e tecnofobia, eppure perde sempre di vista gli oggetti tecnici. L’attitudine hacker come pratica libertaria, rapporto alla pari con gli esseri tecnici, in cui non si obbedisce e non si comanda. Le regole del gioco della convivialità, o l’evoluzione del mutuo appoggio.
Esseri umani ed esseri tecnici
Gli strumenti tecnici sono l’ossatura del mondo umano. Gli strumenti tecnici digitali sono diventati anche centri nevralgici, veri e propri nervi, tendini, muscoli, riserve di energie e organi attivi del mondo intero. Grazie a essi, in maniera sempre più automatizzata, viene diretta la movimentazione delle infrastrutture logistiche globali, si combattono guerre, si allocano risorse nei luoghi reputati strategici, si giocano le partite finanziarie, si interviene nei flussi di comunicazione, si diffondono modelli comportamentali.
Macchine, computer, dispositivi elettronici, reti di comunicazione e così via giocano un ruolo sempre più fondamentale nelle interazioni psicosociali, politiche ed economiche in cui gli esseri umani sono immersi. Ma non sono solo strumenti utili ai nostri scopi. Sono qualcosa di più e di diverso: sono esseri tecnici dotati di caratteristiche proprie, peculiari, a prescindere da noi umani. Al pari degli altri esseri non umani che convivono su questo pianeta Terra, possono fare alcune cose e non possono farne altre; eccellono in alcune attività e sono carenti in altre; possono cooperare fra loro; si evolvono. Questi strumenti sono sottoposti agli stessi meccanismi evolutivi che regolano la co-evoluzione degli organismi viventi: l’adattamento (dalla funzione all’organo) e l’esattamento (dall’organo alla funzione).
Le piante non sono capaci di correre (anche se i semi possono volare, galleggiare…), ma sono capaci di effettuare la fotosintesi. Gli animali (alcuni) sono in grado di correre, altri nuotano o volano, o ancora fanno tutte e tre le cose insieme; ma non se la cavano bene con la fotosintesi. I microfoni collegati ai computer connessi in rete trasmettono i suoni che captano, ma non se la cavano bene con le addizioni. I fogli di calcolo possono calcolare in maniera soddisfacente, se adeguatamente programmati, ma non sono capaci di trasmettere video. Le telecamere in genere sì, sono in grado di trasmettere video, sempre che siano connesse a reti adatte. E così via, ognuno con le proprie caratteristiche. Con questi esseri tecnici siamo in relazione da molto tempo, proprio come siamo in relazione con protozoi, cromisti, funghi, piante e animali (tutti eucarioti come noi umani) e archeobatteri più batteri (procarioti), se accettiamo la tassonomia dei due super-regni e sette regni elaborata da un gruppo di scienziati che hanno raffinato le proposte dello zoologo britannico Thomas Cavalier-Smith nel 20151.
A differenza degli altri esseri citati, gli strumenti elettronici sono esseri non viventi. Ma, al pari degli esseri viventi, influenzano in maniera straordinaria le nostre vite umane. Così come ci preoccupiamo e ci prendiamo cura dell’aria che respiriamo, del cibo che mangiamo, dell’ambiente sociale e naturale in cui viviamo, sarebbe segno di saggezza pratica prenderci cura di questi esseri che fanno parte del nostro ambiente e lo determinano in maniera importante, perché sono fonte di grande potere. Ad esempio grazie a essi possiamo vedere a distanza, parlare a distanza, comunicare a distanza, ovvero: per mezzo delle relazioni che stabiliamo con gli esseri tecnici acquisiamo poteri straordinari.
Saltiamo alle conclusioni: sono potenziali alleati per costruire relazioni di mutuo appoggio. L’alternativa è semplice: se non ci aiutano a diffondere il loro potere per realizzare autogestione e abolire il principio del governo a tutti i livelli, allora sono strumenti di oppressione, individuale e collettiva. Il potere funziona così: o si accumula, e tende a strutturare gerarchie fisse che esercitano dominio dispotico; oppure si distribuisce per aumentare la libertà di tutti, di pari passo con la loro uguaglianza. Non esistono le vie di mezzo: anche perché la tecnica non è neutrale.
Genealogie e terminologie
Questo libro segue l’andamento dell’avventura, che è il farsi azione del pensiero. Appare quindi molto poco sistematico. L’effetto è voluto. Per questo si può leggere in un ordine diverso da quello proposto, perché i capitoli sono abbastanza autoconclusivi, anche se legati da rimandi per rendere l’argomentazione più solida. In particolare vi sono alcune espressioni ricorrenti. Cerco subito di chiarirle e inquadrarle, in particolare per chi ama avere un quadro di quel che segue con riferimenti autoriali.
Non sono un ammiratore dei concetti lisci e privi di appigli, soprattutto perché ogni termine e concetto appartiene a una stirpe, si porta dietro una genealogia, come ha ben mostrato Michel Foucault studiando la storia delle idee, e genera una serie di aspettative e precomprensioni. Preferisco cercare di osservare le situazioni, interrogando le esperienze concrete con uno spirito curioso, tentando di tradurre in maniera condivisibile ciò che accade nella complessità delle interazioni tecniche. Discuterne implica il ricorso a Übertragungen, trasposizioni arbitrarie, come Friedrich Nietzsche sosteneva fosse tutta la conoscenza in Su verità e menzogna in senso extra-morale, un testo del 1873 a mio parere fondamentale per qualsiasi tentativo di conoscere. Sono traduzioni metaforiche e allegoriche, senz’altro mai esaustive e con semplificazioni eccessive per chi è specialista, ma grazie alle quali si può effettuare un resoconto condiviso soddisfacente.
Questo modo di procedere è parte integrante della pedagogia hacker, una metodologia che sperimentiamo da anni con circe (Centro Internazionale di Ricerca per le Convivialità Elettriche). Di fronte alle difficoltà, alle fatiche, alle novità della vita nel mondo tecnologico contemporaneo, cerchiamo di fare un passo indietro e di osservarci, di osservare come agiamo e re-agiamo. Di imparare dalle nostre vulnerabilità, dalle reazioni emotive, dagli entusiasmi e dalle delusioni che spesso punteggiano i nostri rapporti con gli esseri tecnici. Computer, cellulari, automobili, elettrodomestici: amati e odiati, necessari e superflui. Questo approccio rielabora e meticcia diverse tradizioni, in particolare l’apprendimento esperienziale di David Boud, Ruth Cohen e David Walker (1993), i metodi d’azione di Jacob Levi Moreno (2007) e la pedagogia critica di Paulo Freire (2014). In questo senso, lungo tutto il testo, le storie raccontate sono altrettanti episodi di formazione insieme alle tecnologie; nel capitolo conclusivo raccolgo alcune indicazioni di metodo, riprendendo le questioni sorte nei capitoli precedenti. Ho chiamato attitudine hacker questo atteggiamento nei confronti delle tecnologie.
Un’attitudine si può imparare e insegnare; si assume, non è un fatto naturale, non è per nascita, per censo, per genetica, per investitura. Con hacker intendo un essere umano che, nelle sue azioni concrete, mira a ridurre l’alienazione tecnica, cioè il baratro che nel corso dell’evoluzione è stato scavato nei confronti degli esseri tecnici. Non si tratta quindi di mercenari al soldo di multinazionali, agenzie governative o altri deprecabili attori nel panorama della cosiddetta sicurezza, ma di persone amanti delle tecnologie, della riservatezza (privacy), intenzionate a conoscere e comprendere gli esseri tecnici per vivere armoniosamente e piacevolmente insieme. L’hacker perciò non ha a che fare solo con i computer, ma con qualsiasi essere tecnico.
A mio avviso, l’allontanamento da questi esseri artificiali è principalmente dovuto a un duplice movimento di delega cieca nei confronti degli esperti e, da parte di questi ultimi, di strutturazione in caste gerarchizzate al servizio del retaggio del dominio. Nel capitolo primo viene descritta l’emersione della tecnoburocrazia organizzata a partire da semplici meccanismi di delega, più evidenti quando gli esseri tecnici abbisognano di riparazioni a causa di guasti.
L’articolazione delle tecnologie contemporanee in reti di esseri tecnici viene analizzata nel capitolo secondo, esplorando la rete di Internet dal punto di vista della sua costituzione materiale e dei meccanismi di interazione basica, che rivelano immediatamente la straordinaria complessità di quelle che, a prima vista, sembrano operazioni banali. Attingo a piene mani dall’idea di saperi situati (situated knowledges) di Donna Haraway, fin dall’articolo del 1988 Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Estendo questa idea del privilegio della prospettiva parziale, della corporeità e del sapere come prospettiva condivisa a una comunità (cui preferisco i gruppi di affinità), in special modo al sapere tecnico che si genera navigando la rete di Internet. I corpi degli esseri tecnici sono in gioco tanto quanto i corpi umani, e così pure le rispettive, parziali prospettive. Non è possibile bagnarsi due volte nello stesso fiume, diceva Eraclito; nemmeno navigare due volte nella stessa Internet: mutiamo noi, muta l’ambiente circostante, mutano i dispositivi.
Con tecnologie intendo l’incarnazione concreta, materiale, tangibile di teorie e procedure che sono dei modi di fare, modi di costruire, ovvero tecniche. Un dispositivo elettronico portatile, ad esempio uno smartphone equipaggiato con un sistema operativo Android, è quindi un oggetto tecnologico, frutto di specifiche tecniche (produttive, organizzative); queste tecniche sono ispirate da specifiche ideologie, convinzioni, credenze. In questo senso la tecnica non è, e non può essere, neutrale: le sue concretizzazioni tecnologiche incorporano sempre visioni del mondo situate, parziali, definite storicamente, socialmente e psicologicamente. Inoltre, tendono a far nascere ulteriori generazioni di tecnologie (e di umani che dicono di servirsene) che agiscono e re-agiscono in maniera poco consapevole, determinata in maniera preponderante dall’orientamento tecnico sottostante. Di fatto, le macchine, proprio come gli umani, non sono tutte uguali: dipende da come vengono «create al mondo».
Quelli che vengono solitamente rubricati come oggetti tecnologici o strumenti tecnologici sono qui chiamati esseri tecnici. Sostengo che, poiché questi esseri coabitano con altri esseri viventi e non sul pianeta Terra, e sono frutto delle loro interazioni tecniche, ne condividono le dinamiche evolutive di base, ossia adattamento (dalla funzione all’organo) ed esattamento (dall’organo alla funzione). I meccanismi di esattamento sono stati descritti in primo luogo da Stephen J. Gould ed Elizabeth Vrba, raffinando il concetto di preadattamento già formulato da Darwin. Dal momento che gli esseri tecnici sono fonte di potere, a seconda di come il potere viene concepito e gestito dalle teorie sottostanti alla loro costruzione si otterranno diversi retaggi evolutivi, presentati nel capitolo terzo. Rifacendomi a Murray Bookchin, distinguo tra retaggio della libertà e retaggio del dominio. In quest’ultimo lignaggio, storicamente maggioritario e attualmente predominante, gli esseri tecnici vengono cooptati per realizzare le fantasie di dominio umane, e integrati come ingranaggi di meccanismi di comando/obbedienza reciproci. In particolare, gli esattamenti tossici di massa (di cui i social network commerciali sono un buone esempio) selezionano attivamente esseri tecnici ed esseri umani che strutturano le Megamacchine contemporanee, co-evoluzioni gerarchizzate di esseri al servizio della brama di supremazia. Il retaggio della libertà è storicamente minoritario e oggi in grave difficoltà: in queste linee evolutive, gli esseri tecnici vengono concepiti e realizzati nell’ottica del mutuo appoggio, per ampliare la libertà nell’uguaglianza reciproca; gli esseri umani selezionano attivamente comportamenti appropriati in tal senso.
Da qui discendono quelle che chiamo tecnologie conviviali, rifacendomi all’espressione di Ivan Illich, ma adattandola alla dimensione della rete. Nelle reti digitali globali la questione della scala, della dicotomia industriale/conviviale e della prossimità va rivista in maniera non dogmatica, consapevole della materialità e delle dinamiche interattive concrete. Allo stesso modo, i limiti e i correttivi da porre all’evoluzione tecnica non possono essere calati dall’alto di una teoria cristallina, ma devono nascere da un corpo a corpo quotidiano, comune e condiviso con gli esseri tecnici, per selezionare e selezionarci reciprocamente, per affinità, organizzando sistemi federati (capitolo quarto).
Nel capitolo quinto propongo un’analisi dell’evoluzione di una tecnologia complessa, il denaro, evidenziando l’approfondirsi e aggravarsi dell’alienazione tecnica attraverso la ricostruzione genealogica di alcuni dispositivi di pagamento (l’analisi completa è riportata fra i materiali di approfondimento all’indirizzo tc.eleuthera.it). Un carattere chiave del retaggio del dominio è l’ossessione per la riduzione della frizione (frictionless) e dell’attrito tramite intermediazione tecnica. Ma integrare gli esseri tecnici in maniera che non si scorga alcuna soluzione di continuità con l’umano (seamless) è una chimera pericolosa che in realtà serve per nascondere le transazioni di potere sottostanti e le continue deleghe ai meccanismi tecnoburocratici; una catena senza fine in cui tutto si tiene, ovvero l’incarnazione contemporanea della Megamacchina descritta magistralmente da Lewis Mumford.
Il capitolo sesto cerca di fare il punto sulla filosofia della tecnica senza addentrarmi in discussioni specialistiche. Si tratta delle teorie implicite, sottostanti alla tecnica e quindi alla realizzazione degli esseri tecnici, sempre presenti anche e soprattutto quando non dichiarate. Sostengo che la filosofia si è occupata molto di tecnica e tecnologia, ma paradossalmente senza saperne granché, senza sporcarsi le mani con gli esseri tecnici. La maggior parte delle filosofie della tecnica si possono ricondurre alle concezioni antropologiche della tecnica, secondo cui l’umano è al centro, attore protagonista, e gli oggetti tecnici sono meri supporti delle sue azioni. Ad esempio, l’analisi del sistema tecnico di Jacques Ellul appartiene senz’altro alle concezioni antropologiche e, infatti, non presenta alcuna via d’uscita operativa, a parte il rifiuto totale di quello che viene descritto come sistema anche se, in realtà, è davvero ben poco sistematico. Oppure, le filosofie della tecnica si rifanno più o meno esplicitamente alla concezione heideggeriana della Tecnica come Gestell, come scaffalatura, sfondo e destino della contemporaneità, proliferazione di dispositivi che dispone il mondo in un certo modo. La Tecnica diventa così un paio di occhiali di cui non siamo davvero consapevoli, e quel che è peggio è che anche questa volta l’oggetto tecnico viene di fatto accantonato, le sue caratteristiche specifiche non vengono studiate perché l’essenza della tecnica viene considerata non tecnica. Le argomentazioni perentorie e apodittiche di un pensatore come Byung-Chul Han rientrano in questo lignaggio di pensiero. Forse si può recuperare parte dell’analisi di Hans Jonas, quanto meno il suo lucido e dichiarato rifiuto sia dell’assoluta negatività del principio disperazione di Günther Anders, sia dell’assoluta positività del principio speranza di Ernst Bloch. Ma il suo principio responsabilità non mi pare sufficientemente operativo nel mondo tecnologico. Anche Jonas aveva poco a che fare con gli esseri tecnici. Propongo quindi di riprendere lo studio di Gilbert Simondon rispetto alla possibilità di costruire macchine aperte, aperte alla possibilità di liberazione, per quanto sia necessario aggiornare le sue intuizioni all’epoca digitale.
L’ultimo capitolo e la conclusione delineano alcune linee guida per sviluppare tecnologie conviviali, di liberazione reciproca per tutti gli esseri coinvolti, a partire dalla consapevolezza che non esiste una natura umana immutabile, né alcuna altra natura immutabile, e nemmeno una natura tecnica. Esistono composizioni transitorie, alleanze possibili, simbiosi immaginabili e già operative per rimanere nella turbolenza della co-evoluzione, non solo con gli altri esseri viventi non umani, come ha ben raccontato Haraway nei saggi raccolti in Staying with the Trouble, ma anche con gli esseri tecnici. In termini di retaggio della libertà, finché c’è spazio per un’evoluzione, sarà possibile operare in maniera altra rispetto al principio del governo, basato sulla coppia comando/obbedienza, e diffondere potere, anche potere tecnico, per costruire spazi di mutuo appoggio.
Alla bibliografia è stata aggiunta, tra i materiali online, una raccolta di servizi esistenti che mostrano come il retaggio della libertà sia vivo e vegeto anche nel mondo tecnologico. Si tratta di diffondere, moltiplicare e meticciare fra loro i margini di libertà già operativi, nell’ottica di quello che Colin Ward chiamava anarchia come organizzazione. La libertà, come ci ricorda Tomás Ibáñez, non è, ma accade. La libertà non è una sostanza singolare assoluta ma vive nella molteplicità delle sue libere manifestazioni, dei processi plurali di liberazione, relativi.
Strumenti e potere
Un uomo. Una pistola. La sua pistola.
Un uomo. Un’auto. La sua auto.
Un uomo. Un computer. Il suo computer.
In queste formulazioni, i primi possiedono i secondi, subordinati. Il possesso e l’uso dello strumento tende a strutturare, quasi a determinare automaticamente, una relazione asimmetrica. L’essere umano possiede l’essere tecnico, lo ha in pugno, lo comanda; eppure, nel concreto ne è a sua volta posseduto, comandato, determinato, anzi persino definito nella sua identità. Le parole non mentono, si dice infatti: pistolero, automobilista… computerista? (no, ma nei corsi di sicurezza sul lavoro si trova il videoterminalista, cioè l’umano che passa molto tempo al videoterminale).
Che tipo di relazione asimmetrica è? Di dominio/sottomissione, di reciproco comando/obbedienza. Si domina, e si è dominati, alternativamente, ma senza che sia stata esplicitamente negoziata alcuna regola, o norma di comportamento cui attenersi.
Gli strumenti tecnici sono al tempo stesso vittime e carnefici della smania di dominio degli esseri umani, in particolare della parte maschile degli Homo Sapiens. Vittime, perché nessuna pistola, auto, computer o altro aggeggio ha scelto volontariamente di sottomettersi ai capricci di qualche umano sbalestrato: non ha scelto di sparare, accelerare, calcolare senza costrutto. Carnefici, perché in definitiva le pistole, le auto, i computer e molti altri aggeggi tengono in pugno coloro che le impugnano, le guidano, li comandano; ovvero i loro proprietari.
A maggior ragione dominano il resto del mondo circostante, vivente e non; da cui la sensazione diffusa (ma piuttosto vaga) di un mondo dominato dalla Tecnica, qualsiasi cosa voglia dire. In prima approssimazione, possiamo definirla come un sentimento di lontananza, separazione e alterità rispetto alle manifestazioni tecniche, che però contemporaneamente esercitano un’attrazione straordinaria sugli umani. Incarnazioni mostruose del potere tecnico, spaventose ma affascinanti, gli esseri tecnici sono spesso percepiti dagli umani in maniera schizofrenica, oscillanti fra brama tecnofila e salvifica (la tecnologia ci salverà!) e avversione tecnofoba, millenarista (la tecnologia ci dannerà!). Siamo quindi di fronte a una sorta di alienazione tecnica. Come sosteneva il filosofo francese Gilbert Simondon, opponendosi alla limitata comprensione di Marx, l’alienazione tecnica è fisiologica, psicologica e sociale prima che economica. Riguarda innanzitutto i corpi, le menti, le interazioni sociali.
Certamente anche le donne possono ugualmente invischiarsi in simili relazioni di reciproco dominio, ma è interessante notare che nell’epoca moderna la macchina viene raffigurata come femmina, e, sottinteso patriarcale, logica vuole che debba essere dom(in)ata, tendenzialmente da un maschio. Anzi, sarà proprio quella compiuta sottomissione, che stabilisce i reciproci ruoli in una gerarchia da riprodurre senza posa, a farne un vero uomo: così raccontano un numero straordinario di film, romanzi, canzoni, videogiochi. Una macchina da comandare è un po’ come una donna da sottomettere (che, a sua volta, nel discorso colonialista rimanda alla Natura Selvaggia da soggiogare): la pubblicità, vero Cavallo di Troia del capitalismo, ha sempre sfruttato questa becera equazione per vendere qualsiasi cosa.
La macchina come incarnazione mostruosa, ovvero al tempo stesso affascinante e orrenda, si presenta spesso anche come capro espiatorio ideale, ricettacolo di tutte le iniquità. In questo tipo di narrazioni lo Stato controlla i suoi cittadini grazie alle Macchine del Controllo; lo stesso fanno le Multinazionali e, in definitiva, le persone stesse fra loro, grazie agli straordinari poteri degli strumenti tecnici: ad esempio, parlarsi e vedersi a distanza e, più in generale, estendere senza limiti il proprio raggio d’azione. Così il mito della Macchina da Dominare (per creare un Mondo Nuovo) si ribalta nel mito della Macchina da Distruggere (per tornare al Mondo Antico), ma in fondo cambia poco: la possibilità di ricreazione del mondo è subordinata in ogni caso all’affermazione incontrastata dell’umano, come Padrone o Distruttore della macchine.
Attitudine hacker come pratica libertaria
Ma a noi hacker piacciono le macchine, e non per sottometterle. Non vogliamo governarle, ma nemmeno vogliamo essere governati dalle macchine. Ci piace averci a che fare, capire come funzionano, modificarle, risolvere problemi assurdi, imparare insieme, dare forma alle fantasie più sfrenate, costruire mondi impensabili e così via. Impossibile vivere in questo mondo senza macchine. Saremmo più tristi e più soli. Eppure anche noi hacker abbiamo i nostri scheletri nell’armadio, o meglio, nel terminale.
Infatti usiamo la cli invece della gui, cioè la Command Line Interface invece della Grafical User Interface. In parole povere, comandiamo i computer con la riga di comando, invece che con le finestre grafiche. La ragione è semplice: la riga di comando è molto, molto più potente di qualsiasi altro modo di relazionarsi alle macchine elettroniche. Nelle nostre formazioni con circe facciamo spesso un giochino per dimostrarlo agli increduli: distruggiamo il nostro sito web con un comando in meno di un secondo, per farlo ricomparire al suo posto un attimo dopo. Una pura e semplice esibizione di… potere, mormora qualcuno.
Sì. Potere. Questo libro parla esattamente del potere, di come gli strumenti in generale siano fonte di potere, e in particolare gli strumenti elettronici che nel xxi secolo vanno sotto il nome collettivo di «tecnologie digitali», anche se si tratta di apparecchi molto diversi fra loro. Parla di come possiamo non solo immaginare, ma anche concretamente operare in modo che il potere possa essere esercitato in maniera diversa. Per fare ricreazione, costruire spazi dove può fiorire il mutuo appoggio.
Non è per niente facile. Non è come fare i giochi di prestigio per far strabuzzare gli occhi. Richiede pazienza, buona volontà, energia, fatica e anche un pizzico di incoscienza. O di leggerezza, spensieratezza, allegrezza sbarazzina. Non ci si può prendere troppo sul serio, altrimenti diventa un lavoro, un travaglio penoso, e la vita è troppo breve per perdersi in simili baggianate.
Il fatto che non vogliamo ignorare è che il potere è lì, in mezzo a noi. Ci interessa, anche letteralmente: è ciò che inter-est, sta-tra noi considerati come individui singoli, umani e non. Questo libro è una cavalcata nelle terre delle relazioni possibili con le libere macchine.
Il presupposto è chiaro: il potere non è una cosa brutta; il potere non è una cosa cattiva. Anzi: il potere è ciò che vogliamo, il più possibile, perché sia diffuso e distribuito il più ampiamente possibile, idealmente a tutti. Questo perché adottiamo la definizione proposta da Amedeo Bertolo nei primi anni Ottanta del xx secolo, secondo cui il potere è una funzione regolativa sociale, di per sé neutra, che esercitiamo sempre quando ci troviamo in relazione con qualcun altro. Nell’articolo Potere, autorità, dominio: una proposta di definizione, pubblicato sul secondo numero della rivista «Volontà» (1983), sosteneva che il potere serve alla produzione e applicazione di norme che regolano i rapporti fra gli esseri in società: non solo gli esseri umani, ma anche gli altri esseri viventi. Estendo la riflessione agli esseri non viventi, come è il caso degli esseri tecnici di cui ci interessiamo qui.
L’accesso al potere è la precondizione chiave di ogni possibile libertà. Senza potere, cioè senza possibilità di intervenire nella produzione e nell’applicazione di norme, non esiste libertà. In teoria, una volta che il potere è uguale fra tutti, il primo passo è fatto. Rimane il secondo, che è un passo ancora più lungo e difficile, cioè fare in modo che non ci si opprima a vicenda, cosa che come abbiamo visto accade regolarmente nelle «normali» relazioni con gli strumenti tecnici, ridotti a oggetti da possedere.
In linea di principio, per impedire che questo accada, è necessario evitare di obbedire ai comandi, ed evitare di impartirli. Il dominio infatti si stabilisce in questo modo: obbedendo, cioè attenendosi a norme stabilite da qualcun altro (tipicamente una minoranza, ma potrebbe anche essere una maggioranza oppressiva) ed espresse sotto forma di comando. O, viceversa, creando e applicando norme in maniera coercitiva: comandando. Insomma, quando il potere viene esercitato da un settore dominante, non è più neutro, ma diventa dominio. Tomás Ibáñez elabora questo concetto in L’anarchia del mondo contemporaneo.
Il dominio non è sinonimo di potere, lo Stato non coincide con il dominio. Potentia è la capacità implicita di condizionare l’ambiente in cui si vive con la sola nostra presenza; potestas è un condizionamento esplicito – nei suoi diversi gradi – esercitato sull’esistenza di altri umani, che dunque devono sempre mantenere un margine di autonomia affinché il potere possa in esso agire; dominio è il dissolvimento di tale margine nell’assenza della libertà. Si può esercitare potere soltanto su persone ancora libere, si pratica il dominio dove ogni libertà è scomparsa2.
Va sottolineato che gli individui umani sono in grado di praticare l’obbedienza, così come il comando, non solo nei confronti di altri umani, ma anche nei confronti di sé stessi. Questo è un aspetto fondamentale della relazione fra esseri umani ed esseri tecnici: spesso si esegue ancora e ancora una procedura automatizzata perché essa soddisfa profondamente la propria ansia di obbedire a sé stessi, di essere conformi, aderenti a sé. Il digitale diventa allora un elemento di costruzione e rassicurazione identitaria. Chi studia i sistemi per aumentare il livello di coinvolgimento degli utenti sulle piattaforme digitali di massa lo sa bene, e ne approfitta per i suoi scopi di lucro.
In che modo gli hacker, che si relazionano con i computer tramite cli, potrebbero aiutarci a concepire e praticare relazioni di libertà reciproca nell’uguaglianza, relazioni in cui il potere è di tutti e di ciascuno, in cui non è dominio oppressivo ma anzi relazione conviviale? La prima idea che viene in mente è: sottomettendo le macchine per il bene di tutti gli esseri umani. Ma così non può funzionare, perché in nessun caso la sottomissione al comando di qualcuno genera la libertà degli altri. Non funziona con gli umani, non funziona con gli animali, con le piante o con qualunque altro essere vivente: l’estensione del dominio restringe i margini di libertà tanto di chi esercita il comando quanto di chi obbedisce. E nemmeno funziona con le macchine.
Perciò a conti fatti esiste una sola possibilità, meno teorica di quanto potrebbe sembrare a prima vista: liberare gli esseri umani insieme a tutti gli altri esseri che convivono su questo pianeta, appoggiandosi allo straordinario potere delle macchine.
L’ipotetico uomo di cui sopra, capace di relazionarsi con una pistola, un’automobile, un computer, ha più potere di un uomo incapace di farlo. L’immagine è grossolana, ma come punto di partenza ci si può accontentare. La questione è come esercitare questo potere in maniera che si diffonda e soffochi sul nascere le tentazioni di dominio, o quanto meno le renda più difficili da mettere in pratica. Inoltre, l’esercizio di questo potere deve aiutarci a dissolvere la tecnocrazia, nelle molte situazioni in cui una gerarchia fissa e dispotica si è già costituita, retta da catene semi-automatiche di comando/obbedienza e organizzata in procedure burocratiche.
L’ipotesi da verificare è che nelle interazioni tecniche, in particolare con macchine digitali, le dinamiche di potere, cioè di produzione e applicazione di norme condivise, siano più evidenti che altrove. Sarà allora possibile andare più a fondo rispetto a interazioni non mediate da esseri tecnici. In particolare, una volta chiarito «come funziona» l’interazione, sarà possibile esplorare in ogni direzione, e quindi escogitare contromisure per limitare, anzi impedire l’accumulo di potere, l’emersione di gerarchie e di sistemi di dominio. Al tempo stesso, queste contromisure dovranno dimostrarsi efficaci nell’operare sottrazioni significative ai sistemi di dominio esistenti, specialmente attraverso diserzioni non velleitarie rispetto alle gerarchie vigenti. In sintesi, dovranno aiutarci a immaginare come diffondere modalità di relazione libertarie, che tendono all’anarchia.
La cli è semplice e brutale, senza mezzi termini. L’interfaccia grafica intorno serve solo a indorare la pillola; la riga di comando invece ci ricorda che sotto la scocca risuonano gli ordini, sembra schioccare la frusta. Al di là di questa prima impressione, il comando possibile con la command line è tutto sommato piuttosto equo, nel senso che assomiglia a un’autorevole richiesta formulata in maniera adeguata. L’operatore umano deve avere un’idea chiara di quel che digita. Il sistema non eseguirà comandi mal formulati; probabilmente restituirà un errore. Ciò significa che la forza bruta, l’imperio, la minaccia, la sopraffazione, il timore tipicamente associati al comando sono inutili. Per averci a che fare bisogna fare un certo sforzo, imparare; sbagliare e riprovare.
Anche perché, a differenza di altre interfacce di più alto livello, come le interfacce grafiche (finestre e simili), le righe di comando sono tendenzialmente parche ed essenziali. Ogni dettaglio è significativo, nulla di superfluo. Non proteggono da errori banali: presuppongono un certo grado di competenza. Se l’operatore copia e incolla comandi di cui non comprende il significato, il sistema potrebbe eseguirli e fare tutt’altro rispetto a ciò che l’operatore immaginava o desiderava. Distruggere, cancellare, invece di copiare!
Per poter avere a che fare con la riga di comando bisogna studiare, almeno un poco. Fare un po’ di fatica, applicarsi. Inoltre, chiedere a chi ne sa di più, a chi ha già fatto esperienza e può aiutarci, implica imparare a selezionare le persone di cui fidarsi e tessere una rete di fiducia, invece di affidarsi ciecamente agli esperti.
L’alternativa è ficcare la testa sotto la sabbia e lasciare che se ne occupi qualcun altro, tipicamente un essere tecnico gestito da sedicenti esperti. O una rete, anzi una catena di esseri tecnici, incatenati fra loro, ingranaggi di un sistema più vasto insieme agli esseri umani che pretendono di comandarli, dominati da procedure assurde dettate da legislazioni astruse, perlopiù dalla parte dei poteri costituiti: il sistema tecnocratico e tecnoburocratico che si estende fino a diventare Megamacchina globale, in cui tutto si tiene, ognuno obbedisce perché comanda e viceversa.
Non ci sono ricette magiche, né trucchi per imbrogliare le carte. L’apprendistato non può che essere lungo, e di necessità sempre incompleto. Ma è un gioco che vale la pena di giocare.
Le regole del gioco
Come distinguere le interazioni «giuste» da quelle «sbagliate»? La legalità giuridica non funziona affatto, perché dipende dagli Stati, dalle leggi e da tutti i loro rappresentanti (forze poliziesche, avvocati, giudici e così via). Ciò che risponde a criteri di correttezza giuridica non corrisponde a quello che si può fare con gli strumenti, cioè non discende dalla legittimità tecnica. Nel digitale è del tutto evidente: ad esempio, in alcuni paesi è lecito craccare i programmi informatici, in molti altri (fra cui l’Italia) è un reato penale, se viola il copyright. Altri parametri, come quello etico (è buono?) o estetico (è bello?) risultano poco efficaci, troppo vaghi e soggetti all’arbitrio ben chiarito dal detto de gustibus non disputandum est.
Non ho trovato molte fonti autorevoli per orientarmi. Il classico Tools for Conviviality di Ivan Illich (tradotto in italiano come La convivialità) rimane imprescindibile, ma teorico; soprattutto, propone l’ideale dell’uomo austero che non mi soddisfa, così in odore di pauperismo e di sottomissione a un principio trascendente. D’altra parte le compilazioni sulle tecnologie conviviali tendono a essere assai specialistiche (ad esempio si interessano alle tecniche costruttive a tutti i livelli, in particolare fai-da-te) o decisamente troppo astratte; risultano comunque obsolete rispetto alle apparecchiature elettroniche diffuse nel primo ventennio del xxi secolo e, in definitiva, troppo inclini a creare liste e tassonomie, a cercare di menzionare ogni possibile contenuto/oggetto/strumento, ma relativamente poco attente al metodo. Invece, il metodo è parte del contenuto. Sono andato quindi in cerca di un metodo per raccontare le nuove tecnologie per la convivialità.
Un aiuto inaspettato è venuto da Murray Bookchin, che nell’introduzione a L’ecologia della libertà chiarisce:
Questo libro si focalizza su alcune idee generali che si sviluppano secondo l’andamento erratico e occasionale proprio al pensiero organico piuttosto che secondo modalità strettamente analitiche3.
Non condivido completamente l’approccio di Bookchin e in ogni caso l’obiettivo di questo scritto è molto più modesto rispetto alla sua monumentale trattazione; ma mi convince la sua critica del procedere gerarchico insito nell’approccio analitico. Non è sempre vero, ma spesso nella mia esperienza di lettore mi lascia insoddisfatto la rigidità di gran parte delle strutture logiche tipiche degli accademici. Si presentano come fossero teorie lisce e levigate, senza punti d’appiglio se non quelli codificati e previsti (espressi secondo codici arcani per i non iniziati); perciò non lasciano spazio al dialogo con il lettore non specialistico. Risultano calati dall’alto di una gerarchia incancrenita e, al pari di tanta parte della produzione saggistica, mi sembrano davvero «pappette predigerite», eppure indigeste. Spesso trovo articoli e saggi estremamente puntigliosi, eppure, in definitiva, con una densità concettuale minima. Tendono a girare intorno a poche idee, annacquate in una quantità spaventosa di dati, citazioni e riferimenti, che servono per aumentare l’impact factor, cioè il valore di quel testo sul mercato della ricerca.
Mi è stato fatto notare che le trattazioni accademiche non sono necessariamente la sentina di ogni vizio, e che ci sono ben altri ambiti di spreco e corruzione al di là dell’università. Certo, è vero. Ma non mi stupisco se l’idiozia e il conformismo vengono alimentati da militari guerrafondai, politici corrotti, funzionari incompetenti o industriali avidi. Invece mi sconforta che troppi fra coloro che ricercano e studiano per mestiere abbiano contribuito, volenti o nolenti, alla crisi generalizzata di questi tempi. Con i loro complicati studi non hanno saputo arginare l’irrazionalismo montante e hanno anzi soffiato sul fuoco delle contrapposizioni identitarie.
Così, invece di cercare di distillare concetti granitici da una riflessione per forza di cose piuttosto ombelicale, ho pensato di lasciare spazio in primo luogo all’esperienza, per poi cercare di sintetizzare delle linee guida. Non per vana aneddotica, ma perché ritengo che un approccio in parte autoetnografico possa rivelarsi più adeguato a questa ricerca. Dopotutto non sono l’unico umano che ha a che fare con questi esseri tecnici: più che discettare in astratto, mi piace descrivere le situazioni concrete in cui altri potrebbero riconoscersi, e quindi contribuire a ridurre la diffusissima alienazione tecnica.
Mi piacerebbe anche ispirarmi agli straordinari dialoghi di Errico Malatesta in Al caffè: discutendo di rivoluzione e anarchia, ma non ho le idee così chiare da poter mettere in scena dei personaggi riconoscibili. Saranno dunque piuttosto stereotipati, o tratti da resoconti di fatti realmente avvenuti. In ogni caso, passando dalla pratica alla teoria, senza pretese sistematiche, cercherò di limitare la frammentarietà ritornando frequentemente ad alcuni punti saldi, concetti, autori.
Il potere come funzione regolativa sociale è già stato enunciato. La fiaccola dell’anarchia anche, e rimane un faro guida. Un altro è la convivialità. Pur mantenendo un certo grado di vaghezza e un sapore forse eccessivamente classico, carico dei tanti significati di una lunga storia, presenta alcune caratteristiche interessanti.
La convivialità è dinamica, plurale e mutevole. Il convivio, l’antico simposio, è infatti una cena, un pranzo insieme, un banchetto. Gli argomenti affrontati in questo libro e le indicazioni di metodo che ne derivano sono gli ingredienti grezzi da miscelare per creare convivialità; in alcuni casi sono anche le pietanze già cucinate e raffinate, le modalità di preparazione delle ricette, i consigli per ottenere risultati più appetitosi, presentarli, apparecchiarli e gustarli. Non mancheranno le avvertenze riguardo ai possibili rischi di accostamenti decisamente infelici, o potenzialmente dannosi, così come suggerimenti per lanciare la fantasia a briglia sciolta e immaginare combinazioni inedite.
La convivialità non è il caos in cui ciascuno fa quel che gli pare, né l’ordine in cui ogni interazione è prescritta e decisa in anticipo da un rigido programma in esecuzione. Il banchetto riuscito è un’armonia senza padroni e senza servi, in cui non si obbedisce né si comanda. Ma non è una semplice via di mezzo tra il dominio e la sottomissione: al contrario, è un percorso accidentato, perché si confronta non solo con le influenze reciproche fra esseri umani, ma anche, nel caso di interazioni mediate dalla tecnologia, con i poteri derivanti dagli esseri tecnici, che bisogna imparare a gestire.
Bisogna darsi delle regole di buona ricreazione, organizzare per bene, altrimenti va tutto in malora: senza organizzazione, c’è troppa poca varietà. Capita allora, nel caos disorganizzato, nell’anomia, che tutti hanno portato del vino, nessuno da mangiare; capita che c’è troppo di questo e poco di quell’altro; non tutti trovano posto, non si trovano gli utensili per distribuire le vivande, abbandonate senza riguardo; magari si manifesta l’ubriachezza molesta, esplode l’aggressività, i timidi si rifugiano sotto il tavolo mentre sopra si viene alle mani. Siccome ognuno ha le sue idiosincrasie, i suoi demoni da seguire o meno, è il caso di ascoltare gli altri, e di imparare ad ascoltarsi, insieme. Ci vuole buona disposizione d’animo, ovvero una certa grazia.
Di certo un convivio non si fa in solitudine: per creare convivialità si deve perciò tener conto delle sensibilità di chi partecipa. Oltre ai poteri, c’è da confrontarsi con le vulnerabilità che inevitabilmente risultano più evidenti, perché in pubblico, fra un boccone e un bicchiere, in una chiacchiera, in uno scambio, ci si confida, ci si lascia un po’ andare, si allentano le maschere della commedia quotidiana ed emerge con nettezza il carattere di chi partecipa. Vulnerabilità va inteso nel senso di sensibilità specifica, di cui prendersi cura; non nel senso di debolezza, da guarire in ossequio a una norma prestabilita. C’è chi non sopporta il peperoncino e chi ne vuole molto di più. Chi adora la cipolla al punto da ficcarla ovunque. Chi rifugge l’aglio, chi non digerisce il glutine.
C’è anche chi ha fatto un passo in più e ha imparato a convivere con le proprie vulnerabilità, associando un piatto a un altro, allungando una cottura, aggiungendo spezie diverse in momenti adeguati: evitando quindi di indulgere in un certo comportamento e privilegiandone altri. Gli esseri tecnici possono aiutarci a mettere a nudo e quindi ad affrontare le vulnerabilità degli esseri umani: dopotutto, sono stati creati per potenziarli, ovvero per cavarli d’impaccio e rimediare alle loro debolezze. Ma anche e soprattutto per divertire, stupire, provocare meraviglia.
Nei momenti conviviali le chiacchiere possono fissarsi in racconti e storie. Per questo di tanto in tanto ho inserito una storia capace di mostrare le qualità degli strumenti qui raccontati.
Questa non è un’enciclopedia completa né una trattazione esaustiva: è un piccolo assaggio, assolutamente di parte, degli strumenti, delle tecniche e delle metodologie per la convivialità che popolano questo pianeta e convivono con gli umani in questo scorcio di xxi secolo. Ce ne sono senz’altro altri. A chi legge il compito di trovarli, prendersene cura e diffondere quel che hanno imparato.
Senza illusioni e senza rimpianti.
Note all’Introduzione
1. Tassonomie e classificazioni sono sempre temporanee, oggetto di revisioni continue. Le specie si evolvono, i confini fra esse sono labili e le conoscenze in merito mai fissate una volta per tutte. Il modello a cui faccio riferimento è liberamente accessibile online.
2. Tomás Ibáñez, L’anarchia del mondo contemporaneo, elèuthera, Milano, 2022, p. 142.
3. Murray Bookchin, L’ecologia della libertà, elèuthera, Milano, 2017, p. 42.
capitolo primo
Esperti
Gli esperti sono la manodopera essenziale per strutturare i sistemi tecnocratici e, quindi, anche per dissolverli. L’emergenza della gerarchia tecnica delineata attraverso storie di quotidiana tecnocrazia, dagli elettrodomestici agli elettronici: la lavatrice di Giovanna, l’iPhone di Luca. Esperti delle fogne: reti di esseri umani ed esseri tecnici svelano le relazioni di potere. Ingredienti conviviali: curiosità, condivisione, traduzione.
I «miei» strumenti? Possesso e tecnocrazia
Ci sono tanti modi per raccontare il rapporto fra gli esseri umani e gli esseri tecnici. Di solito, gli aggettivi possessivi fanno la parte del leone: si discorre di come gli umani usino bene o male i propri strumenti, gli oggetti e apparecchi che sono di loro proprietà. Le mie macchine, le macchine che lavorano per me, le macchine che non funzionano a dovere e non mi servono.
Cerchiamo invece di cambiare radicalmente prospettiva. Dobbiamo cercare di svincolarci dal nostro punto di vista. Solo così potremo vedere più chiaramente come si manifesta il potere, in che modo fluisce e come tende a strutturare relazioni basate sulla coppia comando/obbedienza, dominio/sottomissione. E imparare ad agire il potere senza esserne agiti, a diffonderlo per ampliare i margini di reciproca libertà invece di accumularlo fino a rimanerne schiacciati.
C’era una volta una lavatrice. Se la cavava bene, con i suoi diversi programmi svolgeva un ottimo lavoro, nessuno se ne era mai lamentato. Ma un brutto giorno qualcosa andò storto. Giovanna, la sua padrona, trovò il bagno allagato, e se la prese con lei, imprecando e pestandola sul cofano, chiamandola stupida macchina. Che fare? Giovanna era abituata a rimboccarsi le maniche. Dopo averla spostata a fatica, scoprì carponi che il tubo di scarico era danneggiato. Urgeva sostituzione.
Il grande magazzino di fai-da-te sciorinava un’intera corsia dedicata all’idraulica. Di tubi ce n’erano parecchi. Ne prese uno, sembrava identico a quello della sua lavatrice, ma alla prova dei fatti la guarnizione non teneva, o forse era un problema della giuntura. Tubo alla mano, tornò al fai-da-te: un primo commesso gentile cui si era rivolta le chiese il modello della lavatrice, ma siccome lei non ne era sicura, la indirizzò a un secondo commesso, l’esperto di idraulica. Questo prese a pontificare sul fatto che è importante badare ai dettagli per scegliere il ricambio giusto, sulla differenza abissale fra tubi con giunti da 3/8 rispetto al mezzo pollice, specificando che i filetti ottonati sono migliori di quelli di plastica, e naturalmente la canapa è meglio del teflon; di fronte all’indifferenza di Giovanna, che cominciava a scocciarsi di quella predica, borbottò un paio di osservazioni sulla nota incapacità strutturale delle donne nell’occuparsi di apparecchi tecnici. Maschilista oltre che noioso, pensò Giovanna, ma frenò la lingua. Le serviva che sistemasse il guasto.
Fortuna che il secondo tubo sembrava adatto. La sua lavatrice poteva tornare al lavoro! Almeno per il momento era scongiurato il rischio di lavarsi i panni a mano, o di dover ricorrere alla prima lavanderia automatica nelle vicinanze di casa.
In questa breve storia compaiono alcuni personaggi chiave della narrazione tecnocratica. In primo luogo, i comuni mortali, rappresentati da Giovanna. Sono umani caratterizzati da una dipendenza strutturale nei confronti degli strumenti tecnologici. Questi strumenti costituiscono il secondo anello della catena: sono rappresentati come servi, supporti utili o addirittura necessari allo svolgimento di determinate mansioni, ma anche come esseri capricciosi, volubili, soggetti a forze sconosciute. Maggiore è la loro complessità, maggiore è la tendenza a mostrarne gli aspetti incomprensibili, misteriosi, quasi magici. Infine, gli esperti: sono loro a essere in grado di interagire correttamente con gli esseri tecnici; sono capaci di incanalarne le forze oscure, incatenandole e dirigendole affinché si manifestino in comportamenti prevedibili e non pericolosi.
In questa narrazione le donne sono per natura incapaci di gestire le macchine, devono rivolgersi a chi sa, tipicamente uomini capaci di sottomettere le macchine ribelli. La loro resa di fronte al potere degli esperti, cui consegnano la macchina da aggiustare, da rimettere in riga, opera come una sorta di raddoppiamento che conferma la loro condizione di subalternità nel discorso tecnocratico. La caratterizzazione di genere è forse un po’ forzata, ma esplicita il portato di una cultura patriarcale che estende le proprie spire ben al di là delle relazioni fra i soli esseri umani, inquadrando in rapporti di dominazione gerarchica ogni essere, vivente o meno.
E quando il guasto accade a un uomo? Nella mia esperienza personale, anche se i passaggi sono leggermente diversi, la resa è altrettanto necessaria. A differenza della donna, che può dichiararsi fin da principio fragile, inesperta, persino incapace, e rimettersi nelle mani dell’esperto maschio, capace di guidarla e consigliarla… l’uomo deve soffrire. O almeno, deve dimostrare di aver sofferto, almeno un poco; di solito in senso figurato: deve dimostrare di aver speso tempo ed energie per cercare di comprendere il problema, di sviscerare l’arcano. Solo allora, potendo affermare di essersi sforzato, di aver fatto del proprio meglio per studiare e capire, insomma potendo mostrare le proprie piaghe, la sua istanza d’aiuto potrà essere presa in considerazione dall’augusto esperto.
Nel contesto patriarcale, la donna può al limite giocare il gioco della seduzione, l’uomo deve invece giocare il gioco della sfida competitiva, battersi, per poi dichiararsi vinto. Nel caso dell’informatica questo atteggiamento si manifesta nel suprematismo nerd, ma per ora ci basta sottolineare che il rapporto standard con oggetti apparentemente banali come gli elettrodomestici, se osservato da vicino, ci permette di svelare il meccanismo basilare della tecnocrazia.
Nella sua forma più semplice, è un triangolo perverso: basta un tubo di lavatrice guasto a scatenare la sottomissione volontaria di un umano che cerca aiuto presso un altro consimile che, in nome di una superiore conoscenza, ne esige l’obbedienza a determinate regole di corretto comportamento perché il guasto sia riparato e la macchina torni a funzionare correttamente. Esisterebbe quindi una norma che coinciderebbe con la normalità, cioè il funzionamento regolare, secondo le regole; il guasto si configura come infrazione dell’ordine del funzionamento; l’esperto è in grado di ripristinare l’ordine. In estrema sintesi, dall’ordine all’ordine, tramite l’obbedienza, il rispetto obbediente a determinate regole.
A questo livello disinnescare la tecnocrazia sembra piuttosto semplice. Basterebbe che l’esperto fosse più gentile e paziente. Basterebbe che, rivolgendosi all’esperto, fossimo in grado di indicare esattamente qual è il problema. Basterebbe che la macchina non si rompesse… Ma sappiamo che il sistema di produzione attualmente in auge favorisce l’obsolescenza programmata, per cui le merci, compresi gli utensili e le macchine di tutti i tipi sono costruite appositamente per rompersi e guastarsi in maniera irrimediabile non appena scade la garanzia.
Evidenziamo alcuni elementi da indagare ulteriormente: reazioni emotive e nomi (generici, specifici, propri).
Le emozioni umane in relazione agli esseri tecnici sono una spia fondamentale da tenere in considerazione per comprendere come si articola il gioco del potere. Nella storiella, la reazione umana al guasto è caratterizzata dall’ira e persino da un’accusa esplicita rivolta allo strumento. Il quale, da parte sua, è curiosamente anonimo, o meglio, non ha un nome proprio, ma solo un nome generico che gli deriva dalla sua funzione: poiché lava, viene denominato lavatrice. Informato del guasto, l’esperto chiede in primo luogo il nome specifico dell’elettrodomestico, cioè il cosiddetto modello, di solito espresso con una sigla alfanumerica che segue il nome della marca produttrice. Non ottenendo una risposta adeguata, passa la palla a un esperto di grado superiore, in una gerarchia esplicita di competenze che prefigura una sorta di rapporto privilegiato fra l’esperto di alto livello e lo strumento, una relazione intima incomprensibile ai non iniziati.
Gli elettrodomestici, privi di nome proprio, sono definiti domestici nel duplice senso di relativi all’ambito domestico, della casa, ma anche, e soprattutto, perché svolgono la funzione dei domestici umani, cioè sono personale di servizio non umano; sono servi meccanici. Invece della domestica lavandaia, abbiamo l’elettrodomestico lavatrice.
Elettrodomestici elettronici
Cosa succede quando invece di semplici (semplici?) elettrodomestici abbiamo a che fare con apparecchi elettronici, ad esempio un computer zeppo di tecnologia complessa? Operiamo un salto quantico e, dalla lavatrice, passiamo a considerare una fra le manifestazioni più eclatanti della follia tecnologica contemporanea, tecnofila e tecnocratica. Protagonista è un oggetto replicato in centinaia di milioni di copie e tuttavia oggetto del desiderio di masse adoranti in tutti i continenti: l’iPhone. Vogliamo verificare se le linee di tendenza tecnocratiche emerse con il guasto al tubo della lavatrice si trovano non solo rinforzate, ma persino estremizzate nel caso di «guasto». Questo ci consentirà di cominciare a formulare ipotesi sulle contromisure possibili, esplicitando reazioni appropriate in prospettiva di modalità conviviali.
Luca aveva aspettato l’arrivo di quel modello con mesi. Era a dir poco magnifico, levigato, luccicante, faceva venire voglia di… leccarlo. A conti fatti, restituendo il vecchio modello, continuava a pagare 39,99 euro al mese di rata, in poco più di due anni lo avrebbe ripagato. Oltre 1.000 euro, sì, ma ne valeva la pena: niente era paragonabile all’iPhone. Luca ne sapeva qualcosa: da ormai dieci anni era un fan sfegatato della casa di Cupertino, e in particolare dell’iPhone. Anzi, dopo il telefono aveva acquistato anche diversi tablet iPad, e naturalmente il macbook pro, l’unico laptop che era un piacere usare. Aggiornava regolarmente i dispositivi, se ne prendeva cura sul serio. E loro lo ricambiavano, rendendo agevole e persino divertente il suo lavoro.
Ma quel giorno non c’era verso: il suo iPhone era lento. Mortalmente lento. Non caricava, non reagiva, non rispondeva a dovere. Quando Giovanna gli fece notare che forse stava esagerando, e gli disse «prova con lo spegni e riaccendi», andò su tutte le furie. Era Apple, quello, non una schifezza Microsoft! Ma cosa ne capiva lei. Per lei erano tutti elettrodomestici! Dopo un’ora passata online a cercare su forum dedicati ad appassionati, si arrese all’evidenza: non era in grado di cavarsela da solo. Ci voleva un esperto.
L’Apple store era un edificio davvero straordinario. Vetri e superfici levigate ovunque trasmettevano una sensazione di trasparente eleganza. Il commesso, gentilissimo, accolse il dispositivo sofferente con delicatezza. Pose alcune domande precise a Luca, che rispose con dovizia di particolari. Aveva un backup?, s’informò il commesso. Certo, confermò Luca, sul cloud di Apple. Quale versione, indagò quello. Eh, l’ultima, credo, cioè… forse. App particolari installate? No, non aveva un elenco preciso. E il disaster recovery? No, Luca non ricordava di averne configurato uno. Il commesso si rabbuiò. Ci vuole un recovery specialist, diagnosticò. Aprì una segnalazione sul suo sistema. Dopo venti minuti buoni, dai piani superiori scese un uomo, in camice bianco. Sembrava un medico. Prese da parte Luca, gli spiegò che il suo iPhone era affetto da sovraccarico strutturale multiplo. Si poteva sistemare, ma dal momento che la riparazione avrebbe anche potuto comportare una sostituzione della batteria per consentire al dispositivo di affrontare il processo con maggior margine energetico, a suo parere era il caso di stipulare una polizza per abbassare i costi dell’operazione.
Luca firmò senza battere ciglio. Per 16,99 euro/mese in più aveva una polizza integrale con sostituzione immediata dell’apparecchio, remote hands on e check di routine ogni sei mesi. In pratica, esperti potevano entrare nel suo iPhone da remoto e sistemarlo in caso di problemi! Era prevista anche una formazione con video-tutorial per impratichirsi delle sottigliezze e delle novità più eccitanti.
Qualche ora più tardi tornò a casa sollevato. Per fortuna c’era chi prendeva sul serio l’assistenza, e sapeva consigliare l’opzione migliore in maniera professionale. Il suo iPhone era scattante e fluido come mai prima. Certo, probabilmente, come gli avevano spiegato, sarebbe stato presto necessario sostituire gli altri dispositivi, ormai obsoleti, per allineare tutta la rete casalinga. Anzi, Luca era quanto mai deciso a portare Apple anche in azienda, non era possibile che dovesse ogni volta scontrarsi con le disfunzionalità di quei rozzi pc dell’ufficio. La transizione avrebbe comportato un salto in avanti pazzesco in termini di produttività. C’era un programma business con finanziamenti rateizzati assolutamente imbattibile.
Scattò una foto con l’iPhone. Voleva aprirla dal macbook per lavorarla, ma l’accesso al cloud sembrava bloccato. Maledizione, la connessione era saltata! Chiamò l’assistenza clienti. C’era un guasto di zona, prevedevano di ripararlo entro 24h. Si infuriò con il centralino, che però rimase impassibile, anche perché era un’assistente virtuale e non era programmata per reagire agli improperi; ripeté un paio di volte «prema 2 per altre richieste, altrimenti, si prega di riagganciare». Riagganciare un corno, urlò Luca. Aveva un iPhone, mica una cornetta dell’anteguerra! Così era bloccato di nuovo, perché l’unico modo di trasferire una foto dal telefono al portatile era passare da Internet…
Per quanto riguarda le reazioni emotive, l’ira in questo caso si è indirizzata verso altri umani, ovvero Giovanna, rea di non comprendere l’eccezionalità dello strumento; il quale, da parte sua, ha ora un nome specifico, è della specie iPhone, ma non ha un nome proprio; o meglio, il suo nome proprio è definito dal possesso umano, «iPhone di Luca». Informato del guasto, l’esperto s’informa sulla correttezza della relazione fra Luca e iPhone, per assicurarsi che tutto sia avvenuto nella maniera prescritta. Fino a che non trova la falla, ovvero alcuni comportamenti che non rispettano minuziosamente la liturgia delle configurazioni. Passa la palla a un esperto di grado superiore, che si presenta come un vero e proprio guru, medico ma anche sacerdote, pastore capace di ricondurre sulla retta via lo strumento sofferente e l’umano penitente, che dovrà impegnarsi ulteriormente per migliorare la propria cura devozionale. Questa cura tende a estendersi, con un movimento di fidelizzazione, di vero e proprio proselitismo, a ogni ambito, trapassando dal personale al professionale.
Tubi e chip
In caso di guasto, i semplici tubi degli elettrodomestici e i complicati software che spostano bit nei chip elettronici provocano effetti tutto sommato paragonabili. A cominciare dall’ira degli umani, fino alla strutturazione di relazioni gerarchiche di sottomissione agli esperti di turno. Per fare ammenda, per riportare l’ordine.
Esperto deriva dal latino expertus, participio passato del verbo experiri, che significa: sperimentare, tentare, provare, mettere alla prova, fare esperienza; cercare di, sforzarsi; sapere, conoscere per esperienza, imparare a conoscere.
Purtroppo gli esperti, al di là delle loro sperimentazioni, tentativi, prove ed esperienze, sono spesso estremamente specializzati. Purtroppo, perché la loro specializzazione di solito li rende speciali nel senso deteriore del termine, cioè appartenenti a una specie privilegiata e dominante. È come se il rapporto privilegiato con gli esseri tecnici, derivato dallo sforzo che hanno compiuto per conoscerli, permettesse loro di ascendere e di diventare superiori agli altri. Quel cimento si configura come un accumulo di conoscenza relativa agli strumenti tecnici che corrisponde a potere di fare, con gli strumenti, e di far fare, agli strumenti e agli altri umani che a loro si rivolgono come intermediari tecnici. L’accumulo di questo potere si esprime nella loro posizione e attitudine dominante: gli esperti specializzati sono diventati tecnocrati.
I tecnocrati si comportano da padroni. Si sentono padroni degli strumenti. Del resto, i comuni mortali non fanno che rafforzare le loro convinzioni. Lo sforzo necessario per acquisire la padronanza dello strumento è, in genere, direttamente proporzionale alla specializzazione; maggiore la specializzazione, maggiore l’esclusività della padronanza. Questa è la ragione per cui l’esperto di iPhone si colloca a un livello superiore rispetto all’esperto di lavatrici, in una sorta di piramide gerarchica. La padronanza dei complicati software vale di più della padronanza dei tubi, non tanto perché il software e i chip sono più costosi dei tubi e delle guarnizioni, ma perché i primi implicano molti più strati e livelli. Immergersi nella profondità dei diversi livelli corrisponde a un’elevazione, a un cambiamento di status.
Ma le cose non devono per forza andare così, l’emergere della tecnocrazia non è il destino ineluttabile di ogni relazione fra esseri umani ed esseri tecnici. Software, guarnizioni, chip, tubi e via dicendo si possono conoscere senza diventare specialisti, anche se gli ostacoli sono molti, e capita di sporcarsi le mani. Ci vuole pazienza, curiosità, voglia di esplorare e di imparare da quel che sanno gli altri. D’altra parte, quando le tecnologie si fanno più complesse, utensili e competenze tendono a cristallizzare ruoli; il potere di gestire lo strumento, accumulato, tende a cementare identità fisse all’interno di precise gerarchie. La tecnocrazia si articola e si fa ossatura delle relazioni fra le persone, tanto palese quanto ambigua.
La prossima storia è accaduta per davvero, all’inizio del terzo millennio, nella città di Milano.
«Allora, per i rendiconti della distribuzione, le cose si sono complicate. In pratica ci danno un pdf, e basta»
«Quindi noi dovremmo riuscire a estrarre i dati delle vendite, dei resi, degli omaggi e così via e importarli in un database a partire da un pdf? Assurdo. Di certo loro avranno dei fogli di calcolo, o dei report da database; ma invece di darci i dati originali, esportano in pdf! Lo fanno apposta per complicarci la vita?».
«Sì, sicuramente. Così è più difficile controllare che i numeri tornino».
Sul tavolo quadrato si sciorinavano fogli zeppi di numeri. Quelli importanti venivano cerchiati in rosso, evidenziati in verde e viola e giallo, che risaltavano sul bianco della carta, e della formica del tavolo. L’esperto informatico era stato convocato in redazione per automatizzare l’estrazione dei dati mettendo a punto un database, a partire da quel famoso pdf. In casa editrice si faceva quasi tutto a mano, e c’era chi ci stava perdendo la vista, oltre che il senno, a controllare che i numeri nelle tabelle corrispondessero a quelli delle bolle di accompagnamento e poi delle fatture.
Io facevo il traduttore, fra l’editorialese e l’informatichese, cercando di formulare spiegazioni comprensibili senza entrare troppo nei dettagli, che d’altra parte non erano il mio forte. Non conoscevo bene nessuna delle due lingue, non ero lingua madre editoria né lingua madre informatica; ma speravo, proprio per questo, di avere sufficiente cognizione di entrambe per rendere tutti un po’ più consapevoli della situazione. Invece di spaccare il capello in quattro, cercavo di procedere a furia di metafore e allegorie. Grossolane ma efficaci.
Dal punto di vista informatico c’era da decidere quale fosse la chiave primaria di ogni tabella del database; poi anche le chiavi univoche, che potevano essere più d’una. Questo passaggio era preliminare, per poter ragionare su come collegare fra loro le tabelle (da cui il nome di database relazionale: relazioni fra chiavi di tabelle), e poter poi effettuare query (domande) ed estrarre così i dati voluti. Descrizione grossolana, ma corretta. Eppure man mano che la discussione proseguiva mi rendevo conto che stavamo imboccando un vicolo cieco.
Nella mia foga di tradurre, a beneficio della redazione, avevo sostenuto che potevamo considerare la chiave primaria come il nome proprio di ogni riga di ciascuna tabella; perciò qualcuno aveva proposto di usare il titolo dei libri. Ma così poteva esserci un libro con due edizioni, stesso titolo ma prezzi differenti, e quindi non funzionava perché la chiave primaria doveva avere valori univoci; ma allora perché chiamarla primaria, se doveva avere valori univoci, obiettava qualcuno, da buon redattore attaccato al significato delle parole?
Nell’altra direzione, verso l’informatica, era necessario chiarire cosa si intendesse in editoria per «sospesi da conteggiare»; per non parlare delle «tredicesime». Per chiarirlo mi ero lanciato in un parallelo con le decime, la tassa di un decimo sul raccolto, o qualsiasi altro reddito: infatti ogni dieci copie di uno stesso titolo ordinate da una libreria, il distributore pretendeva una copia «omaggio», con cui premiare il libraio per il suo ordinativo. Il costo se lo doveva accollare l’editore, in pratica era una copia che il libraio vendeva, il distributore distribuiva e l’editore era costretto a regalare. Ma allora perché chiamarle tredicesime, si obiettava dal lato informatico… chiamarle decime sarebbe stato meglio!
Insomma, per il momento la traduzione era piuttosto zoppicante.
Ma quel giorno, in quel sottoscala milanese, c’erano problemi ben più urgenti dei rendiconti dei libri. C’erano dozzine di scatoloni di libri a rischio inondazione. All’epoca «A rivista anarchica» lasciava in usufrutto quei locali sotto il livello della strada al Centro Studi Libertari / Archivio Pinelli, con oltre seimila volumi negli armadi vetrati, e centinaia di riviste archiviate; e alla casa editrice elèuthera, che lì stipava il suo magazzino, qualche decina di migliaia di volumi. In quegli stessi locali, appena coperti da tavole di legno, correvano i tubi di scarico dei quattro piani superiori del palazzo, al momento evidentemente e olfattivamente intasati. Il flusso delle acque nere era ostruito, probabilmente da qualche oggetto gettato in uno scarico. Se una qualche curva avesse ceduto…
Citofono: erano arrivati gli esperti degli spurghi! Il giovane e il vecchio scesero le scale e si disposero all’intervento.
Abbandonato il tavolo delle riunioni, ci tuffammo tutti nella sfida delle fogne. Dai quattro lati del tavolo, ognuno aveva le sue buone ragioni per interessarsi ai nuovi arrivati. Il magazzino innanzitutto era una bella preoccupazione: la carta dei libri non va d’accordo con l’acqua, tanto meno con le acque nere. Temute anche dai volumi e dalle riviste dell’archivio, per quanto protette dai vetri, invece che dal cartone degli scatoloni. E ancor più temute dai computer, fra cui Servera, il server su cui giravano i servizi web, fileserver e via dicendo.
Insomma, oltre alla puzza, anche la preoccupazione appesantiva l’aria già pesante dei sotterranei. Nei giorni precedenti erano state rimosse le assi per verificare la situazione. Alcuni tratti dei tubi degli scarichi erano in plastica, ma la maggior parte parevano in cemento, forse addirittura in alcuni tratti in eternit; in diversi punti si vedevano delle crepe, rappezzate alla bell’e meglio.
I vari dettagli vennero riferiti agli esperti. «Quanto ci metterete a risolvere?», chiese qualcuno, come se valutasse la faccenda un impiccio tutto sommato di routine, ma tradendo nel tono l’ansia malcelata di chi si rivolge a un oracolo. «Abbiamo fatto spazio e spostato il più possibile, non c’è pericolo che si allaghi tutto, vero?», aggiunse qualcun altro. «Ci occupiamo di spurghi, faremo il possibile, ma non miracoli. Dipende da come sono messe le tubature», replicò serafico quello più giovane dei due.
Aiutammo ad aprire la finestrella sopra gli scaffali del magazzino ingombri di scatoloni di libri e a far entrare dal piano stradale, attraverso le inferriate, un tubo flessibile, nero, di plastica, con un ugello di metallo.
«Come funziona? Spinge o risucchia? A che pressione c’è rischio di rottura?», chiese l’ingegner Sabbadini, esperto di database, all’operatore decisamente più stagionato che maneggiava il tubo flessibile. Quello bofonchiò che lui manovrava solo, non si occupava della parte decisionale.
«Sì, ma tenendolo in mano lo sentirà, se risucchia o spinge… e che pressione raggiunge? In bar, intendo» insisté l’ingegnere.
«Bar? Mah…», replicò il tubista, confuso, o forse scocciato da tutte quelle domande.
«Per misurare la pressione, i bar. Mmm, che tipo di valvola è?», l’ingegnere indicava il punto d’inserzione fra il tubo flessibile e quello che pareva un manometro.
«Valvola? Guarda, io infilo solo e dico: vai!, chiedi al capo sul camion!», tagliò corto l’operatore.
Forte del mio ruolo di traduttore, salii a domandare a quello che era stato indicato come decisore. «Io schiaccio quel bottone quando sento: vai!», rispose lo schiacciabottoni. Neanche il tempo di dirlo, e: «Vai!», urlò il compare dal sottoscala. E quello schiacciò il bottone. Sarà stato per le dita incrociate a limite rottura, o forse perché gli esperti sapevano il fatto loro, o semplicemente perché la congiuntura della rete fognaria locale era favorevole, sta di fatto che, nonostante i rumori inquietanti che ci tennero con il fiato sospeso, con secchi, stracci e spazzoloni a portata di mano, a un tonfo sordo seguì una specie di fischio, e un ruscellare di acqua che sembrava aver ritrovato la sua strada consueta.
Sospiri di sollievo. «Ora comunque dobbiamo ispezionare», sentenziò il giovane boss. Scese di nuovo, con in mano mazzetta e scalpello, che rifilò all’altro. E si misero a confabulare fitto.
Ci scambiammo un’occhiata delusa, con l’ingegnere. Funzionare aveva funzionato, ma come? Non era chiaro. Drizzammo le orecchie per cercare di capire. Il vecchio non era d’accordo sull’uso degli arnesi, ma il giovane non sentiva ragione. «Spacca qui», ordinò, segnando un punto sotto il lavello. «Va bene, va bene», acconsentì il vecchio, di malavoglia. E si mise a spaccare in un altro punto dello scarico, più in alto, raccogliendo le macerie in un secchiello. Rovistò nel budello di cemento, recuperò un pezzo di plastica sporca, bestemmiò sottovoce e in quattro e quattr’otto ci mise una pezza di una specie di plastica. Fece scorrere l’acqua dal rubinetto: da sotto non usciva una goccia.
«Ecco, tutto a posto», proclamò quello che non si stava sporcando le mani, ma nel frattempo compilava scartoffie sul perché e percome della scampata inondazione di merda varia. «Però la curva è ancora fessurata», ricordò qualcuno più attento degli altri. «Superficiale. Nessun problema», dichiarò il boss. «Arrivederci», concluse. «’giorno», fece il manovale. E se ne andarono.
Senz’altro erano esperti, ora tutto funzionava, cioè gli esseri tecnici erano rientrati nei ranghi; il guasto era stato riparato, ovvero, come riportava l’incartamento compilato dal capoccia, fitto di frasi inutilmente ampollose:
[…] per i motivi indicati in premessa, l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria delle tubazioni, con scasso e rappezzo, a seguito di spurgo con smaltimento liquame, pulizia e lavaggio di tubazioni delle acque nere, da cui all’indirizzo […] è stata effettuata in data […] con finitura a regola d’arte […], blablabla.
Seguivano visti, firme e segni di spunta su una specie di questionario di un paio di pagine.
L’ostacolo alla comprensione non sembrava essere stato solo l’eccesso di specializzazione. Non è che gli spurganti fossero incapaci di spiegare quel che facevano: è che non era rilevante, o meglio, non lo ritenevano importante, ma soprattutto non ritenevano che dovesse o potesse interessarci.
D’altra parte anche noi tendevamo a trattare con sufficienza le richieste di spiegazione (peraltro rare) sul funzionamento dei database; erano espresse in maniera strana, non adeguata, si sarebbe dovuto tenere tutto un lungo e noioso discorso; insomma, faticavamo a farci capire riguardo agli aspetti che ritenevamo importanti.
Curiosità, condivisione, traduzione
Quest’ultima storia fognaria introduce alcuni ulteriori elementi per identificare le tecnologie conviviali, ovvero la curiosità, la pratica della condivisione e la traduzione.
L’eccesso di specializzazione può essere evitato solo tramite uno sforzo continuo per condividere, diffondere, spiegare ciò che si è imparato nelle proprie sperimentazioni e ricerche. La curiosità è necessaria per non adagiarsi sulle conoscenze acquisite, per non fossilizzarsi su ciò che è ormai noto e ridursi a ripeterlo in maniera meccanica.
Da esperti, è faticoso condividere ciò che si conosce. Non è facile sfuggire alla frustrazione, sia perché chi esperto non è può irritarci con domande che ci sembrano banali, sia perché ci sentiamo poco gratificati per lo sforzo che compiamo. Quando veniamo riconosciuti come esperti è spesso più facile rimanere nella parte che ci è stata assegnata, e dire: scansati, ci penso io. Sottinteso: senza il mio intervento esperto, tu non puoi cavartela, non hai potere.
Gli esperti degli scarichi sono specializzati al punto da non avere alcuna voglia di comunicare quel che sanno; si limitano a ripetere uno schema appreso, come fossero addestrati. Sono padroni di quella specifica tecnica e, in questo senso, sono tecnocrati, ma con scarsissima consapevolezza del proprio potere, che non è più funzione sociale neutrale: è già diventato obbedienza formale a una gerarchia, consapevolezza del proprio ruolo e delle competenze a esso deputate.
Anche se conoscono i dettagli delle operazioni che effettuano, anche se conoscono i nomi e le peculiarità degli strumenti che maneggiano, sono quanto meno riottosi a spiegarne il funzionamento, come se non fosse rilevante. L’ira e le reazioni emotive scomposte di fronte ai guasti precedenti lasciano il posto a una routinaria prassi d’intervento, nella quale gli esperti ultra-specializzati si comportano quasi come ingranaggi, difficile dire se ignari o meno, di un meccanismo più vasto. Ognuno fa la sua parte, come in un copione ben rodato: il giovane comanda, e forse finge di non notare che la sua autorità viene messa in discussione nei fatti, visto che il vecchio esegue, ma non quello che gli viene ordinato. Quasi a mo’ di risarcimento per la disobbedienza fattuale del sottoposto, il capo di fatto si prende il merito del lavoro altrui, frutto di una decisione che lui non aveva avallato. Tecnica e arnesi sono come gli orpelli che nascondono le relazioni di potere in gioco, o le mettono in evidenza per chi sa osservare i dettagli.
E arriviamo alla traduzione, che è l’aspetto forse più carico di possibilità. La traduzione risulta impossibile se non c’è una volontà di incontrarsi «nel mezzo», di uscire da zona di comfort della propria mansione ripetitiva, e dei propri rapporti gerarchici noti, giocati in sordina, come sottotrama della rappresentazione principale; se non c’è lo sforzo continuo per cercare di spiegare ciò che accade, come e perché si decide e si agisce, con inevitabili semplificazioni e approssimazioni. Tradurre implica un movimento di de-solidarizzazione da sé, ovvero bisogna essere disposti a guardarsi dal di fuori e dare un nome sufficientemente preciso non solo ad azioni e arnesi che riteniamo ovvi e banali, ma anche al nostro modo di agire e re-agire rispetto agli altri esseri umani coinvolti.
Riprendiamo lo schema del guasto: di fronte all’essere tecnico che «non funziona», l’essere umano tende a cercare qualcuno che ne ha fatto esperienza. «Non ci capisco nulla», afferma, sminuendo la propria competenza per convincere quello che ha identificato come esperto a occuparsi del caso; se quest’ultimo esita a farsene carico, passa all’attacco: «A te non costa nulla», sostiene. Il che è relativamente vero, nel senso che l’esperto in genere farà meno fatica del non esperto; questo schema evidenzia quindi la fatica della cura nella relazione fra esseri umani ed esseri tecnici.
In ogni caso, l’emergere della tecnocrazia si configura come delega di questa cura, e parallelamente come formulazione di una lingua esoterica riservata agli iniziati in grado di comprenderla; di una correlata gerarchia, al tempo stesso esplicita, con capi e sottoposti, e ambigua, ad esempio con comandi rispettati nella forma ma non nella sostanza.
A volte a questa delega corrisponde una ricompensa economica, come nel caso degli esperti di tubi e software che abbiamo visto; ma non è detto che debba intervenire il denaro. La distribuzione di ruoli esperti avviene comunemente anche fra amici, parenti e affini; tende a ripetersi e a strutturare le relazioni fra le persone, con geometrie variabili a seconda degli esseri tecnici coinvolti; contribuisce a definirne le identità sulla base di competenze tecniche, vere o presunte. Se la gente lo sa che sai suonare, suonare ti tocca, per tutta la vita, cantava Fabrizio De André… le capacità possono trasformarsi in una condanna alla ripetizione, alla fissità identitaria.
E, d’altra parte, possono anche non essere riconosciute esplicitamente, come accade al vecchio manovale: lui sa dove spaccare, detiene una conoscenza, ma evita di mettere in discussione la gerarchia al punto di sovvertirla, pur prendendosi il rischio di procedere come ritiene giusto. Alla fine tutto torna nei ranghi, con il corollario burocratico: la competenza relativa alle carte conferisce un ruolo gerarchicamente sovraordinato rispetto al lavoro manuale; la burocrazia si configura come garante della stabilità gerarchica, andandosi a saldare alla tecnocrazia nel tandem tecno-burocratico.
Come fare per mettere a punto tecnologie e tecniche in grado di evitare l’instaurarsi di gerarchie fisse, tecnoburocratiche? Come alleviare la fatica della traduzione, della spiegazione e della dissoluzione della tecnocrazia? Come rendere meno gravosa e anzi piacevole la condivisione delle proprie conoscenze? Come limitare la delega in maniera che non diventi strutturale ma rimanga temporanea e revocabile?
Saranno i temi del prossimo capitolo.
capitolo secondo
La rete, questa sconosciuta
Punti connessi creano reti. Digressione teorica sui grafi: nodi, archi e pesi. Modelli di rete e strutture gerarchiche. Concezioni antropologiche della tecnologia in cui gli esseri tecnici sono supporti neutri per le azioni umane. Dove siamo? Situarsi sulla rete digitale del web. Sistemi di mutuo assoggettamento e condizionamento. Un quiz per materializzare la rete di Internet: radio, cavi o satelliti? Discussione di alcune obiezioni.
I primi tre ingredienti positivi da porre per costruire tecnologie conviviali sono dunque curiosità, condivisione e traduzione. Ora dobbiamo capire come dosarli, in che modo mescolarli e secondo quali sequenze. I poteri sprigionati da questi accostamenti nella ricetta che ne risulterà dovranno essere valutabili a ogni passo in termini di apporto conviviale, di potenza emancipatoria e liberatoria. In altri termini, dev’essere chiaro come verificare che le nuove capacità di produrre e applicare norme (poteri generati dalle procedure) vadano nella direzione di una maggiore libertà reciproca a tutti i livelli, di pari passo con un’accresciuta uguaglianza. Devono essere in grado di diffondere l’accesso ai poteri quanto più possibile a quanti più esseri coinvolti nelle interazioni; contemporaneamente, devono contribuire a rendere quanto più difficoltoso possibile l’accumulo di potere e l’insorgere di gerarchie dominanti.
Potremmo ragionarne in teoria, provare a calcolare quali sono le proporzioni idealmente corrette, in quali condizioni, formulando ipotesi su potenziali rischi e benefici; oppure, possiamo provare ad applicarle in pratica, effettuare correzioni strada facendo a seconda delle contingenze e poi, una volta effettuata la sperimentazione, valutare se è stata soddisfacente.
In questo secondo caso abbiamo bisogno di una situazione concreta, cioè letteralmente di mettere in situazione le conoscenze. Dopo i tubi e i chip, l’avventura con le fogne ci ha messo di fronte alla configurazione più comune delle tecnologie contemporanee, ovvero la struttura di rete. Ci sono reti ovunque, variamente interconnesse e sovrapposte: rete fognaria, rete idraulica, rete elettrica, rete metropolitana, rete stradale e autostradale, rete ferroviaria; e reti di comunicazione, come la rete radiofonica, la rete televisiva e, naturalmente, la rete di Internet. Dal punto di vista umano esistono senz’altro reti sociali, reti di conoscenze, reti parentali e affinitarie, variamente intrecciate fra loro e con le precedenti reti tecniche.
Che cosa hanno in comune queste strutture sociotecniche per poter essere tutte categorizzate come reti? Ci vuole un notevole sforzo di astrazione. Dobbiamo accantonare momentaneamente non solo tubi e chip, ma anche strade, fermate, caselli, ripetitori, onde e insomma tutti gli oggetti materiali che costituiscono le reti stesse. Ma solo momentaneamente, perché il ritorno alla concretezza è la migliore garanzia che abbiamo per evitare di invischiarci nelle pastoie del radicalismo astratto, delle teorie vuote di pratica.
In prima approssimazione, una rete è l’insieme di punti connessi fra loro da linee.
Chi vuole entrare più nel dettaglio può proseguire con la digressione che segue; chi ha sufficiente conoscenza della teoria delle reti, può saltare il prossimo paragrafo e passare al successivo.
Digressione: reti dalla teoria alla pratica
Possiamo visualizzare in maniera bidimensionale una rete su un foglio di carta sotto forma di grafo (da non confondere con grafico), cioè un insieme di punti (nodi o vertici) connessi fra loro a coppie da linee (archi, spigoli o lati). Una rete estremamente semplice può contare anche solo tre nodi (a, b, c), di cui a e b sono connessi, mentre c è disconnesso, come rappresentato nella Figura 1.
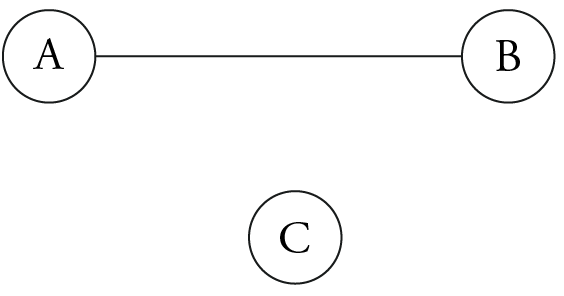
Figura 1
Con il crescere del numero di nodi e di archi che li collegano, il grafo che rappresenta la rete diventa più complesso. Alcuni archi vengono percorsi più spesso e seguendo una certa direzione, da un nodo all’altro ma non nella direzione opposta. Nella teoria dei grafi1 questo si traduce specificando che si tratta di un grafo pesato, in cui gli archi hanno un valore diverso (un «peso»); e orientato, in cui la percorrenza è orientata in un certo modo. Graficamente possiamo rappresentare questa rete con delle frecce al posto delle linee, e con dei numeri che indicano quanto spesso, o con quale intensità, viene percorso un determinato arco. Il grafo della rete viene così arricchito di particolari come nella Figura 2.
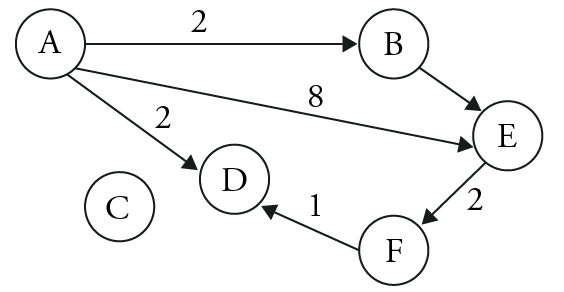
Figura 2
Il peso dell’arco che collega a, e (8) è quattro volte maggiore rispetto al peso dell’arco che collega a, b (2) e otto volte quello che collega f, d (1). c rimane disconnesso. Il grafo, orientato e pesato, descrive nell’astrazione bidimensionale quella che è concretamente una rete gerarchicamente ordinata.
Non è banale tornare alla concretezza, una traduzione è sempre necessaria. Questo grafo potrebbe ad esempio descrivere la rete di un’emittente radiofonica che dalla stazione a invia il segnale radio in onde fm (modulazione di frequenza) di tipo broadcast (da uno a molti) alle riceventi b, d, e; quest’ultima è anche una sottostazione che riceve il segnale anche dalla sottostazione b, con una potenza pari a 1; e ripete il segnale ricevuto verso f, con una potenza di 2; infine f ripete il segnale a d. Ogni segnale deriva da a, che non riceve segnali da nessuna sottostazione; nessun segnale giunge a c. In questo esempio i pesi corrispondono alla potenza del segnale radio.
Questa struttura è gerarchica perché i nodi non hanno tutti lo stesso peso e non godono tutti delle medesime libertà in termini di connessione e accesso alle risorse di rete, cioè agli archi di collegamento fra i diversi nodi. Non definiscono le norme cui invece obbediscono. Se ad esempio la connessione fra e e f viene a mancare, f rimarrà isolato; ma non d, perché è connesso direttamente alla sorgente a. La topologia della rete, cioè le sue proprietà geometriche al di là della misurazione, come ad esempio la connessione o meno fra due nodi, è fondamentale per comprendere come ciascun nodo influisca sull’altro, ovvero quale potere ha di definire la struttura e le relazioni rispettive.
Reti e gerarchia
Le reti sono intrinsecamente strutture gerarchiche? Implicano una distribuzione asimmetrica del potere, che determina rapporti di supremazia e subordinazione reciproci, cioè organizzazioni di tipo piramidale orientate allo sfruttamento tramite l’instaurazione del dominio? Oppure sono strutture di per sé libertarie, orientate al libero usufrutto tramite pratiche libertarie, pervertite da approfittatori senza scrupoli? La domanda non è banale come potrebbe sembrare e la risposta è complessa.
Intuitivamente molti umani rispondono: dipende da chi le usa, e da come le usa. Nella pratica, dipende ad esempio dalle regole di connessione fra i nodi. Dipende dalle preferenze accordate ad alcuni percorsi invece che ad altri. Dipende dai vincoli materiali, dalle vicende storiche che hanno condotto a costruire la rete in un modo piuttosto che in un altro, e via dicendo.
La risposta è però orientata dalla domanda. Infatti, come vedremo meglio nel prosieguo, il modo di porre le domande implica dei presupposti, dei non detti, da cui discende una tensione verso modalità di risposta che tendono a determinare le risposte stesse. In questo caso, il presupposto principale è l’essenzialismo e la convinzione che esistano elementi indipendenti, astratti e teorici, che si incarnano in una situazione concreta.
La legittimità delle domande sulla natura intrinseca della rete si fonda su un presupposto filosofico non detto. Questo tacito postulato è una sorta di platonismo idealistico per cui esisterebbero delle entità astratte (nodi, archi), dotate di alcune proprietà essenziali (formalizzabili persino in termini matematici!), che nelle loro incarnazioni manifestano tali proprietà in maniera differente, anzi opposta! Così alcune reti sarebbero buone e altre cattive in base all’uso che ne viene fatto dagli umani; alcune reti sarebbero fonte di emancipazione e liberazione, altre di sottomissione, assoggettamento, dominio. Addirittura, una stessa rete potrebbe essere usata in maniera buona e giusta oppure cattiva e sbagliata. Questo vorrebbe dire che gli elementi costitutivi della rete sono in definitiva supporti neutri per azioni, reazioni e organizzazioni del tutto antagoniste fra loro; gli stessi elementi tecnici, usati in maniera differente dagli umani, sarebbero portatori di libertà e uguaglianza, invece che di dominio.
Riconosciamo facilmente in questa posizione una concezione antropologica della tecnologia. Approfondiremo le diverse concezioni delle tecnologia nel capitolo quinto, discutendo degli ambienti associati. Per ora ci basta ricordare che secondo le concezioni antropologiche della tecnologia l’essere umano usa l’essere tecnico, ne cambia a piacimento il segno, da negativo a positivo e viceversa; le qualità dell’essere tecnico vengono obliterate, dimenticate al punto che non è rilevante conoscerle. Importa solo conoscere e valutare intenzioni, capacità e caratteristiche degli umani utenti delle tecnologie.
Il potere tecnico funziona però in maniera diversa. Come ogni potere è una questione relazionale, non prevede l’esistenza assolutamente indipendente di elementi astratti, ma la concreta, vibrante, evolutiva e materiale interdipendenza di esseri viventi (individui, cioè associazioni autogestite di cellule) ed esseri tecnici (organizzazioni di componenti, perlopiù eterogestite).
Accantoniamo la prospettiva essenzialista per assumere questa prospettiva relazionale e relativista. Ora le domande possono essere formulate in maniera del tutto diversa. Possono esistere tecnologie conviviali? In maniera più completa: data l’esistenza di reti più o meno complesse (dalle reti fognarie alla rete di Internet), parzialmente connesse e sovrapposte (la rete ferroviaria e la rete elettrica, ad esempio), composte di esseri umani, esseri tecnici e norme che regolano l’interazione fra di essi, esistono pratiche conviviali, suscettibili di promuovere una redistribuzione e diffusione del potere, in termini di capacità di intervenire nella definizione e applicazione delle norme sociali, cioè di produzione delle reti stesse? Esistono esperienze, metodi, ricette, ingredienti, attitudini che favoriscono l’instaurarsi di rapporti di libera associazione e collaborazione, capaci di diffondere modalità di usufrutto ampio e condiviso delle risorse, cioè organizzazioni di tipo libertario, orientate all’emancipazione e alla liberazione degli esseri umani, e di tutti gli altri esseri, viventi e non?
Come ci siamo tuffati nelle fogne, cercando di capirne il funzionamento, osservando e chiedendo conto di quel che succedeva, per trarne alcune indicazioni fondamentali, così nella prossima esplorazione ci immergeremo in un’altra rete, molto più complessa, sofisticata e capillare: la rete di Internet. Anche la rete Internet è un grafo, molto complesso e stratificato in tanti livelli, ma pur sempre un grafo; lo stesso si può dire per l’insieme delle pagine web, che sono un sottoinsieme di Internet (quello basato sul protocollo http/s).
Prenderemo perciò in considerazione un caso molto frequente nell’impiego della rete di Internet, per rendere l’esperimento facilmente ripetibile, con l’impiego di strumentazione minima e di ampia reperibilità. Il nostro caso di studio sarà l’accesso a un sito web molto conosciuto.
Dove siamo?
Nell’aprile 2022 il sito
Aggiungiamo un pizzico di curiosità. Semplice sì, ma dove siamo, quando arriviamo a TikTok? D’accordo, su Internet. Ma dove, su Internet? Dove si trova TikTok?
Nei server e nei data center di TikTok, risponderà chi ha un’idea di come è strutturata Internet. Esatto. I data center, in italiano Centro Elaborazione Dati (ced), anche detti server farm (fattorie di server), sono enormi capannoni industriali zeppi di server, cioè di computer fabbricati per rimanere accesi 24/7/365, in maniera continuativa. Tipicamente sono collegati alla rete globale da connessioni in fibra ottica, alimentati in caso di black-out da gruppi di continuità per scongiurare interruzioni di servizio, vigilati da sistemi di sicurezza, da rigide procedure di controllo degli accessi e, spesso, da personale umano armato. In questi centri di gestione, manutenzione e custodia di server ronzano i dati di TikTok, sempre accessibili e disponibili per gli utenti. Oltre che, naturalmente, per la società proprietaria della piattaforma.
Ma dove si trovano, in quale località sul pianeta Terra? Come possiamo scoprirlo?
Grazie alla curiosità il nostro punto di vista cambia. Porci queste domande significa fare un passo indietro rispetto alle nostre abitudini e osservare quel che facciamo abitualmente con occhio etnografico, come se ci vedessimo agire per la prima volta. Una curiosità non scontata, che non si può saziare con risposte preconfezionate.
Chiediamo a Google!, direte. Proviamo. Nato come motore di ricerca nel 1998, vent’anni più tardi è già diventato il fulcro di una serie impressionante di servizi diffusi in tutto il mondo: posta elettronica (Gmail), mappe (Gmaps), video (YouTube), app (PlayStore), tracciamenti (Google Analytics), sistema operativo (Android), navigatore web (Chrome), e così via. Le applicazioni più avveniristiche, dalla cosiddetta Intelligenza Artificiale ai sistemi di esplorazione dello spazio profondo, sono in continuo, rapido sviluppo nei laboratori delle società afferenti ad Alphabet, la «compagnia madre» di Google.
Ma possiamo fidarci? Forse sì, forse no. Google risponde cercando di indovinare cosa cerchiamo, di soddisfarci, come mostrano anche i suggerimenti di completamento automatico, offrendo risposte ponderate in base alle nostre ricerche precedenti, alla nostra posizione geografica, lingua. Le risposte sono confezionate in base a chi siamo e alle abitudini che ci identificano. Non è un vero e proprio raggiro, né una truffa esplicita, ma piuttosto un combinato disposto di reciproche aspettative più o meno sottaciute fra umani e sistemi tecnici.
La personalizzazione avviene in base a chi il sistema suppone noi si sia, cioè al riconoscimento di un’identità, o quanto meno dell’appartenenza a una categoria identitaria (genere, lingua, ecc.). Ma potremmo esserci impossessati delle credenziali di qualcun altro, aver effettuato il login e agire quindi sotto mentite spoglie, come se fossimo un’altra persona. Oppure potremmo semplicemente aver cambiato punto di vista, desiderare risposte difformi, diverse rispetto alle risposte che il sistema ci propina abitualmente.
Gli algoritmi operanti tendono a restituire per primi i risultati più popolari, cioè quelli visualizzati dalla maggioranza, interpretando un alto numero di connessioni entranti alla stregua di voti. Un sito linkato da molti siti comparirà più in alto rispetto a un sito linkato da pochi altri siti. Come tecnologia si comporta in maniera conformista. Non voglio qui suggerire che Google mente, ma solo che nei fatti il suo obiettivo primario è quello di far guadagnare gli azionisti della società, al di là delle risposte.
Anche ammesso che Google sia la risorsa più adatta cui far ricorso, rimane opinabile quale sia il modo migliore per porre la questione.
Possiamo trattare il sistema come un essere umano, e porre le domande in lingua naturale, proprio come faremmo con una persona. O meglio, con una persona che conosce la lingua in cui ci esprimiamo. Digiteremo allora (o scandiremo, a favore del riconoscimento vocale):
Dove è situato TikTok?
Ma se risponde con un articolo di Wikipedia riguardo alla composizione societaria dell’azienda in questione, alla sua storia, o con altre informazioni che non ci soddisfano, è segno che non ha compreso quello che davvero volevamo. Possiamo allora provare a scandire bene le parole; magari a semplificare la questione, attraverso un fraseggio meno complesso, o una circonlocuzione. Ad esempio:
Dov’è TikTok?
La semplificazione estrema consiste nel rivolgersi al sistema esclusivamente tramite parole chiave. Ma come scegliere le keywords appropriate? In questo caso, probabilmente appropriato coincide con ciò che ha la maggior probabilità di generare il risultato desiderato; dovremo quindi comportarci in modo tale che il sistema capisca ciò che vogliamo, ovvero in modo da condizionare la sua reazione nella direzione voluta. In effetti, ci troviamo di fronte a un tipico problema di traduzione. Dobbiamo tradurre nel linguaggio più adeguato alla comprensione quel che cerchiamo. Forse potrebbe funzionare una domanda del tipo:
TikTok data center?
A metà 2022, Google rispondeva con risultati riguardo a nuovi data center in Europa, in particolare in Irlanda. Ma né Google, né altri motori di ricerca (Bing!, DuckDuckGo, Qwant, e così via) erano in grado di fornire una risposta chiara alla domanda:
Dove siamo andati quando ci siamo connessi al sito web di TikTok?
A questa domanda, il sistema offriva «circa 85.900 risultati (0,46 secondi)». Chi mai avrebbe controllato la quantità approssimativa e il tempo di fornitura? Nessun umano, probabilmente. Ritorneremo a indagare sulle risposte contenenti informazioni non richieste nelle domande, parte di un più ampio sistema di addestramento cognitivo. Per ora ci basta constatare che i primi risultati erano semplicemente link al sito TikTok, a pagine di ToS (Terms of Service, Termini di Servizio), e simili.
Semplificare può significare tradurre nella maniera appropriata, nel senso di propria di quel sistema. Non è affatto facile. Anche perché scarseggiano i dizionari umanese-macchinese, linguaggi umani-linguaggi tecnici. Certo, esistono molti corsi per apprendere a scrivere codice informatico in moltissimi linguaggi specifici; esistono tantissime guide per insegnare a servirsi di determinate interfacce. Eppure è molto difficile comprendere come si svolgono i vari passaggi dell’interazione tecnica in un caso apparentemente banale come quello presentato. Ma, nel caso in cui sappiamo già la risposta, ad esempio quando cerchiamo quel certo sito web che visitiamo spesso e di cui abbiamo il nome sulla punta della lingua, le cose possono procedere più speditamente: una volta indovinate le parole chiave funzionali alla nostra richiesta, il sistema tenderà a riproporcele la volta successiva, e noi tenderemo ad adeguarci a come il sistema si manifesta. L’interazione tende a confortare le convinzioni implicite nelle domande poste.
Quella che a prima vista si presenta come una semplice richiesta di un umano a un servizio tecnico si rivela, non appena cambiamo il punto di vista, un esercizio di traduzione che si conclude nella ripetizione semi-automatica di uno schema d’interazione. L’essere umano ha un obiettivo, cerca di porlo in termini che ritiene adeguati all’essere tecnico, che reagisce come è stato programmato, cioè per soddisfare quell’obiettivo piegandolo alle sue specifiche modalità d’interazione. Definisco questo schema d’interazione un mutuo assoggettamento e condizionamento fra umano e tecnico. I rispettivi poteri, cioè capacità di formulare norme condivise, vengono sostanzialmente piegati al fine di sottomettere e condizionare l’altro al proprio volere: dal lato umano, per condizionare una risposta; dal lato tecnico, per far accettare una risposta preconfezionata, sulla base di domande formulate in maniera già di per sé condizionate dalla supposta natura di funzionamento del sistema.
Ci rendiamo conto che stiamo facendo troppa fatica, è evidente, perché ci stiamo allontanando dalla richiesta iniziale e impantanando nei vari strati di interazione. La domanda sembrava banale e invece ci siamo trovati a discettare degli obiettivi di Google. In casi simili, la fatica è la spia del fatto che la traduzione della curiosità non è sufficiente, o è applicata in maniera scorretta e genera quindi frustrazione, senza creare nuove possibilità di produrre norme né tanto meno di applicarle. La fatica non viene compensata dall’acquisizione e diffusione di potere. Dalla frustrazione per quello che l’umano può vivere come errato funzionamento, cioè come guasto, all’irritazione e quindi alla rabbia, il passo è breve. E ritorniamo così alla situazione del guasto analizzata nel capitolo precedente.
D’altra parte, anche in questo caso ci troviamo in una situazione di sudditanza. Infatti non abbiamo deciso noi le norme di funzionamento di Google; possiamo solo applicare le norme esistenti, anzi cercare di indovinare quali siano e forzare il sistema ad assecondarci, cioè applicare norme non esplicite senza poterne valutare l’efficacia. E viceversa: Google cerca di condizionare la nostra scelta offrendoci una pletora di risposte preconfezionate ma comunque personalizzate per noi, o per chi il sistema presume che noi siamo, cercando di desumere le nostre intenzioni dalle informazioni in suo possesso.
Un aiuto ci viene dalla pratica della condivisione. Delle domande, innanzitutto. Se Google mena il can per l’aia e ci fa girare in tondo, a giocare il suo gioco in cui ci sono milioni di risposte già pronte ma non quella che cerchiamo, e d’altra parte non abbiamo la pazienza di scorrerle tutte, visto che siamo abituati a fermarci alla prima risposta, al massimo poco oltre… allora forse non è questo il caso di fidarci, perché non si sta mostrando affidabile, e soprattutto non sono chiare le regole d’interazione. Possiamo allora chiedere a qualcuno di cui ci fidiamo, a qualcuno che consideriamo esperto, che ne sa più di noi: cosa possiamo fare per scoprire dove si trova TikTok?
Forse un giorno questo sistema esperto potrà anche essere una macchina digitale, ma certo dovrà funzionare in maniera diversa da Google, che pare guasto come un tubo rotto, solo che non riusciamo a capire dove stia il guasto, al punto che ci viene il dubbio di essere guasti noi, cioè di non essere in grado di interagire nella maniera corretta, di non seguire bene le regole d’interazione, la liturgia prescritta, come accadeva con l’iPhone. Nell’attesa di un simile essere tecnico, l’opzione più semplice e meno onerosa dal punto di vista energetico è rivolgersi a un umano smanettone degno della nostra fiducia.
Questa persona affine esperta, con cui deve esistere una relazione pregressa, quanto meno una fiducia immaginata, per sentito dire, per quanto non ancora verificata, dovrà ascoltare la domanda; magari porrà qualche domanda a sua volta, per accertarsi di aver compreso bene. Cercherà di tradurre la domanda in una maniera comprensibile dal suo punto di vista. A questo punto probabilmente risponderà di non averne la più pallida idea, ma di avere un’ipotesi sul metodo da seguire. A meno che non sia a conoscenza della risposta esatta per qualche fortuita ragione.
Una tecnologia appropriata si manifesta allora sotto forma di sequenza cooperativa dinamica fra un essere tecnico specificamente costruito per rispondere a quella specifica domanda e un essere umano in grado di individuarlo e porsi in relazione in maniera reciprocamente soddisfacente. La tecnologia si esplicita come metodologia tecnica, cioè di applicazione di un certo metodo. Non c’è una risposta immediata, ma è possibile costruire una strada per ottenere una risposta soddisfacente avvalendosi della collaborazione di strumenti appropriati. Assumere un’attitudine hacker è una precondizione necessaria per poter osservare le proprie interazioni da un punto di vista non ordinario e poter immaginare nuove vie.
Il mio parere è che sia opportuno ricorrere alla riga di comando, la già citata cli cara agli hacker. Se volete provare, ricordate di digitare «man nomecomando» e di leggere attentamente ogni volta che non siete sicuri sul da farsi. Questa è una ricetta, non un’orazione da ripetere in maniera pedissequa; ci vuole sempre un po’ d’iniziativa e gusto personale, desiderio di interpretare a modo proprio. Aprite un terminale su un computer equipaggiato con una distribuzione gnu/Linux e digitate:
$ man traceroute
Vi risparmio le 435 righe di manuale (11 ottobre 2006), perché per vostra fortuna l’apprendistato in questione l’ho già fatto, leggendo il manuale molto superficialmente; posso quindi condividere con voi quello che ho imparato, sfrondando dai mille esempi e casi d’uso riportati, e cioè che basta un semplice comando:
$ traceroute tiktok.com
Da cui si ottiene come risposta:
traceroute to tiktok.com (161.117.98.196), 30 hops max, 60 byte packets
1 H388X.home (192.168.1.1) 1.675 ms 1.617 ms 2.584 ms
2 * …
16 if-ae-2-2.tcore2.svw-singapore.as6453.net (180.87.12.2) 349.650 ms 349.687 ms 349.660 ms
Difficile? Incomprensibile? Certo, non conoscendo la lingua… un po’ di traduzione dal linguaggio della riga di comando può aiutare.
Abbiamo chiesto di tracciare la strada verso il sito web di TikTok con il software Traceroute, che dobbiamo aver installato sul dispositivo. Questo programmino tracciastrada ci informa che l’indirizzo ip cui vogliamo arrivare è il 161.117.98.196 e che effettuerà un massimo di trenta salti da un nodo all’altro della rete (30 hops max), inviando pacchetti di dati della dimensione di sessanta byte l’uno (60 byte packets). Anche in questo caso sembrano esserci molte informazioni non richieste. Non sono però state messe lì a bella posta per impressionare; sono un tentativo, magari un po’ rozzo e non particolarmente riuscito, né esteticamente gradevole, per rendere noto a chi sta interagendo quali sono i passi specifici compiuti dal tracciastrada per effettuare il percorso richiesto. Sono i dettagli della ricetta seguita.
La serie si ferma dopo sedici salti, arrivando fino al nodo identificato dall’ip 180.87.12.2 che si trova, a giudicare dall’url (indirizzo
Vogliamo una conferma, magari evitando terminali, righe di comando e traduzioni. Forse non abbiamo a disposizione un dispositivo gnu/Linux, non sappiamo installare il programma tracciastrada e via dicendo. Vogliamo forse una rappresentazione più visiva, possibilmente; più… immediata? Certamente no, perché ci sarà quanto meno la mediazione in più dello strato grafico. Più… semplice? Opinabile. Senz’altro sarebbe opportuno scegliere un linguaggio che gratifica maggiormente i sensi umani, dunque in questo caso in primo luogo la vista, mostrandoci quello che Traceroute ci ha dettagliatamente elencato.
Possiamo avvalerci dell’ottimo servizio web di Geo traceroute, <https://geotraceroute.com>, che ci permette di visualizzare la strada compiuta sul globo terrestre.
Conferma. Singapore.
Quindi, ricapitoliamo.
La curiosità di sapere dove si trova TikTok ci ha portato a porre una serie di domande, a cercare di tradurle in modo da farle comprendere a Google, che, dicono, sa tutto; il quale però in definitiva pare più interessato a condizionare il modo in cui poniamo la domanda piuttosto che ad aiutarci a soddisfare la nostra curiosità. D’altra parte, anche noi siamo in qualche modo interessati a condizionare il motore di ricerca, nel senso che abbiamo cercato di estorcergli un’informazione, di piegarlo a rispondere a una domanda che sembra, in definitiva, mal posta.
Abbiamo allora cambiato approccio, attivando la condivisione della curiosità stessa e rivolgendoci a una persona di fiducia. Il ricorso alla cli è stato faticoso, ma in definitiva necessario, e il risultato fornito è stato confermato in maniera indipendente da un altro sistema, più gratificante alla vista perché dotato di interfaccia grafica: quando un utente si connette al sito web di TikTok dal territorio italiano, dopo una serie di rimbalzi fra nodi della rete di Internet, arriva a un Centro di Elaborazione Dati che si trova a Singapore2.
Questo lo abbiamo scoperto seguendo la connessione, attivando curiosità, condivisione (delle domande), traduzione; grazie ad amici, dispositivi elettronici e programmi di cui ci siamo fidati. Siamo stati sul punto di lasciar perdere, perché di fronte al manuale di Traceroute, sembrava davvero troppo faticoso; persino prima, avremmo potuto perderci facilmente in una delle risposte di Google, se non avessimo tenuto la barra dritta nella nostra navigazione.
Ma visto che ormai abbiamo fatto tanta strada, fino all’altro capo del mondo, abbiamo in un certo senso doppiato il capo, chiuso un ciclo, e allora la curiosità torna alla ribalta. Una domanda tira l’altra, e perciò viene da chiedersi: come abbiamo fatto ad arrivare fino a Singapore?
Quiz: come funziona Internet?
In ossequio alla moda dei quiz a risposta chiusa, e visto che il tracciastrade sul globo terrestre ha introdotto una dimensione terraquea, proviamo a riformulare la questione in termini geografici.
Quando un essere umano localizzato in Europa si collega, tramite un dispositivo mobile connesso a Internet, a un servizio come TikTok localizzato a Singapore, deve per forza attraversare almeno il braccio di mare che separa la penisola malese dall’isola di Singapore. La strada più diretta, dice la geometria euclidea, sarebbe tirare una riga da un punto a un altro (un arco, se pensiamo in termini di superficie curva del globo terrestre); ovvero attraversare ampie distese d’acqua come il Mar Mediterraneo e l’Oceano Indiano. In ogni caso c’è da percorrere molta strada.
Internet è una tecnologia straordinaria, una gigantesca rete di reti, un insieme di esseri tecnici che garantiscono questo incredibile potere all’umano, senza che quest’ultimo debba saper nulla del funzionamento dell’infrastruttura sottostante. Tutta quella strada in un battito di ciglia… ma come è stato possibile? Certamente ci sono cavi sotterranei che continuano a essere posati. Laddove c’è del mare da oltrepassare, però, ci si affida a una delle tecnologie disponibili, ovvero:
risposta 1. Satelliti in orbita geostazionaria. I satelliti rimbalzano segnali elettromagnetici. Come tutti sanno, nel 2022 ce ne sono poco meno di quindicimila in orbita e ne vengono lanciati in continuazione nello spazio, da imprese private oltre che da Stati, una fitta ragnatela che costituisce l’ossatura della rete di Internet.
risposta 2. Cavi sottomarini. Come tutti sanno, fin dalla metà del xix secolo questi cavi sono stati stesi sul fondo degli oceani, grazie a tecniche di posa via via più sofisticate. Nel 2022 ci sono diverse centinaia di migliaia di km di cavi posati, una fitta ragnatela che costituisce l’ossatura della rete di Internet.
risposta 3. Onde radio di vario tipo. Come tutti sanno, Guglielmo Marconi all’inizio del xx secolo dimostrò che era possibile comunicare a distanza inviando un segnale radio dalla penisola di Cornovaglia, nell’Inghilterra meridionale, all’isola di Terranova, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, sfruttando la capacità delle onde di rimbalzare dalla stratosfera alla superficie dell’acqua. Le onde radio nel 2022 sono molto più potenti rispetto a quelle sperimentate da Marconi, come ad esempio il 4g e il 5g, fino a formare una fitta ragnatela che costituisce l’ossatura della rete di Internet.
Una sola è la risposta corretta. Ed è valida non solo per TikTok, ma anche, a maggior ragione, per quelle porzioni di Internet che ci danno la possibilità di raggiungere i server situati nei data center di Google, Amazon, Facebook, Apple o Microsoft che si trovano negli Stati Uniti, attraversando l’Oceano Atlantico.
Prima di svelare la risposta corretta, gentili lettrici e lettori, se vi sembra un quiz banale, sappiate che nell’ultimo decennio è stato proposto a molte centinaia di persone, forse a qualche migliaio; a decine e decine di pubblici differenti; lo abbiamo sottoposto a studenti delle scuole elementari, delle medie inferiori e superiori, delle università, delle scuole d’arte, dei licei, degli istituti tecnici e professionali; a professori di tutti gli ordini e gradi; a ricercatori, insegnanti, formatori, educatori, cooperanti, attivisti, amici; in italiano, francese, inglese, spagnolo; in Italia, Francia, Spagna, Svizzera, Paesi Bassi, uk, Germania. Abbiamo scritto, con i colleghi di circe, articoli in merito, ripreso dei video e persino partecipato a trasmissioni radiofoniche. Insomma, non si può dire che la risposta corretta sia un segreto.
Nella stragrande maggioranza dei casi, la risposta scelta è la numero uno: satelliti. Quindi, se il nostro campione fosse rappresentativo per Google, il motore di ricerca grazie al suo algoritmo di ordinamento dei risultati (ranking), risponderebbe: satelliti, che è la risposta preferita dalla maggioranza. Ed è sbagliata.
Un numero limitato di persone, variabile ma sempre inferiore al primo gruppo, risponde invece scegliendo la numero tre: onde radio. Non è una cattiva risposta in sé, ma purtroppo in questo caso è sbagliata. Per Google, intento a contare quanti scelgono una certa risposta e a propinarla anche agli altri, sarebbe probabilmente il secondo risultato.
Non proponiamo cavi sotterranei come risposta possibile, inserita solo come premessa, perché nel caso di TikTok c’è tutta l’Eurasia da attraversare, per quanto via mare sia più breve; perciò non so dire in quale percentuale questa risposta sarebbe stata scelta. So però che, se combinata alle risposte più popolari – satelliti oppure onde radio – per spiegare «come fa Internet a oltrepassare il mare?», è sbagliata.
La risposta giusta è quella scelta da un numero davvero esiguo di persone, a prescindere dal grado di istruzione, dall’età, dalla lingua, ed è la risposta numero due: cavi sottomarini.
Fidarsi? Meglio capire
Esiste almeno una mappa web, liberamente accessibile, del reticolo dei cavi sottomarini, corredata di distanze percorse, punti d’attracco sulla terraferma e indicazioni relative alla data di posa e ai proprietari-finanziatori, solitamente dei consorzi pubblico-privati: <https://www.submarinecablemap.com/>. Ma perché dovremmo credere a questa «risposta giusta»?
Ogni volta che accettiamo una spiegazione tecnica, accettiamo che alcuni aspetti rimangano non del tutto chiariti, cioè ci fidiamo di alcune parole chiave, spesso metafore, che sintetizzano concetti complessi. Va bene così, l’obiettivo non è diventare esperti di ogni dettaglio di un sistema tecnico, ma sentirsi sufficientemente a proprio agio con gli esseri tecnici, senza dover obbedire a procedure che non si comprendono né comandare a qualcuno o qualcosa di occuparsene al posto nostro.
Cosa caratterizza una spiegazione soddisfacente? Senz’altro non può essere troppo lunga, né richiedere uno sforzo eccessivo per essere compresa. Ma è fondamentale essere comunque in grado di afferrare il quadro generale, altrimenti si tratterebbe di atti di fede, non di comprensione. Meglio ancora sarebbe riuscire a riportare il ragionamento senza banalizzare. Una buona spiegazione sazia, come un buon piatto, ma senza appesantire. Lascia intravvedere la perizia di chi lo ha preparato, permette di gustare l’equilibrio di ingredienti genuini, accostati con creativa semplicità.
D’altra parte, mentre può essere estremamente difficile identificare tutti gli ingredienti, le modalità di preparazione e i tempi di cottura, è piuttosto facile individuare quando un piatto ha davvero qualcosa che non va. Un retrogusto di bruciato, troppo sale, una pietanza stracotta o cruda che produce una nota stonata, un ingrediente andato a male, e così via. Anche se non siamo esperti enologi, possiamo imparare a individuare un vino che sa di tappo o un vino inacidito.
Così è anche per le spiegazioni. Senz’altro si fa un po’ di fatica per comprenderle, ma la fatica viene ripagata da un senso di soddisfazione che permane. Anche perché una buona spiegazione aumenta la competenza sia di chi la riceve, che deve sforzarsi un poco per comprendere, sia di chi la formula, che deve sforzarsi un poco per renderla comprensibile. Una buona spiegazione diffonde potere sociotecnico. Aumenta il potere complessivo a disposizione senza produrre gerarchie tecnocratiche.
In breve, i cavi sottomarini sono l’infrastruttura rodata da oltre centocinquant’anni, dal telegrafo fino alle fibre ottiche. I satelliti, anche se profumano di futuro, si appoggiano a tecnologie più recenti, più complicate, più fragili, più costose, più inquinanti. Per arrivare ai satelliti, in ogni caso, non si possono usare cavi o fili, ma sono necessarie onde radio, perciò la risposta uno e tre si equivalgono, anche se si tratta di onde radio di frequenza differente. Per chi è interessato, alcuni materiali di approfondimento sono consultabili all’indirizzo
Alcune obiezioni
Spiegazioni lunghe e complesse, per quanto inevitabilmente approssimative e con largo ricorso a metafore, non sempre risultano soddisfacenti. Mappe e ragionamenti a volte non bastano. A volte capita che le persone rimangano con un languore, o addirittura ancora più affamate e assetate di prima. La sensazione di impotenza cresce invece di diminuire. Specialmente in questi casi è importante lasciare spazio alle obiezioni e cercare di capire come e perché vengono formulate, e perché risultano più credibili e soddisfacenti rispetto alle spiegazioni fornite.
Poco dopo la seconda ondata della pandemia di covid-19, durante una sessione di pedagogia hacker, mi è capitato che in una classe quinta di un Liceo di Scienze Umane alcune ragazze fossero assolutamente non convinte. Alcune loro obiezioni ci possono aiutare a capire meglio come funzioniamo, in quanto umani, quando costruiamo la nostra conoscenza insieme, ragionando sulle nostre esperienze quotidiane.
obiezione 1. E la tv satellitare? Perché Internet non dovrebbe funzionare con i satelliti, se funziona la tv?
La tv satellitare in effetti trasmette grandi quantità di dati, streaming video ad alta risoluzione. Ma il suo modello di comunicazione è broadcast, cioè da uno (emittente) a molti (riceventi): un’emittente tv satellitare invia al satellite una sola sequenza di dati (trasmissione uplink); la stessa sequenza viene ripetuta (downlink) a tutte le stazioni riceventi il segnale attraverso un’apposita parabola puntata in direzione del satellite. I satelliti geostazionari ruotano alla stessa velocità della Terra, perciò irradiano sempre la stessa zona: ecco perché le parabole satellitari possono rimanere puntate sempre nella stessa direzione. Siccome stanno sulla Terra, ruotano insieme al pianeta e rimangono sempre in vista del loro satellite di riferimento.
Il modello di comunicazione della rete di Internet, invece, tende al multicast, da molti (emittenti) a molti (riceventi). Inviare una mail, fare un post, inviare un audiomessaggio o delle foto a molti contatti da un luogo piuttosto che da un altro sono attività diverse fra loro, ma hanno un punto in comune fondamentale: comportano capacità di emissione oltre che di ricezione. Le parabole della tv satellitare ricevono il segnale dal satellite, ma non sono in grado di trasmettere nulla. Invece dispositivi come smartphone e portatili connessi a Internet possono trasmettere grandi quantità di dati molto rapidamente, oltre che riceverli; inoltre sono mobili, cioè non sono legati a una postazione precisa come le antenne satellitari.
obiezione 2. E il gps? Gli smartphone sono spesso, se non sempre, connessi ai satelliti gps, perché Internet non potrebbe funzionare allo stesso modo?
Il Global Positioning System, nato per scopi militari all’inizio degli anni Settanta del xx secolo, è una rete di satelliti che orbitano più in basso rispetto a quelli geostazionari, intorno a 20.000 chilometri dalla superficie terrestre. Questo sistema è in grado di localizzare qualsiasi oggetto dotato di un ricevitore, in qualsiasi punto della Terra e in qualsiasi momento, a prescindere dalle condizioni meteorologiche. I cellulari, i navigatori satellitari e così via ricevono segnali triangolati dal reticolo dei satelliti gps. Contengono un ricevitore gps, cioè un «chip» dotato di un’antenna, un piccolo processore e un orologio in grado di captare il segnale dei satelliti e di rilevare le coordinate terrestri della sua posizione con un’approssimazione di una decina di metri. Possono eventualmente riportare queste coordinate su una mappa grazie ad appositi sistemi, programmi o app. Ricevono dai satelliti pochissimi dati (coordinate geografiche) e, via satellite, non trasmettono nulla. Per trasmettere usano sistemi wi-fi agganciandosi alle celle terrestri.
obiezione 3. Spacex comprende la costruzione di Internet Satellitare per tutti! È solo questione di tempo e i cavi verranno abbandonati.
Vero, la società Starlink, di proprietà di Elon Musk, fin dal 2019 sta lanciando satelliti per la fornitura di connettività. Per ovviare al problema della distanza esposto sopra, le orbite non sono geostazionarie, ma leo, molto più basse (poche centinaia di chilometri, simili alle reti Iridium per la telefonia satellitare già esistente); sono quindi sensibili ai fenomeni atmosferici e soprattutto saranno necessari migliaia e migliaia di satelliti, in grado di evitare collisioni tramite sensori, per coprire porzioni significative di superficie terrestre. Su <https://satellitemap.space> si può trovare una mappa della situazione.
Anche senza considerare evidenti problemi come l’inquinamento dovuto ai detriti spaziali (il tempo di vita dei satelliti è inferiore ai dieci anni), l’inquinamento luminoso spaziale notturno, l’aumentato rischio di collisione dovuto a decine di migliaia di satelliti in orbite basse, rimane il fatto che la connettività sarà comunque più costosa rispetto a quella via cavo. Potrà forse consentire la connessione costante durante i viaggi aerei, oltre che nelle zone rurali, aumentando così il tempo di connessione globale, ma non certo sostituire la connettività globale via cavo.
obiezione 4. E i cavi sottomarini, quando si rompono, come vengono riparati?
A differenza di quel che la maggioranza delle persone ritiene (almeno nel nostro campione di riferimento nelle formazioni), pesci, smottamenti e terremoti sottomarini causano raramente guasti. La pesca è ancora il maggior problema. In Europa, nel Mediterraneo, la pesca a strascico continua a danneggiare cavi sottomarini, oltre che l’ecosistema, anche se ormai parecchie porzioni di cavi sono state adagiate sul fondale marino. In particolare non è raro che nei punti di attracco le imbarcazioni da pesca trancino i cavi. Un cavo tranciato a Mazara del Vallo significa la Sardegna semi-isolata da Internet, o Pantelleria; oppure un’importante riduzione della banda disponibile verso… Singapore! Il cavo SeaMeWe-3, entrato in funzione nel 2000 e più volte ampliato, è lungo 39.000 chilometri. Da Mazara arriva fino all’Indonesia, a Singapore, alla Corea del Sud, al Giappone, all’Australia. Parte da Nordend, in Germania, sul mare del Nord.
Riparare i cavi è relativamente facile quando il guasto è vicino alla terraferma. Altrimenti bisogna recuperare il cavo stesso, ripararlo e riposarlo. Magari inviando un robot capace di tagliarlo negli abissi e di saldarlo di nuovo correttamente.
obiezione 5. Satelliti, radio, cavi… Ma in fondo, a noi cosa importa? Quel che importa è che funzioni!
Quest’ultima obiezione è molto difficile da affrontare. Dipende dall’attitudine, e l’attitudine non è una questione di mera erudizione rispetto alla conoscenza in questione. Gli umani possono avvalersi del potere tecnico senza preoccuparsi di come funzionano gli strumenti singoli o addirittura intere reti globali di sistemi strumentali complessi, senza saperne nulla, usandole e basta. Ma così facendo tendono a delegare a un’autorità esterna la competenza relativa al sistema tecnico. Si assoggettano volontariamente, di solito per comodità, a una tecnocrazia. O per esser più precisi a una tecnoburocrazia: infatti firmano un consenso, ovvero solitamente spuntano la casella «Acconsento» senza leggere nulla. Se leggessero il contratto cui stanno acconsentendo, e se fossero in grado di capirne il contenuto espresso in termini burocratici, forse non sarebbero così tranquilli.

Il percorso del cavo SeaMeWe-3, fonte
La contro-obiezione più semplice è perciò la seguente. Quando diciamo di usare un sistema tecnico, in particolare un sistema tecnico reticolare molto complesso, costituito di tanti strati interconnessi fra loro, di fatto siamo parte di quel sistema. Non c’è soluzione di continuità fra noi umani e gli altri esseri, a prescindere che siano cavi, satelliti o ricetrasmittenti radio. Una rete è forte quanto il suo nodo più debole; un sistema è intelligente, consapevole e libero quanto il suo nodo meno intelligente, consapevole e libero. La mancanza di consapevolezza rispetto al funzionamento dei sistemi tecnici nei quali siamo immersi aggrava l’alienazione tecnica. Aumenta la vulnerabilità alla manipolazione, favorisce la diffusione di credenze magiche.
Le credenze magiche (fra cui annovero le credenze religiose) di per sé non sono nocive, a meno che non comportino la sottomissione a un’autorità dispotica, che può essere anche un’autorità del tutto introiettata: si obbedisce allora a quello che si ritiene giusto perché «si sente» che è giusto, senza mettere in discussione le proprie convinzioni. Al contrario, un po’ di scetticismo non guasta, in un’epoca in cui è difficile distinguere ciò che è credibile, ragionevole, possibile, da ciò che non lo è.
Confido che dopo questa esplorazione, anche se non avete compreso i dettagli o non li ricordate, se qualcuno vi proponesse un terminale capace di connettersi alla rete di Internet ad altissima velocità grazie a un nuovo sistema satellitare… perlomeno avreste qualche domanda da porre. Succederà, nel prossimo futuro, perché la scioccheria suprematista mira alla «conquista dello spazio» invece che a prendersi cura del pianeta su cui viviamo. E allora, fidarsi va bene, ma capire è meglio.
Così, dopo aver girato il mondo in lungo e in largo, dalle profondità oceaniche allo spazio geostazionario, ritorniamo al punto di partenza, alla tipologia di relazione che intratteniamo con gli esseri tecnici e al ruolo che giochiamo in questa relazione: dominio/sudditanza, o magari entrambi in maniera alternata. Condizionamento e sottomissione reciproca oppure mutuo appoggio?
Ce ne occuperemo nel prossimo capitolo.
Note al capitolo
1. La letteratura sulla teoria dei grafi è sterminata. Un testo classico è Øystein Ore, I grafi e le loro applicazioni, Zanichelli, Bologna, 1965. L’articolo online dell’enciclopedia Treccani è un punto di partenza per studi più approfonditi,
2. L’esempio qui svolto non è più valido perché dalla metà del 2022 TikTok si appoggia ai server di Amazon in Europa anche per il suo sito web. Perciò il traceroute si conclude nei data center di Amazon. L’evoluzione di Internet è in corso. L’esempio rimane però valido se si effettua il traceroute verso amazon.com (il sito usa di Amazon), o un sito istituzionale come nasa.gov: in entrambi i casi, dall’Europa bisogna attraversare l’Oceano Atlantico.
capitolo terzo
Evoluzioni tecniche
Dinamica del potere nelle evoluzioni tecniche. Il guasto come momento rivelatore: dall’affidamento alla delega tecnica, elemento base della tecnocrazia. Storia del governo tecnico, dalla teoria cibernetica all’informatica industriale. Modalità evolutive note: adattamento ed esattamento. Evoluzionismo in ambito tecnico e inquadramento dei sistemi tecnocratici come esattamenti tossici di massa. Ingredienti tecnocratici: sistemi di addestramento gamificato, sistemi di delega strutturale.
All’inizio di questa ricerca abbiamo visto come gli esperti si manifestino in occasione di guasti, ovvero quando i sistemi tecnici non funzionano come i loro possessori si aspettano. Gli esperti non s’impongono con la forza, ma, al contrario, sono i benvenuti intermediari, chiamati dai comuni mortali a frapporsi nella relazione, ormai insoddisfacente, che intrattengono con gli esseri tecnici di loro proprietà.
In termini di potere, potremmo dire che i guasti, manifesti nei mancati funzionamenti, coincidono con lo scemare del potere che gli esseri tecnici conferiscono agli umani, o addirittura con la scomparsa di quel potere. Ridotte all’impotenza, orfane del potere tecnico, le persone cercano allora qualcuno in grado di ripristinare quella sensazione di potenza, cioè la relazione pregressa in cui i sistemi tecnici rimanevano esecutori obbedienti e sottomessi. Ed è a questo punto che entrano in gioco gli esperti.
La domanda di esperti genera gli esperti? Le domande dall’apparenza semplice raramente sono semplici domande, soprattutto quando c’è di mezzo la tecnica; e questa non fa eccezione. Proviamo a tradurre, ponendo la domanda in una situazione concreta e studiando quel che accade.
Per esperienza umana, i guasti tecnici sono spesso faticosi da riparare. Nel caso degli esseri tecnici, analogici o digitali che siano, spesso risulta persino difficile riuscire a spiegare qual è il problema. Se siamo persone esperte di un determinato ambito, sappiamo bene che è difficile comprendere quello che i non esperti cercano di comunicarci. Questo è tanto più vero quanto più le apparecchiature sono complicate, sofisticate e realizzate in modo che sia difficile o impossibile smontarle e sostituire le parti usurate, o quando il «guasto» riguarda la programmazione dei software di un dispositivo elettronico.
Le relazioni possono risultare molto frustranti quando non si comprende il comportamento dell’altro, quando l’altro comunica in maniera a noi incomprensibile o sembra non comunicare affatto, ad esempio con una schermata nera. Tutto accade come se nel guasto, improvvisamente, l’essere tecnico si ribellasse; come se, impazzito, decidesse di non comportarsi più in maniera normale, cioè come se non rispettasse la norma. Dal momento che il cosiddetto «funzionamento regolare» di un sistema tecnico tende a coincidere con catene di automatismi reciproci (click, si apre una finestra; un altro click, si chiude… e così via), di cui gli umani fruitori ignorano la gran parte dei passaggi e dettagli, l’infrazione della norma comportamentale si configura come guasto. In effetti, di solito le condizioni di esistenza dell’essere tecnico vengono ampiamente ignorate fino a quando non si manifesta il guasto. Solo allora, di fronte all’impasse, alcuni si domandano: questa macchina, questo affare, questa cosa, l’avrò trattata bene? Avrò seguito le prescrizioni? E ora che è rotto, che devo fare?
La reazione più comune però è molto diversa, per nulla autocritica; l’ira, come abbiamo visto nel capitolo primo, la fa da padrona. L’automobile presa a calci perché non parte più fa il paio con lo smartphone che non risponde più ai comandi e sul quale si riversano gli improperi del padrone umano. Il comando non ottiene più l’effetto desiderato, la catena di retroazioni (click, click, click…) si interrompe perché il messaggio di comando inviato non viene recepito dallo strumento disobbediente, ed è questa situazione percepita come eccezionale a portare improvvisamente alla ribalta la materialità della tecnica. La Tecnica si manifesta allora in oggetti costituiti di molti strati; si svela come incarnata in oggetti connessi fra loro che formano reti complesse, oggetti che abbiamo chiamato esseri tecnici.
Studieremo più avanti le implicazioni fisiologiche, psicologiche e sociali di questa ira per la mancata obbedienza degli oggetti, che abbiamo già visto in azione. Sappiamo intuitivamente che l’ira tende a favorire l’insorgere di comportamenti passivo-aggressivi e rinunciatari, in un quadro generale di infantilizzazione dell’umano e colpevolizzazione dell’essere tecnico. Da cui le tipiche imprecazioni: «Non funziona, maledetto affare! Proprio adesso che mi serviva! Dannazione, capita sempre a me, non è giusto!».
Invece di comportarsi come lucido compartecipe in una relazione fra pari, l’essere umano viene infatti ridotto a stupido agente appena in grado di pigiare dei bottoni per godersi la vicinanza della macchina (la zona della macchina), intenta a compiere il suo dovere, a eseguire i comandi impartiti. A sua volta, la macchina, invece di comportarsi come abile compartecipe in una relazione di reciproco soddisfacimento, viene ridotta a schiava che risponde docile ai comandi, seguendo una procedura ignota alla controparte umana. Questo apparente idillio fatto di sottomissione automatizzata ai comandi preordinati nelle interfacce si spezza quando, nel guasto, la macchina si ribella e dev’essere allora regolata, riparata, ri-ammaestrata da un esperto.
L’emersione della tecnocrazia dipende in primo luogo dalla propensione a delegare la relazione con gli esseri tecnici agli esperti, i quali, da parte loro, sono ben lieti di mettersi in mezzo, dando vita a un triangolo di co-dipendenza. La parola chiave è delega: vediamo come si articola in situazioni concrete.
La delega tecnica
«Io non ci capisco niente di queste cose!», «Ti prego, solo per questa volta!», «A te non costa nulla!», «Tu sei capace!», «Ti ci vuole un minuto!».
Ho sentito molte volte affermazioni del genere, alternate in sequenze diverse ma sostanzialmente analoghe. Il dominio sta nei dettagli, o per meglio dire, nei minimi, singolari accantonamenti di potere che generano un accumulo di potere stratificato e strutturato in maniera gerarchica, capace di farsi passare per ovvietà, logica espressione del buon senso comune, naturale stato delle cose. Il dominio tecnico non sorge per caso, per accidente imprevisto, per destino ineluttabile. Il dominio si costruisce un passo alla volta, come evoluzione, composta da un’incessante selezione di caratteri tecnici adeguati a svilupparne gli elementi base presso gli esseri umani che si relazionano con esseri tecnici appositamente concepiti.
Elementi costitutivi per la strutturazione del dominio sono, ad esempio, la propensione alla delega cieca all’autorità, alla sottomissione, all’obbedienza e al conformismo; l’acquiescenza nei confronti della gerarchia. I caratteri tecnici selezionati in serie successive di strumentazioni tecniche perfezionano l’alienazione tecnica, la approfondiscono perché tendono a favorire comportamenti umani adeguati alle strutture di dominio, tipicamente concatenati in automatismi inconsapevoli, presentati come naturali, ovvi e inevitabili, da apprendere per rapportarsi correttamente alla macchina. In questo modo, nel corso del tempo, si verifica un rafforzamento di determinati tratti, ritenuti adeguati e per questo selezionati per moltiplicarsi nei mille rivoli del dominio che vanno a costituire la co-evoluzione tecnica dominante.
Il momento del guasto sembra essere cruciale per rivelare le relazioni di potere che intercorrono fra gli attori dell’interazione tecnica; perciò prenderemo sul serio queste formule di ricorso all’expertise, per quanto appaiano banali, analizzandone i presupposti e gli agiti impliciti, oltre che il significato esplicito.
Da una parte, le persone inesperte si sminuiscono, minimizzano le proprie competenze: «Non capisco, sono ignorante, non ci arrivo». Rimane sottinteso un ragionamento relativo al prezzo da pagare per mantenere una relazione soddisfacente con la macchina: implicitamente, non si dà il caso di una libera relazione consensuale, non prezzolata. Infatti, di fronte alla ritrosia dell’esperto, scatta la recriminazione: «Cosa ti costa? A me costa molto! Invece a te, che sei esperto, non costa nulla». Così, quando l’accento si sposta sull’esperto, il ragionamento sul costo relazionale si fa esplicito: «O esperto, tu sei capace, e questa superiore capacità implica che impieghi meno tempo ed energia rispetto a un non esperto per ripristinare il guasto. Ripristinare una relazione soddisfacente è meno oneroso per te, o esperto»! La continuità di attitudine è evidente: si sminuiscono le energie che l’esperto dovrebbe spendere, minimizzandone la fatica.
Di fronte alla fatica prospettata dal guasto, si affida a qualcun altro il compito di ripristinare il potere tecnico sotto forma di norma comportamentale dello strumento; si effettua cioè una delega. Come spesso accade, l’etimologia aiuta a capire la posta in gioco. Delegare, dal latino de-legare, significa mandare legato, deputare; la particella «de» indica un movimento di allontanamento. Delegare perciò significa allontanare da sé la macchina guasta, affidarla alle cure di qualcun altro, con l’accordo che ce la restituirà funzionante.
La delega tecnocratica è un meccanismo complesso, attivato da diverse leve, ma con uno schema ricorrente abbastanza semplice che in definitiva coincide con un aumento dell’alienazione tecnica, della lontananza ed estraneità fra esseri umani ed esseri tecnici. Il tema sottostante è sempre lo sforzo necessario per ripristinare il guasto, o, più in generale, per nutrire la relazione con gli esseri tecnici. Infatti, al di là del momento forte rappresentato dalla crisi del guasto, la delega tende a reiterarsi a livello di comportamento individuale, fino a diventare costume sociale diffuso. Tende a pervadere ogni istante delle relazioni fra esseri umani ed esseri tecnici, a farsi regola, a strutturarsi in una gerarchia organizzata in livelli fissi.
La più comune giustificazione addotta per la delega tecnocratica tira in ballo la conoscenza e la specializzazione. Dice il buon senso comune: non si può saper tutto, bisogna pur fidarsi degli specialisti, di chi ha maggiore autorità in un certo ambito. Anche Bakunin concorda:
Respingo forse ogni autorità? Lungi da me questo pensiero. Allorché si tratta di stivali, ricorro all’autorità del calzolaio; se si tratta di una casa, di un canale o di una ferrovia, consulto quella dell’architetto o dell’ingegnere. Per ogni scienza particolare mi rivolgo a chi ne è cultore. Ma non mi lascio imporre né il calzolaio, né l’architetto, né il sapiente. Li ascolto liberamente e con tutto il rispetto che meritano le loro intelligenze, il loro carattere, il loro sapere, riservandomi nondimeno il mio diritto incontestabile di critica e di controllo1.
Il vecchio Bakunin ha spesso ottime argomentazioni e questa non fa eccezione. L’autorità nel senso di autorevolezza dell’artigiano competente non è in discussione. Dobbiamo però fare la tara a questo discorso, espungendo l’afflato positivista ottocentesco che tende a presentare la scienza come una sorta di religione laica. La pratica della ricerca scientifica è molto spesso retta da principi competitivi e da logiche di spartizione politico-finanziarie, da velleità personali, da motivazioni tutt’altro che nobili, da una volontà di prevaricare a scapito della collaborazione fra pari.
A livello pubblico, di comunicazione scientifica e politica, la conoscenza scientifica assume spesso una postura dichiaratamente pastorale, di guida delle masse ignoranti, mutuata dalla pratica religiosa del governo delle anime. La tecnoscienza è tutt’altro che la panacea di ogni male, soprattutto quando si presenta come unica via per la salvezza del mondo. Il governo tecnico è un governo che tende inevitabilmente all’autoritarismo, perché tende a rendere operative soluzioni tecniche basate su verità scientifiche, a loro volta presentate come fonti di autorità inoppugnabili. Sappiamo invece che l’avventura scientifica è una continua evoluzione e che le verità scientificamente provate oggi potrebbero essere riviste alla luce delle scoperte di domani.
D’altra parte, sappiamo che il diritto di critica e controllo può esprimersi in maniera perversa, come accade di fronte a questioni scientifiche controverse come l’energia nucleare, i ritrovati biomedicali (a cominciare dai vaccini), le manipolazioni genetiche e così via. In casi simili, il libero ascolto di posizioni contrastanti e conflittuali tende a cedere alla fascinazione per sedicenti esperti, moltiplicatisi al punto che in definitiva ciascuno tende a seguire le proprie inclinazioni e a trovarle confermate in una presunta critica (para)scientifica al discorso dominante. I motori di ricerca e i social network tendono a confermare e nutrire i pregiudizi umani, non a far maturare posizioni critiche, frutto di un accurato vaglio e selezione.
A ogni modo, tenendo presente queste precisazioni, potremmo aggiungere l’autorità dell’esperto informatico a questo elenco di autorità liberatorie? Potremmo annoverare l’autorità dell’esperto informatico fra quelle di abili artigiani, o di accorti scienziati, in grado di migliorare l’esistenza nel senso della reciproca libertà degli uguali? Nella stragrande maggioranza dei casi, purtroppo, no. La ragione è al tempo stesso semplice e complessa.
Semplice, perché è semplice comprendere intuitivamente la differenza fra un paio di scarpe che un calzolaio può riparare, ad esempio sostituendo un tacco usurato, e un computer che non risponde ai «normali» comandi del suo proprietario, il quale però non riesce nemmeno a spiegare bene in cosa consista il problema all’esperto informatico di turno. Quest’ultimo, a sua volta, magari è esperto di uno specifico tipo di dispositivi elettronici, equipaggiati con un certo software, ma non sa proprio come cavarsela di fronte ad altri modelli. Incomprensioni e malintesi sono la regola.
Ma al contempo la ragione è complessa, perché ha a che fare con la complessità delle concatenazioni reticolari e delle retroazioni sistemiche che rendono l’informatica tanto potente. Un potere sostanzialmente opaco perché eccessivamente (volutamente) complicato, appositamente progettato e realizzato in termini industriali per favorire la specializzazione e la delega tecnocratica. Nessun umano è in grado di comprendere davvero nei dettagli il funzionamento di un sistema informatico, con tutti gli strati di cui è composto, con tutte le implicazioni delle interazioni fra diversi livelli; né di contemplare tutti gli effetti scatenati da un’azione (magari inconsapevole, frutto di un automatismo comportamentale) compiuta da un agente umano con un banale dispositivo elettronico connesso alla rete globale. Si possono descrivere a grandi linee i comportamenti previsti, ma con un grado di affidabilità e completezza non paragonabile a quanto può accadere per la competenza del calzolaio rispetto all’interazione con le calzature, anche su diversi terreni e in circostanze meteorologiche differenti.
Diecimila ore di pratica è la misura comunemente assunta per indicare il tempo che occorre a un umano per diventare un «professionista» nel proprio campo. Senza assolutizzarla, questa misura può aver senso se ci si riferisce a un’attività nota, con un cursus studiorum magari definito in secoli di affinamento (dall’antichità alle corporazioni medievali fino alle discipline contemporanee) e una chiara sequenza di risultati che si deve essere in grado di raggiungere. Sempre a patto che esista un’attitudine, una volontà e un sostrato favorevole allo sviluppo di determinate abilità. A ogni modo, al di là del talento, della predisposizione e della conformazione fisica, con una pratica costante sotto la guida di insegnanti sensibili e disponibili a imparare insieme, è possibile senz’altro diventare artigiani provetti in moltissimi ambiti: calzolai, ma anche pittori, scultori, medici, giocatori di una determinata disciplina sportiva, musicisti, scrittori e così via.
Ma questa misura di diecimila ore per raggiungere una sorta di caratterizzazione identitaria professionale non ha alcun senso se riferita all’informatica, cioè a un’attività la cui unica costante, fin dalla sua comparsa a metà del xx secolo, è il radicale cambiamento continuo, l’espansione forsennata, l’integrazione sistematica con le strutture pre-esistenti, la ramificazione in una quantità abnorme di rivoli del tutto eterogenei fra loro. Forse, agli inizi del anni Novanta del xx secolo, quando Internet era affare di pochi e il web stava nascendo, con diecimila ore di pratica (dai tre ai cinque anni di impegno costante a tempo pieno) era possibile diventare esperti di informatica, nel senso di persone in grado di gestire la relazione con le apparecchiature informatiche esistenti in maniera soddisfacente. Questo però è assolutamente impossibile oggi, e in futuro ancora di più, man mano che compariranno nuovi esseri tecnici digitali. Sarà sempre più assurdo pretendere da un singolo individuo umano di padroneggiare quel che viene ascritto all’ambito dell’informatica. Per cui diventa, necessariamente, una questione sociale e collettiva. D’altra parte, un convivio non si fa in solitudine: è logico che le competenze e le capacità individuali acquisiscano un valore effettivo solo in combinazione con quelle altrui.
In primo luogo perché il sostrato materiale cambia rapidamente, ad esempio con la comparsa di dispositivi del tutto nuovi, con caratteristiche peculiari. I cosiddetti telefoni furbi (smartphone) con schermo tattile non esistevano prima del 2007; in poco più di un decennio sono diventati di gran lunga i principali mediatori delle connessioni umane alla rete di Internet. Ma un esperto informatico potrebbe tranquillamente ignorarne (quasi) l’esistenza, o comunque non aver maturato particolari abilità con quei dispositivi, perché magari si dedica alla concezione e gestione di macchine virtuali ospitate su server remoti, o si occupa della progettazione di linguaggi informatici e protocolli di alto livello a prescindere dal sostrato meccanico.
In secondo luogo perché le reti informatiche sono composte di molti strati complessi che interagiscono fra loro in maniera estremamente rapida, con retroazioni cibernetiche, per cui anche gli esseri umani fanno parte di queste reti in maniera diversa rispetto a quanto avviene nelle relazioni con i classici utensili «semplici» (martello, forbice, ecc.) o con le macchine «complesse» (automobile, bicicletta, ecc.). Da portatore di utensili abbastanza chiaramente distinguibile dagli utensili stessi, l’essere umano tende a diventare ingranaggio di un sistema complesso, integrato quanto ogni altro elemento meccanico, elettrotecnico, chimico.
In realtà, la dinamica interattiva di fondo è simile a prescindere dalla complessità tecnica, perché da parte umana è pur sempre necessario mettere a punto automatismi cognitivi (apprendistato tecnico) per interagire in maniera soddisfacente con gli esseri tecnici. Non ci domandiamo «come funziona questo affare?» ogni volta che afferriamo un martello, e nemmeno «che diavolo è questa leva?» ogni volta che guidiamo un’automobile: meno male, altrimenti finiremmo con le dita pestate o schiantati.
Dalla cibernetica all’informatica industriale
Certamente l’automobile non ha senso senza la rete stradale, né il treno senza la rete ferroviaria; entrambe sono strutture reticolari complesse, innervate dalla distribuzione di comunicazioni e controlli per regolarne i flussi informativi e quindi la circolazione di veicoli. A partire dagli anni Quaranta del xx secolo è stato impiegato il termine cibernetica per designare lo studio dei fenomeni di controllo e comunicazione e in particolare l’invio di messaggi di comando effettivo, cioè di messaggi che modificano il comportamento di ciò che riceve il messaggio stesso (umano o non umano). Oggetto di studio della cibernetica è l’adattamento reciproco fra esseri viventi ed esseri non viventi in termini di autoregolazione dei sistemi. La cibernetica è nata in un’epoca in cui l’informatica era più teoria che pratica incarnata in apparecchiature concrete.
L’intensità dei cicli di adattamento (reciproco) nelle reti informatiche globali è notevolmente maggiore rispetto alle reti analogiche precedenti, come autostrade, ferrovie e fogne. La mia tesi è che siano preponderanti le dinamiche di esattamento tossico, orientato all’aumento di automazione e preordinato a scopi di lucro e dominio a livello individuale e collettivo, rispetto a dinamiche di adattamento/esattamento non orientate al dominio. Esattamento (o exattamento) è una traduzione dell’inglese exaptation, che grossolanamente possiamo figurarci come evoluzione che procede dall’organo alla funzione.
In termini più tecnici, nell’esattamento un carattere, o un insieme di caratteri (sotto forma di organo complesso), precedentemente plasmato dalla selezione naturale per una particolare funzione (adattamento), viene cooptato per un nuovo uso, cioè per svolgere funzioni prima inesistenti. Oppure, un carattere (o un insieme di caratteri, specie sotto forma di organo complesso) viene cooptato per un uso attuale, cioè per svolgere una funzione già esistente ma attraverso una nuova sequenza, in un modo nuovo; l’origine di tale carattere (insieme di caratteri, organo) non può essere direttamente ascritta alla selezione naturale, ma piuttosto a una variazione conservata per altre ragioni più o meno casuali (quindi un non adattamento).
Gli esattamenti differiscono radicalmente dagli adattamenti, che procedono dalla funzione all’organo, per cui la selezione naturale (o tecnica) plasma un carattere per un uso attuale, per svolgere in maniera più adeguata (con meno sforzo, in modo più efficiente ed efficace) una funzione già esistente e individuata.
Gli esattamenti sono parte dell’evoluzione naturale da sempre, e sono assolutamente fondamentali, al pari degli adattamenti. Dal punto di vista dell’analisi del potere non c’è soluzione di continuità fra esseri naturali ed esseri artificiali, fra esseri organici ed esseri inorganici, fra esseri viventi ed esseri non viventi. Propongo quindi di considerare esattamenti e adattamenti come elementi primari dell’evoluzione tecnica fin da quando il primo strumento tecnico è stato messo a punto da un nostro antenato australopiteco. Questo per evidenziare che non si tratta di un fenomeno nuovo, sorto improvvisamente con l’era digitale, ma di un continuum evolutivo che però ora si presenta come straordinariamente sbilanciato dalla parte dell’evoluzione di sistemi tecnici orientati al dominio. Non è cambiata la sostanza, ma è cambiata la rapidità, l’intensità, la scala e le reazioni sistemiche dell’adozione di determinati adattamenti ed esattamenti tecnici.
Nel caso delle reti attuali, la selezione di caratteri che il sistema individua come desiderabili avviene quindi secondo dinamiche più intense, rapide, dirompenti rispetto agli esattamenti tecnici fin qui noti. Inoltre avvengono su scala industriale globale, con effetti a catena a ogni livello della scala, dal comportamento del singolo individuo umano alla linea di montaggio dei dispositivi elettronici, alle contese geopolitiche per il controllo e l’estrazione delle materie prime (terre rare, litio, ecc.). La sensazione di disagio e alienazione tecnica è principalmente riconducibile alla forzatura orientata al dominio di selezioni evolutive tramite esattamenti tecnici tossici delle relazioni fra esseri umani ed esseri tecnici.
Discuterò nel prossimo paragrafo i meccanismi di selezione tecnica tramite esattamento teso all’automatismo. Importa ora aver ben chiaro che, per funzionare, nel senso di presentarsi in maniera fluida e reattiva alle interazioni umane, la rete globale di Internet necessita di una quantità di expertise irriducibile al singolo esperto e persino a una categoria specifica di esperti. Anche gli esperti effettuano deleghe ad altri esperti, di cui si fidano per conoscenza diretta o più spesso ai quali sono costretti ad affidarsi giocoforza, serrando sempre più le maglie di una catena senza fine in cui gli umani tendono ad affidarsi ciecamente ai dispositivi con cui vivono, da cui le loro vite in effetti dipendono in maniera crescente. Quando il flusso interattivo incontra qualche ostacolo, ecco insorgere l’ira, la frustrazione, la noia.
Certo, l’umano si affida da sempre a ritrovati tecnici per abitare il mondo. Una volta si ricorreva a mappe del territorio per orientarsi, e a enciclopedie cartacee per trovare definizioni. Oggi siamo nell’era digitale, perciò può sembrare naturale progresso tecnico (un’espressione che è un concentrato di assurdità e pregiudizi!) il fatto che navigatori digitali intelligenti sopperiscano al senso dell’orientamento umano, o che i motori di ricerca (magari consultati con assistenti vocali altrettanto intelligenti) semplifichino il recupero di informazioni.
Ma, al di là della contrapposizione poco illuminante fra analogico e digitale, sussistono differenze fondamentali fra la consultazione della mappa e quella del navigatore digitale. Si tratta di operazioni che implicano tipologie di fiducia molto diverse per intensità e soprattutto per il ritmo relazionale, per la frequenza di scambi impliciti in procedure apprese in maniera perlopiù inconsapevole dagli agenti umani. Infatti questi ultimi raramente sanno spiegare come hanno appreso a interagire con gli esseri digitali, pur avendoci a che fare senza difficoltà quotidianamente. Nessun corso di perfezionamento, nessuna scuola, nessun apprendistato: si evoca invece l’intuitività di alcune interfacce, la semplicità di determinate procedure e dispositivi, che di intuitivo e semplice non hanno assolutamente nulla. Spesso viene invocata una predisposizione all’interazione tecnica che sa di predestinazione nascosta, variamente mescolata a considerazioni scientificamente infondate sull’essere nativi o immigranti digitali. Invece è dimostrato e dimostrabile che qualsiasi essere umano dotato di determinate caratteristiche fisiche (principalmente, una corteccia cerebrale che risponde a determinate sollecitazioni visive), a prescindere dall’età anagrafica può maturare relazioni di familiarità con sistemi tecnici digitali e sviluppare abilità solitamente considerate appannaggio dei cosiddetti nativi digitali. Al punto da poter sviluppare anche dinamiche di abuso.
Dal punto di vista materiale, si tratta di sviluppare dinamiche di interazione diverse per quanto riguarda i mediatori tecnici chiamati in causa (cartine, software presentati da schermi digitali, volumi enciclopedici e così via), così come per le abilità richieste: leggere una cartina geografica, interagire con un software di navigazione o consultare un’enciclopedia cartacea. Non dipende dall’età, ma dalla motivazione, dall’occasione, dal contesto e così via.
In ogni caso, la delega all’operato dell’esperto, da temporanea e revocabile, tende a diventare delega all’operato dell’essere tecnico fissa e irrevocabile; anzi, delega continuamente reiterata e aumentata di grado e intensità, in un crescendo di alienazione tecnica. Questo avviene sotto una duplice pressione. Da una parte, per via delle caratteristiche intrinseche dei sistemi informatici attuali, frutto della predazione dissennata delle risorse (materie prime naturali e sfruttamento della manodopera ridotta a risorsa umana): questi sistemi mirano a riprodurre strutture operative e comunicative gerarchiche, implementate con modalità opache per l’utente e orientate all’estensione illimitata dei regimi di mercato. Dall’altra, per via della propensione al dominio maturata da alcuni millenni dagli esseri umani. Una propensione che si nutre non solo della brama di comando dispotico, ma anche e soprattutto del desiderio di sottomissione, dell’ansia di obbedire, della scarsa volontà di prendersi cura della faticosa gestione della tecnica.
Gli straordinari poteri che scaturiscono dall’interazione con gli esseri tecnici sono estremamente appetibili per chiunque, e sono facile preda di chi è in grado di assicurarsi l’obbedienza degli esperti che, dopotutto, sono pur sempre esseri umani. Così la gerarchia esistente si trova inequivocabilmente rafforzata ogni qual volta un esperto si conforma alle relazioni di comando/obbedienza; per converso, viene indebolita dal rifiuto degli esperti di collaborare al sistema di dominio esistente, ma può essere dissolta solo se molti più esseri umani si fanno carico del sistema tecnico, disertando le «normali» subordinazioni dispotiche.
In concreto, la delega tecnica tende a farsi alienazione tecnica strutturale nel caso del guasto, perché sono necessari diversi esperti per venire a capo del problema; esperti subordinati fra loro in sistemi gerarchici: lo abbiamo già visto nel caso dell’iPhone nel primo capitolo. Ma questo accade anche nel caso del funzionamento regolare. Questa percepita normalità della delega alienante è molto più grave dal punto di vista libertario. Quella che viene percepita come ovvia normalità è in effetti il prodotto dell’azione coordinata di un’enorme quantità di sistemi che richiedono una quantità straordinaria di controlli e monitoraggi (retroazioni cibernetiche) da parte di umani e non umani, ovvero cure specifiche da parte di esperti di vario tipo. Cure per i cavi sottomarini in fibra ottica percorsi dalla luce che, come abbiamo visto, costituiscono l’ossatura stessa della rete; cure per l’assemblaggio industriale dei dispositivi a partire da una miriade di componenti; cure necessarie per la programmazione dei software (dal codice sottostante fino alle interfacce utente), che consentono l’interazione umana; cure indispensabili per risolvere errori, effettuare aggiornamenti e regolari manutenzioni. Cure prodigate quasi sempre sotto l’egida di sistemi gerarchici per nulla disposti a lasciar spazio alla convivialità; cure obbligate dall’obsolescenza programmata dei sistemi, imposte come abitudine di co-dipendenza tossica dall’ignoranza e dalla noncuranza generalizzata.
La rete di Internet è molto più complessa di qualsiasi altra rete tecnica mai realizzata, più che altro perché tende a interagire in maniera sistemica con le reti già esistenti, inglobandole così in una rete più ampia: si pensi alle lavatrici «intelligenti» e agli altri dispositivi della cosiddetta Internet delle Cose (iot, Internet of Things), elettrodomestici e altri oggetti connessi in rete, gestibili da remoto. La delega strutturale ai tecnocrati sembra essere inevitabile, e in effetti lo è, almeno per come si è evoluta e strutturata oggi.
Delegare a livello tecnico significa investire qualcun altro della propria autorità nei confronti di quel sistema/strumento; significa dare ad altri il proprio potere. Nel caso dei computer è molto evidente: consegniamo le parole d’ordine, le password per accedere al dispositivo e poterlo comandare; al contempo, diamo mandato all’esperto di fare qualsiasi cosa sia necessaria per ripristinarne il funzionamento.
Gli esperti di organizzazioni gerarchiche spiegano come effettuare deleghe in maniera corretta, cioè, dal loro punto di vista, in modo da massimizzare l’effetto della delega stessa, per moltiplicare il potere diffuso e poterlo poi riassorbire, accumulandolo e rinsaldando in tal modo la gerarchia stessa, la lealtà nei confronti dell’autorità dei dominanti da parte dei subordinati. Nel caso della delega tecnica strutturale, la nostra domanda invece rimane: è possibile delegare bene, in senso libertario, cioè in modo da aumentare la diffusione del potere, della capacità di intervenire nella messa in opera di norme condivise, ma di evitare al contempo il fortificarsi delle relazioni di dominio?
La risposta breve è: sì, se riusciamo a far circolare la conoscenza, ovvero la linfa stessa che nutre le relazione all’interno di una rete. Dobbiamo ricordare che lo strumento è diverso dalla rete, il dispositivo non è la rete, e d’altra parte la rete si riconfigura continuamente, è un processo di ontogenesi, di creazione di esistenza incessante, proprio perché si evolve attraverso la selezione di caratteristiche reputate adatte. Ma al tempo stesso dobbiamo tenere presente che possiamo separare gli strumenti che compongono una rete solo in maniera astratta, per comodità di studio; lo stesso vale per la separazione netta fra elementi tecnici e umani che partecipano a una stessa rete.
Per delegare bene, è necessario che le conoscenze circolino il più possibile, non solo e non tanto come sapere astratto, applicabile a ogni situazione, ma come competenze di cui ci si può impratichire sotto forma di esperienze sempre e comunque uniche, individuali. Devono circolare anche (soprattutto!) quando sono spurie, incomplete e magari insoddisfacenti. Non dobbiamo perdere di vista il percorso; è fondamentale riuscire a goderci il viaggio e maturare l’abilità di cogliere il momento opportuno, il kairos come direbbero i filosofi antichi. Dobbiamo invece evitare di concentrarci sull’obiettivo e sul risultato atteso che, nei fatti, è piuttosto nebuloso e in ogni caso difficile da esprimere in maniera precisa senza sporcarsi le mani con la cura per e insieme agli esseri tecnici.
È fondamentale divertirsi, non prenderla troppo sul serio, altrimenti invece di un piacevole e appassionante convivio ci ritroveremo immersi in uno sfiancante sforzo per convincere, sopraffare, cooptare e sottomettere gli altri ai nostri obiettivi.
Al tempo stesso, è necessario evitare di contribuire ai sistemi tecnocratici esistenti, cosa che potrebbe sembrare in contraddizione con la libera circolazione delle conoscenze, ma che in realtà non lo è affatto. Libero non significa assolutamente libero, ma relativamente libero, in relazione a qualcosa e qualcuno. Non c’è libertà possibile senza condivisione del potere. Gli accumulatori seriali di potere, che forzano l’evoluzione tecnica nella direzione del dominio, ovvero i sistemi tecnoindustriali, vanno semplicemente disertati, abbandonati e distrutti.
Per rispondere in modo un poco più approfondito dovremo studiare come operano concretamente i sistemi tecnici dal punto di vista dell’evoluzione del comportamento umano, e dell’umano in genere.
Evoluzione: adattamento ed esattamento
Gli esseri umani convivono sul pianeta Terra con altri esseri, tra cui quelli tecnici. La storia della loro comune esistenza è la storia della loro co-evoluzione. Per immaginare come delegare bene, ammesso che sia possibile, dobbiamo innanzitutto delineare le loro modalità di interazione e di selezione delle caratteristiche reciprocamente desiderabili. In termini evolutivi, i caratteri vengono selezionati secondo due tipologie di processi, gli stessi che scandiscono l’evoluzione di tutti gli esseri sul pianeta: processi di adattamento e processi di esattamento (exaptation).
La modalità più nota è l’adattamento, di cui Darwin tratta estesamente nel suo capolavoro L’origine delle specie: si intende con adattamento l’adeguamento di un organismo, una specie o un sistema ambientale al modificarsi delle condizioni esterne. Gli umani si adattano anche agli strumenti tecnici, parte delle condizioni esterne, scaricando su di essi una parte dello sforzo. Nel caso degli utensili, come il martello, la pinza, la vanga, si tratta di uno sforzo fisico che viene ottimizzato tramite l’apprendimento di uno schema di interazione (martellare, pinzare, vangare).
L’apprendimento è sempre presente nell’interazione tecnica, e quindi c’è sempre un aspetto cognitivo. Ad esempio, invece di ricordare a memoria indirizzi e numeri di telefono (immagazzinandoli nel proprio corpo), li scriviamo sull’agenda; anzi, li digitiamo sull’agenda elettronica del cellulare. La fatica di ricordare viene delegata allo strumento, che assume un ruolo protesico, nel senso che funge da protesi mnemonica. In concreto, questa delega avviene attraverso la messa in atto di procedure di interazione con i dispositivi che tendono all’automatismo cognitivo. La procedura diventa automatica, non dobbiamo studiare ogni volta come interagire; perciò l’essere umano risparmia energie, delegando lo sforzo all’essere tecnico. Assumendo un automatismo comportamentale di delega nei confronti dell’essere tecnico, l’umano riduce in maniera drastica l’impegno delle proprie risorse cognitive.
Dal punto di vista che abbiamo adottato in questa ricerca, quello del potere, ciò significa che la capacità di formulare e applicare norme condivise viene delegata agli esseri tecnici. Almeno in parte, sono gli esseri tecnici a regolare i rapporti di convivenza fra gli esseri viventi e non. È necessario quindi comprendere in che modo avvenga questa delega capace di renderci più potenti.
Ci adattiamo alla bicicletta come all’automobile, alla tastiera meccanica come allo schermo tattile. Non c’è una differenza sostanziale nel caso degli esseri tecnici digitali. In tutti i casi, per tutti gli esseri viventi (non solo per gli esseri umani), l’adattamento procede dalla funzione all’organo. Lo si può rintracciare nell’evoluzione di ogni specie vivente, studiando la conformazione dei loro corpi e il modo in cui interagiscono, in particolare a livello di organi.
Grazie al pollice opponibile, gli umani sono in grado di afferrare in maniera efficace. I caratteri che hanno portato all’evoluzione del pollice sono stati selezionati in milioni di anni, perfezionando l’abilità di afferrare. Per portare a termine questa funzione è necessario compiere un certo lavoro, in greco antico ergon, che è svolto da un organo (organon in greco, ciò che svolge l’ergon, il lavoro; in latino organum, strumento, arnese), in questo caso la mano.
L’invenzione di dispositivi che facilitano la predisposizione ad afferrare mira a trasformare lo sforzo consapevole in procedure automatiche, senza bisogno di un lavoro cognitivo consapevole: si pensi ad esempio a tutti i tipi di maniglie e impugnature che gli oggetti possono avere. Quando afferriamo una caraffa per il manico non ci soffermiamo a riflettere sul significato di quell’ansa: la afferriamo e basta. Funzioniamo insieme alla caraffa e al suo manico. Il corpo ha interiorizzato i movimenti necessari all’esecuzione della sinfonia, viene eseguito lo spartito musicale che prevede l’intervento ritmato di diversi muscoli e tessuti in armonia con l’essere tecnico.
L’organo mano deve apprendere una serie di abilità e risulterà modificato da queste interazioni, perché imparerà ad afferrare in maniere differenti. Così la penna per scrivere è adatta alla mano, nelle sue varie versioni, dalla penna d’oca e calamaio alla penna a sfera; a sua volta, la mano si adatta alla penna esercitandosi a impugnarla per scrivere. Una volta imparato ad afferrare correttamente la penna, non abbiamo più bisogno di pensarci: seguiamo la procedura.
Le linee di produzione industriale integrano le procedure di automatismo cognitivo umano nella fabbricazione di oggetti identici, adattati all’interazione automatica; il che significa, dal punto di vista del complesso tecnico (composto almeno di robot industriali-designer-operai della linea), che l’obiettivo dell’automatismo tende a riflettersi sull’intero sistema produttivo, nella segmentazione e specializzazione delle singole operazioni tecniche, da parte di umani e non. Il risultato è, ad esempio, la produzione di bottiglie di plastica con un incavo, invece che semplicemente cilindriche. Questo tipo di bottiglia è appositamente studiata e realizzata per rendere più efficace la funzione di afferrare, perché l’ergonomia dell’oggetto lo permette, per cui si dice che possiede una certa affordance (permissività). L’ergonomia specifica letteralmente le regole del lavoro (ergon-nomos) da compiere.
Nell’esattamento (exaptation), al contrario, sono alcuni caratteri, o insiemi di caratteri organizzati come organi, a creare effetti prima inesistenti, cooptati per usi e funzioni prima inesistenti (o svolti in maniera differente). In termini generali, se l’adattamento consiste nell’elaborazione di strutture che permettono all’organismo di sopravvivere, o sopravvivere meglio, attraverso un lavorio lento, costante e graduale, l’esattamento è l’impiego da parte dell’organismo di strutture già esistenti per finalità diverse da quelle che le hanno generate.
Darwin aveva discusso già di pre-adattamento. Se per effetto della variazione casuale un individuo si trova a possedere caratteristiche che si rivelano utili per svolgere funzioni fino a quel momento impensate, quell’individuo avrà una fitness maggiore e una maggiore possibilità di riprodursi e trasmettere così le sue caratteristiche alla progenie. L’esattamento, per quanto abbia a che fare con la cooptazione di caratteri già esistenti per effetti inattesi, cioè per svolgere attività impreviste, è però qualcosa di più sofisticato rispetto al pre-adattamento darwiniano; soprattutto, non ha alcun riferimento teleologico, cioè non avviene per rispondere a un disegno predeterminato.
Uno degli esempi dei paleontologi Stephen J. Gould ed Elizabeth Vrba, che nel 1982 hanno coniato il termine exaptation, è l’ala negli uccelli. Questo organo aveva in origine una funzione termica. Nei rettili a sangue freddo serviva infatti ad aumentare la superficie del corpo e a immagazzinare maggior calore; la metamorfosi delle scaglie in piume aumentò l’isolamento termico. Ma poi, lentamente, quella membrana-termosifone divenne ala per volare in alcuni individui che si trovarono a esercitarla in quel senso, cioè a cooptare quell’organo per la nuova funzione «volare» invece di continuare a servirsene per la funzione per cui si era evoluta, cioè «regolare la temperatura»: l’esercizio e la cooptazione dell’organo hanno prodotto un effetto inatteso e creato una nuova funzione.
Tornando all’evoluzione tecnica della scrittura, possiamo individuare forme di adattamento alternate a forme di esattamento. Un esempio di esattamento: la funzione «lascia una traccia scritta della tua esistenza» non esisteva prima che la scrittura diventasse una consuetudine sociale, prima cioè che il potere derivato dalla co-esistenza fra esseri umani ed esseri tecnici dedicati alla scrittura (penne, carta per scrivere, quaderni, ecc.) si diffondesse al punto tale da esplicitarsi in norme condivise, come quella di lasciare diari personali, lettere, memorie scritte per le persone care. In qualche modo, la scrittura è una maniera per prolungare la vita dell’autore al di là della sua esistenza corporea attraverso il manufatto scritto. È un potere straordinario creato dalla tecnologia.
Esattamenti tossici di massa
Il caso delle tecnologie digitali di massa è molto più complesso, ma sostanzialmente analogo. Il concetto di esattamento applicato alle piattaforme digitali commerciali di massa ci permette di inquadrare in maniera più precisa la dinamica ricorsiva di comandi e regolazioni cibernetiche. Le retroazioni sistemiche nutrono il reciproco condizionamento fra esseri umani ed esseri tecnici. Un click genera un altro click e così via, strutturando lunghe catene di esattamenti tecnici. Questi esattamenti in effetti convocano insieme strutture sociali, abitudini personali e collettive, nonché strutture tecniche, per farle interagire secondo finalità diverse da quelle che le hanno generate. L’evoluzione dei sistemi interattivi viene forzata favorendo la ripetizione di procedure, sotto forma di comportamenti irriflessi, automatici.
Questi automatismi comportamentali sono assimilabili a rituali inconsapevoli. Ad esempio, rispondere all’«Alt, parola d’ordine»: fornire login e password, una procedura ripetuta in continuazione, cui gli umani sono ormai abituati nei sistemi tecnocratici. Eppure non sono operazioni anodine: declinare le generalità e comunicare una parola d’ordine indica chiaramente che stiamo entrando in una zona militarizzata, che non è casa nostra. Le procedure tipiche degli esattamenti tossici avvengono infatti all’interno dei cancelli digitali dei padroni della piattaforma.
La reiterazione delle medesime azioni e reazioni è assimilabile a schemi rituali che si svolgono secondo il ritmo dettato da regole algoritmiche altrui, e sotto l’attenta supervisione del sistema. Il monitoraggio mira sia a realizzare versioni successive sempre più condizionanti, sia a collezionare dati (e metadati) da vendere al miglior offerente sul mercato. La soddisfazione dell’utente è immediata, così come la sensazione di non averne abbastanza: a ogni click, post, notifica, corrisponde infatti una scarica a livello dei neurotrasmettitori che orchestrano le sensazioni del piacere nel corpo umano (in particolare la dopamina). Il risultato è la sottomissione pressoché immediata degli umani al sistema che credono di comandare; il che coincide con l’obbediente sottomissione al condizionamento patito dal proprio organismo, cioè corrisponde a un vero e proprio autoabuso.
In questa prospettiva è illuminante l’invio di un messaggio di Whatsapp, un’esperienza condivisa da miliardi di esseri umani più volte al giorno. Scomponiamo la procedura in azioni semplici, con le corrispondenti emozioni, per mostrare come si snoda l’articolazione liturgica del condizionamento digitale. Si vede così come specifici automatismi siano stati progettati nelle interfacce dei dispositivi tecnici per produrre corrispondenti automatismi comportamentali negli esseri umani che li adoperano, selezionando così tratti comuni di co-evoluzione tecnica.
L’invio di un messaggio: «Dove sei? Ti aspettavo alle sette!», è seguito da una spunta grigia visualizzata sullo schermo di chi invia («bene, è stato inviato» = sollievo; «ma quando arriverà?» = aspettativa, ansia); spunta che diventa azzurra quando il dispositivo del destinatario riceve il messaggio («ha ricevuto, era ora!» = sollievo; «ma quando lo leggerà?» = aspettativa, ansia), e quindi si raddoppia in una doppia spunta azzurra quando il destinatario visualizza il messaggio («ha letto, era ora!» = sollievo; «ma quando risponderà?» = aspettativa, ansia). Uno speculare ritmo d’interazione si instaura nel combinato disposto fra dispositivo ricevente e umano destinatario del messaggio, che a sua volta tenderà a rinforzare l’interazione dando il via a un nuovo ciclo. Vengono così selezionati comportamenti specifici e reazioni emotive ben definite, volte a perpetuare l’interazione, ancora e ancora. In barba alla sbandierata libertà di scelta.
Non ha senso quindi proporre di usare bene tecnologie del genere. Al massimo possiamo individuare quali sono i caratteri selezionati dal sistema e quindi cercare di smorzare, attenuare, controbilanciare gli effetti che riteniamo sgradevoli e indesiderabili. Ma questo sforzo comporterà un sostanziale disallineamento fra l’uso previsto del sistema e l’uso deviante che cerchiamo di farne strutturando l’interazione in maniera differente, per adattarla ai nostri fini. L’energia necessaria per compiere un’interazione sarà inevitabilmente maggiore, l’efficienza e l’efficacia saranno inferiori, la gratificazione complessiva risulterà minore.
Pensiamo ai gruppi di messaggistica: è facile constatare quanto l’abuso sia inscritto nella procedura stessa, che seleziona attivamente comportamenti abusivi. Ad esempio: rispondere immediatamente quasi senza leggere; reagire in maniera standardizzata tramite emoticon e simili; ritornare ossessivamente a porre domande la cui risposta si può trovare qualche messaggio prima nella lista; rendere complicata o faticosa o impossibile la ricerca nell’archivio dei messaggi; e così via. Avvalersi di un sistema del genere per attivare una riflessione ampia e condivisa non è impossibile in linea teorica, ma in pratica, considerate le caratteristiche specifiche del sistema e le modalità che favorisce, risulta estremamente faticoso e dispendioso.
Una sequenza calibrata, disegnata ad hoc da esperti, viene proposta in esclusiva per ogni umano disponibile all’interazione. Gli esperti al servizio di aziende che lucrano su ogni minimo movimento degli utenti appartengono a diverse tipologie: sono interaction designer, scienziati cognitivi, psicologi comportamentali, designer di interfacce, coder, ecc. Grazie al loro impegno, la procedura si dipana sempre uguale a sé stessa, eppure pronta ad accogliere «innovazioni» (cioè selezioni di caratteri ritenuti adeguati) per renderla ancora più appetibile, in una nuova versione «migliorata». Migliorare, dal punto di vista dell’esattamento tecnico industriale, significa immaginare e mettere a punto selezioni di caratteri per accelerare, prolungare e intensificare la durata degli scambi e il tempo complessivo trascorso dagli umani all’interno di quella dinamica interattiva tossica.
Tutte queste interazioni richiedono molta energia e un gran lavorio. Gli organi che svolgono il lavoro, però, sono solo in minima parte organi umani. Sono gli algoritmi, le interfacce e gli esperti di cui sopra che svolgono il lavoro liturgico, strutturando una gerarchia opaca; e tutti lavorano al servizio di aziende private (nel caso delle multinazionali) o di governi più o meno oppressivi (nel caso delle agenzie di intelligence). Le funzioni non pre-esistono, ma sono effetti prodotti attraverso interazioni pre-ordinate, restituite al corpo organico dell’utente sotto forma di misurazioni, che corrispondono alla quantificazione della sua esperienza.
Digressione etimologica: il significato originario di liturgia non era lontano da servizio pubblico. Viene dal greco leitos (pubblico, per il popolo) ed ergon (lavoro, servizio). In origine, come riferiscono anche Platone e Aristotele, erano dette liturgie tutte le opere pubbliche realizzate in pubblico per il bene pubblico. In seguito, nell’Atene classica, le liturgie sono state intese come forme di tassazione. Ad esempio, i cittadini benestanti finanziavano la rappresentazione pubblica di tragedie e drammi satireschi aperti a coloro che ne avevano diritto. Quelle liturgie erano appunto al servizio del pubblico.
Venticinque secoli più tardi, la situazione è sostanzialmente ribaltata: le liturgie operate da aziende private strutturano il mondo sociale pubblico. L’esperienza pubblica di Internet, e in particolare del web, si concretizza grazie agli algoritmi: sono queste le procedure che regolano il ritmo della liturgia digitale. Gli algoritmi fanno accadere le cose. Gli algoritmi di Alphabet servono i risultati pubblici del motore di ricerca Google, dei suggerimenti video di YouTube. Quelli di Facebook e Instagram servono gli aggiornamenti e le connessioni di Facebook e Instagram. Gli algoritmi di Amazon offrono suggerimenti sui libri che dovremmo leggere, e su tutto ciò che dovremmo acquistare. Quelli di Apple Store ci suggeriscono la musica da acquistare e ascoltare, così come mille altri servizi analoghi. Le piattaforme gestite da governi autoritari si comportano in maniera analoga. Queste liturgie tecniche, private o pubbliche, selezionano funzioni prima inesistenti.
La funzione «dì a tutti che sei fidanzata» (gay, confusa, triste, entusiasta…), con l’effetto gratificante, la sensazione di potere che comporta, non esisteva prima dell’avvento di Facebook. La funzione «mostra a tutti una foto che dimostri quanto ti stai divertendo con una frase memorabile che faccia schiattare d’invidia» non era nemmeno concepibile prima di Instagram. Per raggiungere un effetto vagamente paragonabile si sarebbe dovuto scrivere ad alcuni, parlare con altri, telefonare, scattare foto, stamparle, inviarle, farle pubblicare su giornali o riviste e così via. Si sarebbe dovuta organizzare una rete di competenze e di esperti in grado di supportare e mettere in opera quella funzione con organi adeguati.
Ora invece questo potere è alla portata di tutti, perché la funzione è disponibile a chiunque possieda un profilo su Facebook, Instagram o altre piattaforme a seconda di quel che desidera ottenere, automaticamente. Il costo cognitivo di questa funzione è prossimo allo zero. Anche se riuscire bene non è facile: bisogna allenarsi molto e impegnarsi per diventare capaci al gioco social, non è affatto banale. Ma questa fatica richiesta dall’apprendistato del sistema tecnico è radicalmente diversa dai tipi tradizionali di apprendistato. Invece di sforzarsi per organizzare un’interazione complessa con molti altri umani tramite la chiamata in causa di tanti dispositivi e l’impiego di tante competenze, l’individuo trae da questa attività piacere immediato, chimico, sotto forma di secrezione di dopamina endogena. Il neurotrasmettitore viene secreto a livello cerebrale durante l’interazione con la piattaforma stessa, favorito dalla piattaforma. Quest’ultima si fa carico di gran parte del lavoro, mettendo a disposizione i propri organi digitali. Organi assai concreti e per nulla smaterializzati, come abbiamo visto studiando la struttura dell’Internet globale con i suoi cavi sottomarini.
Per essere parte integrante di queste nuove Megamacchine, gli umani devono solo fare click, con il pollice se hanno uno smartphone. O con un altro organo adattato alla funzione, piegato all’interesse interattivo iscritto nel sistema, profondendo ancora minor energia – ad esempio la voce: «Alexa, invia la foto!» – oppure adeguati movimenti oculari, o ancora semplice presentazione del viso alla telecamera, per effettuare un pagamento tramite riconoscimento facciale. In ogni caso devono assoggettarsi a una procedura che non hanno deciso, cioè adeguarsi a una norma che non hanno contribuito a definire. Seguono le tracce algoritmiche dell’interfaccia tecnica, ne interiorizzano il ritmo fino a che diventa un automatismo comportamentale.
Sistemi di addestramento
Per favorire l’instaurazione della norma procedurale, le interfacce tendono a essere gamificate, cioè a incorporare schemi di gioco competitivo in sistemi che non si presentano esplicitamente come giochi. Questi schemi si manifestano sotto forma di punti, classifiche, badge, notifiche, jingle e così via. L’interazione tecnica assume allora la forma di giochi seriali, ripetitivi e competitivi che risultano estremamente piacevoli per gli esseri umani, poiché ogni azione e reazione scatena scariche ormonali che sollecitano il circuito dopaminergico, responsabile delle sensazioni di piacere. Ricevere un like è letteralmente un’iniezione di dopamina endogena, un neurotrasmettitore dagli effetti analoghi agli oppiacei.
La letteratura sull’addestramento comportamentale tramite la messa a punto di interfacce altamente gamificate è vasta e ramificata. In genere la gamificazione viene presentata come la panacea per le istituzioni che vogliono attirare i cittadini e coinvolgerli in attività di partecipazione, ma anche per gli insegnanti che vogliono rendere più accattivanti le loro lezioni, per i manager che vogliono migliorare i rendimenti aziendali, per i venditori che vogliono aumentare le vendite, e insomma per chiunque desideri aumentare, intensificare e rendere più rapide le interazioni con il proprio pubblico.
Per inciso, notiamo che questo genere di interazioni tende ad azzerare le dimensioni etiche ed estetiche. Sono basate su sistemi di gratificazione premiale ispirati al condizionamento operante scoperto da B.F. Skinner negli anni Trenta del xx secolo. Anche se agli umani piace pensare di decidere in maniera autonoma delle loro interazioni tecniche, in realtà nei sistemi gamificati odierni tendono ad adeguarsi allo schema di godimento chimico pre-ordinato nel sistema stesso. Questo tipo di co-evoluzione tecnica seleziona tratti di comportamento abusante, al punto che l’umano si dimentica del proprio corpo, perso nel flusso del circuito dopaminergico.
Siamo tutti sensibili al condizionamento operante. Adolescenti, adulti e bambini, a prescindere dalle convinzioni politiche, dal credo religioso, dall’orientamento sessuale, dal genere, dal livello di educazione, ricchi o poveri che siamo, tutti rimaniamo presi nella rete. Tutti gli umani dotati di cervello, occhi e sistema nervoso sono soggetti all’addestramento cognitivo premiale. Tutti tendiamo a reagire con scatti d’ira quando ci viene sottratto lo schermo magico: logico e fisiologico, ci stanno togliendo la nostra fonte di piacere! Tutti tendiamo ad astrarci dal contesto ambientale, ad attivare disattenzione selettiva nei riguardi degli stimoli non visivi: per questo il bambino o l’adulto che sia, incantato dallo schermo, non sente quando viene chiamato, non reagisce quando viene toccato, ma si irrita quando gli viene spento il richiamo visivo. Provate anche solo a passare una mano davanti agli occhi di una persona intenta a interagire con il suo schermo: la reazione sarà come minimo di irritazione.
Non è casuale, né (quasi mai) consapevole. Accade perché le strutture gamificate aiutano a implementare funzioni nuove tramite esattamenti tecnici, sfruttando gli effetti di gratificazione endogena legati alla stimolazione del sistema dopaminergico. La selezione dispotica viene adeguata alla tirannide premiale, più efficace rispetto alla tirannide punitiva. Invece di retribuire lo sforzo del lavoratore con un salario più o meno misero, ma comunque strutturalmente inadeguato, si retribuisce lo sforzo del giocatore che partecipa all’ambiente gamificato, stimolando nel suo corpo la secrezione di neurotrasmettitori legati alla percezione di piacere.
Riporto un esempio di esattamento tecnico tossico che mi tocca da vicino. La funzione «scopri quante copie hai venduto del tuo libro» era di fatto inesistente prima di Amazon. Un autore doveva chiedere all’editore quante copie aveva venduto. L’editore tipicamente accampava difficoltà dovute al complesso sistema di distribuzione, promozione e vendita. Di fatto, l’autore doveva fidarsi dei rendiconti, disponibili solo molti mesi dopo la pubblicazione. In ogni caso si vedeva obbligato a profondere un notevole sforzo cognitivo e relazionale, organizzando interazioni complesse con diplomazia, per ottenere risultati comunque dubbi. Amazon invece ci permette di sapere immediatamente a che punto siamo nella classifica di vendita su Amazon, senza alcuno sforzo a parte leggere. Ho visto autori controllare freneticamente, ogni pochi minuti, la loro prestazione su Amazon, scorrendo avidamente i numeri che classificavano i loro libri. Ho visto autori, altrimenti composti, succubi di una ridicola, patetica ricerca di conferma da parte della piattaforma. Sono stato tentato e spesso ho ceduto al desiderio di sapere come stava andando il mio libro, o quello di qualcun altro.
Un sistema capace di gratificare automaticamente l’umano tramite l’interfaccia gamificata rimpiazza, mediante accurata selezione di caratteristiche tecniche, la fatica di organizzare in maniera autonoma (ma condivisa con altri) una conoscenza complessa. Il costo di un automatismo tossico eteronomo, frutto di delega cognitiva cieca, è il suo carattere effimero: per questo il controllo viene eseguito ancora e ancora, per reiterare quella sensazione di piacere a prescindere dall’informazione acquisita. La soddisfazione della richiesta iniziale non è prevista perché lo scopo del gioco è protrarsi all’infinito, in una ripetizione senza fine di gesti automatici.
Questo effetto gratificante tramite la funzione «classifica» di Amazon risponde a una logica precisa, evidente nei numeri presentati, che ovviamente non sono neutri: ci viene fornito il posizionamento del testo relativo alle vendite di altri libri, eventualmente suddivisi per categorie, e non il numero di copie vendute (a meno di avere accesso a funzionalità avanzate per vendere sulla piattaforma, ma in ogni caso parliamo solo delle copie vendute tramite quel canale). La funzione creata dagli organi di Amazon è gamificata, cioè risponde a uno schema di gioco competitivo inserito in un sistema che non si presenta esplicitamente come un gioco: è una classifica, prevede strutturalmente la competizione, i premi e così via.
Si potrebbero portare molti altri esempi, ma il ragionamento di fondo è delineato. L’informatica commerciale di massa genera gigantesche catene di esattamenti tossici, cui gli umani tendono ad adattarsi supinamente per comodità ma soprattutto perché ne ricavano piacere chimico endogeno nel corso di ogni singola interazione.
In questo modo, funzioni prima inesistenti diventano vitali non appena vengono resi disponibili i mezzi tecnici per soddisfarle. Diventa vitale sapere dove stanno i nostri amici, partner, familiari; cosa stanno facendo e con chi, in ogni momento, pena l’instaurarsi di un’insopportabile irrequietezza che facilmente sconfina nell’ansia e nell’angoscia.
Il sistema delle notifiche, in perenne evoluzione, è il corollario dell’addestramento cognitivo, perché favorisce la ripetizione procedurale, la reiterazione e interiorizzazione di azioni semplici organizzate in catene comportamentali complesse. Le notifiche servono a mantenere un certo livello di attenzione: compito non banale, perché un eccesso di notifiche provoca sovraccarico e frustrazione, mentre una carenza lascia spazio ad altri stimoli pronti ad attirare l’attenzione umana, vorace di stimoli capaci di eccitare il circuito dopaminergico.
Infatti, al fine di calibrare l’attenzione richiesta nell’interazione bisogna anche tener conto dell’investimento cognitivo per immaginare ciò che potrebbe accadere nell’interazione, come abbiamo visto con le notifiche di Whatsapp che consentono di sapere se l’altro ha visionato il nostro messaggio. Questo determina la messa in opera di sistemi di controllo reciproco anche molto sofisticati a livello di relazione fra umani.
Per svelare i meccanismi di asservimento sottostanti ai sistemi tecnocratici non è necessaria alcuna conoscenza dall’interno del sistema stesso, ovvero non c’è bisogno del contributo di qualche ex-sviluppatore, ex-collaboratore o ex-manager pentito. Come nella paleontologia classica, le forme degli organismi contengono in sé la storia della loro co-evoluzione con l’ambiente circostante, così nello studio delle interazioni tecnocratiche è possibile rinvenire le tracce di esattamenti e adattamenti orientati al dominio nella forma, funzionamento e caratteri degli organismi umani coinvolti, e parallelamente nella forma, funzionamento e caratteri degli esseri tecnici implicati. In particolare nei momenti di crisi relazionale, che spesso coincidono con i guasti, è possibile osservare l’articolazione dei flussi di potere tecnici ed eventualmente intervenire per ri-orientare l’evoluzione.
Sistemi di delega strutturale
Non è possibile effettuare deleghe temporanee, consapevoli, libere e revocabili quando ci si trova immersi in sistemi di esattamento orientati al dominio e strutturati a livello globale. Il problema non sta nell’esattamento di per sé, che, come abbiamo visto, è una delle modalità con cui l’evoluzione si realizza nella storia concreta degli esseri viventi (e non viventi). Il problema sta invece nelle modalità organizzative degli esattamenti tecnici industriali, che sono intrinsecamente gerarchiche e votate all’estensione del dominio. Come possiamo affidare le nostre relazioni a sistemi di cui non sappiamo praticamente nulla, sui quali non esercitiamo alcun potere reale? Non abbiamo contribuito alla produzione delle norme che regolano le interazioni tecniche, e non abbiamo alcun potere. Ma il potere è proprio quello che ci serve per cambiare le cose.
Abbiamo bisogno di recuperare spazio di manovra, agio, spensieratezza nell’avere a che fare con i sistemi tecnici, senza doversi costantemente preoccupare che la nostra riservatezza venga violata, che malintenzionati possano spiare, monitorare e carpire ogni nostro movimento, che le piattaforme del dominio stiano manipolando il nostro comportamento a scopo di lucro. Ma tutto questo è impossibile fino a quando rimarremo intrappolati in sistemi industriali che prevedono una delega strutturale continuamente reiterata in cambio di ricompense dopaminiche. Fino a quando avrà la meglio la comodità della situazione di comando in cui apparentemente ci troviamo, quando invece siamo ingranaggi degli esattamenti tecnici intenti a schiacciare bottoni che non abbiamo progettato e che scatenano meccanismi sociotecnici di cui non ci prendiamo cura. Fino a quando sceglieremo, acquiescenti, la comodità della situazione di obbedienza quotidiana, obbedienza all’impulso di consultare il nostro cellulare, obbedienza alla coazione di ripetere ancora e ancora gesti studiati per provocare un piacere tanto effimero quanto tossico.
In che modo e per quale ragione gli esattamenti tecnici calati dall’alto, come quelli delle piattaforme commerciali di massa, hanno così facile presa sugli esseri umani? La ragione principale, se osserviamo le interazioni concrete, è che ci concentriamo sul contenuto e non badiamo alla procedura, alla forma, al metodo dell’interazione con l’essere tecnico.
Nelle formule di delega ricorrono spesso espressioni come: «Ho altro da fare, non posso occuparmi (anche) di questo, del meccanismo, di come funziona; mi serve che funzioni e basta!».
Con circe mi occupo fra l’altro di pedagogia hacker, cioè di diffondere l’attitudine hacker in attività educative e (auto)formative; un approccio curioso nei confronti degli esseri tecnici grazie al quale ci osserviamo interagire e cerchiamo di individuare le nostre vulnerabilità, messe in evidenza dagli esseri tecnici stessi. Per imparare poi a prendercene cura, insieme, insegnandoci reciprocamente come fare, senza deleghe strutturali e irrevocabili, senza trascurare i dettagli in cui si svela spesso la sostanza della delega tecnocratica.
Quando gli insegnanti si rivolgono a noi, sconsolati dalla Didattica a Distanza, afflitti dalle storture dei sistemi tecnici imposti da istituzioni miopi o francamente corrotte, affaticati dalla necessità di adattare le proprie lezioni a sedicenti «innovazioni» tecniche… spesso ci chiedono di far funzionare quello che non va, di metterli in condizioni di fare il loro lavoro. Questa pur comprensibile esigenza purtroppo quasi sempre coincide con una richiesta di occuparci del sistema tecnico attorno a loro. Come se fosse slegato, indipendente da quello che insegnano.
Così facendo scompare l’essere tecnico, ridotto a oggetto, anzi a ingranaggio invisibile di un sistema che «funziona» per consentire ai contenuti, alle intenzioni, ai desideri degli umani di fluire liberamente, senza attriti, senza frizioni. Al contrario, l’elemento tecnico dev’essere quanto più presente possibile, comprensibile nei suoi comportamenti, visibile con le sue idiosincrasie che si intersecano con le nostre idiosincrasie umane, evidente nei momenti di attrito e frizione con l’umano.
La prima cosa allora è insegnare (insegnarci reciprocamente) a disimparare quello che diamo per scontato, e cioè che la tecnica sia un mero supporto neutro per i nostri contenuti, per la disciplina che trasmetteremo agli allievi (ma anche ai figli, ai dipendenti, agli altri in genere). La seconda è convincere (convincerci reciprocamente) che è possibile ristrutturare le relazioni tecniche in senso conviviale, proprio come in un banchetto in cui ognuno contribuisce alla comune riuscita.
La domanda «condizionamento reciproco o mutuo appoggio» cui avremmo dovuto rispondere in questo capitolo è rimasta sostanzialmente intatta, almeno dal punto di vista delle proposte. Abbiamo però compreso a grandi linee come funziona la delega tecnocratica e perché, approfondendo il baratro dell’alienazione tecnica. Rimane da capire come evitarla.
La prima via da esplorare è quella della riduzione di scala, che Ivan Illich proponeva già nel suo La convivialità, divulgata spesso con l’espressione «piccolo è bello». Vedremo che senz’altro la grande scala tende a strutturarsi in maniera gerarchica, ma in realtà la piccola scala non è necessariamente un vantaggio; dovremo quindi capire come e se è possibile adeguarla al mondo delle reti digitali globali.
Uno dei miti da smontare è quello primitivista del «si stava meglio prima». Il lavoro e la fatica possono essere condivise con gli esseri tecnici, in rapporti di libera collaborazione; ma non esiste un’epoca mitica in cui gli umani vivevano nel giardino dell’Eden. La storia umana non è necessariamente progressiva né regressiva, è semplicemente la storia delle loro relazioni di potere con gli esseri con cui convivono: protozoi, cromisti, funghi, piante, animali, batteri, archeobatteri. Ed esseri tecnici. Relazioni quasi sempre d’oppressione, ma solo per scelta e comodità vigliacca, non per necessità intrinseca nella storia. Il futuro non è scritto da nessuna parte.
Abbiamo sommariamente illustrato perché l’idea che è «meglio stare all’aria aperta», o che i dispositivi digitali «rendono stupidi», è conservatrice quando non reazionaria. In poche parole, il condizionamento operante funziona sui piccioni, sui ratti e anche sugli esseri umani, come hanno dimostrato gli esperimenti di B.F. Skinner fin dagli anni Trenta del xx secolo. Questo significa che la soddisfazione derivante dal piacere tossico dei sistemi gamificati è più intensa e coinvolgente di una passeggiata in un parco. È il caso delle piattaforme digitali di massa, in cui siamo impegnati in schemi di gioco senza renderci nemmeno conto che ci troviamo all’interno di giochi competitivi. Dare degli stupidi agli umani che se la godono, impegnati ad autosomministrarsi scariche di neurotrasmettitori, significa ignorare i meccanismi basilari delle interazioni effettive e derubricarle a sciocchezze.
Ma questo non significa che siamo condannati allo status quo. Si possono progettare e realizzare macchine aperte, di cui si vede e capisce il funzionamento, e non opache e incomprensibili. Macchine che possono aiutarci a realizzare quello che ci piace, ammesso che si sia capaci di esprimerlo in maniera comprensibile e si sappia applicarlo in esperienze e apprendimenti significativi. Macchine non totalmente automatizzate in maniera predeterminata, ma con margini di libertà, dal comportamento indeterminato. Possiamo riusare e riutilizzare alcune delle macchine esistenti, sottraendole alle strutture di dominio in cui sono immerse insieme a noi. Questo è possibile se siamo innanzitutto in grado di non collaborare con i sistemi gerarchici organizzati, di disertare la tecnica dominante, di dire «preferirei di no», con gentilezza ma anche con fermezza.
Ma soprattutto dobbiamo escogitare metodi di collaborazione conviviale, concreti e semplici da mettere in atto. Per farlo dobbiamo imparare a selezionare le caratteristiche adeguate a sviluppare convivialità sia negli esseri umani, sia negli esseri tecnici.
Nota al capitolo
1. «Scienza e scientismo», in Michail Bakunin La libertà degli uguali, elèuthera, Milano, 2017, p. 135.
capitolo quarto
Questioni di scala
Dinamica dell’evoluzione tecnica fra scala industriale e scala conviviale. L’evoluzione della rete di Internet, dal decentramento orizzontale all’accentramento verticale. I concetti di scala conviviale e Megamacchina rivisti e tradotti in ambito digitale. Appunti per un’informatica libertaria: oltre la coerenza mezzi-fini, o il come deve giustificare il cosa. Ingredienti: prossimità, affinità, federazione.
L’evoluzione tecnica fra industriale e conviviale
L’evoluzione degli organismi viventi si gioca sull’alternanza delle dinamiche di adattamento ed esattamento. Abbiamo mostrato per sommi capi come queste stesse dinamiche siano all’opera anche nella selezione sottesa all’evoluzione delle interazioni fra esseri umani ed esseri tecnici.
Finora però gli esseri tecnici sono rimasti un po’ nell’ombra, schiacciati fra esperti, comuni mortali, deleghe, adattamenti, esattamenti e così via, sempre sull’orlo di una crisi di nervi umana di cui sono il capro espiatorio designato. La loro esistenza tende a palesarsi quando non funzionano a dovere, non rispondono ai comandi, alle aspettative umane.
Quando comincia l’evoluzione degli esseri tecnici? Quando nascono le macchine, e perché?
Si dice che gli arnesi, gli strumenti manipolabili e infine le macchine siano state inventate per alleviare le fatiche umane. Invece di scavare con gli arti di cui è dotato, l’umano maneggia una pala e scava più in fretta; ancora più velocemente manovrando un’escavatrice, e con molta meno fatica.
Orchestrando un plotone di escavatrici comandate da umani addestrati a farlo in maniera semi-automatica, secondo un piano prestabilito, è possibile portare a termine opere immani in tempi minimi rispetto all’impiego di forze lavoro tradizionali. Allo stesso modo, invece di camminare, l’umano pedala sulla sua bicicletta, guida la sua automobile, barca, aereo, e può così coprire distanze inimmaginabili senza l’ausilio delle macchine, anche in ambienti altrimenti ostili come l’aria o l’acqua.
Orchestrando plotoni di mezzi di trasporto che viaggiano su reti interconnesse fra loro, comandati da umani addestrati a farlo in maniera semi-automatica (piloti di aerei, comandanti di navi, capotreni, ecc.), è possibile decidere di fare un salto dall’altra parte del mondo con un preavviso minimo, senza saper nulla di come funzionano quei complessi sistemi tecnici.
A due condizioni, per nulla scontate: in primo luogo, si deve disporre dei mezzi economici per poterselo permettere e liberarsi per il tempo necessario; in secondo luogo, si deve disporre di documenti d’identità adatti, cioè che ci conferiscano un’identità privilegiata dal punto di vista della possibilità di attraversare le frontiere immaginarie che distinguono gli Stati. Fra l’altro, va notato che la ragione ultima di un numero non esiguo di spostamenti e viaggi per motivi di svago è da ricondurre al condizionamento esercitato dal sistema pubblicitario, capace di proporre occasioni «irrinunciabili» all’attento consumatore umano.
Come è stato possibile che le macchine, da serve fedeli fabbricate per realizzare i desideri umani, siano diventate il fulcro dei sistemi di asservimento contemporanei, i mezzi della predazione industriale e dello sfruttamento globale a tutti i livelli, compreso quello esercitato dall’individuo su sé stesso? Per scoprirlo, continuiamo a studiare la rete di Internet, cui abbiamo già fatto ricorso per mostrare la materialità della tecnica e la straordinaria complessità delle sue manifestazioni odierne.
L’evoluzione della rete di Internet
La rete di Internet si è evoluta a partire da un sistema aperto e altamente decentralizzato fino a trasformarsi in un sistema molto centralizzato, soggetto a sorveglianza diffusa, censura e manipolazione su larga scala, da parte di imprese commerciali e istituzioni governative. Concepita come parte di un programma militare negli anni Cinquanta del xx secolo, è stata progettata per essere estremamente flessibile e adattabile, ovvero resiliente in caso di attacchi.
Una caratteristica teorica basilare è il principio end-to-end, «da un capo all’altro»: la rete si deve comportare come un «banale tubo» che trasferisce pacchetti di informazioni da una parte all’altra, cercando sempre di trovare il percorso migliore dalla sorgente alla destinazione per ogni pacchetto. Si differenzia così dal modello tradizionale delle telecomunicazioni, per cui si effettua una «connessione» o un «circuito» preferenziale e stabile attraverso cui scorrono tutti i pacchetti.
La rete distribuita è composta da diversi sistemi autonomi, liberi di interconnettersi (operando secondo i rispettivi vincoli strutturali) e di condividere le informazioni necessarie per calcolare i percorsi più appropriati per inviare e ricevere i pacchetti di dati. Questo contratto piuttosto approssimativo fra entità indipendenti è stato parzialmente formalizzato con il principio della neutralità della rete. Tutti i pacchetti di dati che attraversano la rete dovrebbero essere trattati allo stesso modo in termini di urgenza, indipendentemente dalla loro origine o destinazione.
In teoria ciò consente a chiunque si colleghi alla rete di agire, aiutarsi reciprocamente e anche di competere su un piano di parità: premesse indispensabili per la sperimentazione e l’innovazione, cioè per l’evoluzione di caratteristiche, funzioni e servizi desiderabili. La posta elettronica, uno dei servizi Internet più antichi e popolari, inizialmente è stato distribuito tra diversi server di posta elettronica operativi in luoghi diversi, in genere le università. Tuttavia, con l’aumento degli utenti di Internet, i servizi sono diventati sempre più centralizzati e la partecipazione delle persone online sempre meno anonima. Fra le cause possiamo annoverare i rilevanti vincoli fisici dell’infrastruttura (in particolare la bassa velocità di connessione e la larghezza di banda asimmetrica, cioè maggiore in download e minore in upload), le economie di scala, i tentativi di prevenire gli abusi.
Per rimanere all’esempio della posta elettronica, una percentuale molto elevata del traffico e-mail mondiale passa attualmente (2022) attraverso i server Gmail di Google, i cui agenti algoritmici analizzano il contenuto delle e-mail per sviluppare questo e altri servizi della multinazionale. Ad esempio, immagazzinare i testi e-mail scritti da esseri umani costituisce un’indispensabile base di dati per allenare modelli di scrittura automatizzata capaci di mimare gli agenti umani, cioè per sviluppare le cosiddette Intelligenze Artificiali. Gli algoritmi di Gmail effettuano anche molte altre operazioni: ad esempio, definiscono de facto ciò che è spam e ciò che non lo è; stabiliscono correlazioni con altre informazioni personali di mittenti e riceventi, come le posizioni gps registrate da Google Maps, query di ricerca, e altro ancora.
Le piattaforme Internet globali, commerciali e governative, mediano una quota parte sempre più preponderante delle comunicazioni quotidiane della popolazione umana attraverso le loro infrastrutture. Questo avviene a prescindere dalle scelte operate dai singoli esseri umani e da comunità autogestite di vario tipo, che potrebbero anche decidere di costruirsi i propri servizi (e non di rado lo fanno), ma non per questo sono al riparo dalla mediazione delle piattaforme globali. Le macchine al loro servizio, gli algoritmi implementati e continuamente «migliorati» dai loro ingegneri, diventano così sempre più efficienti nella gestione di grandi quantità di informazioni. Al contempo, queste stesse piattaforme diventano sempre più esperte nella progettazione dell’interazione con l’utente, aumentando a dismisura la loro «appiccicosità» (stickyness), ovvero la capacità di mantenere l’utente agganciato, determinandone il coinvolgimento (engagement) in termini di metrica delle prestazioni. Ciò rende i loro utenti sempre più dipendenti e assuefatti ai loro servizi, soggetti a manipolazioni e sfruttamento a fini commerciali e politici.
Questa situazione presenta i tratti di una «seconda soglia di mutazione» di Internet, secondo la terminologia introdotta da Ivan Illich nel suo La convivialità per l’analisi del ciclo di vita degli strumenti. Come nei casi illiciani della medicina e dell’istruzione, Internet nelle sue fasi iniziali è stata estremamente utile ed è stata cooptata da molti gruppi umani decisi a usarla per aumentare la libertà reciproca, sviluppando caratteristiche tipiche dei sistemi di mutuo appoggio: federazione di servizi, aiuto reciproco, condivisione di risorse e così via. Tutto questo nonostante l’origine non certo conviviale ed emancipatoria di Internet stessa, derivata da un programma di difesa militare e implementata con dispositivi ottenuti con lo sfruttamento industriale delle risorse naturali e umane. Uno degli effetti desiderabili di Internet, almeno inizialmente, è stato aumentare, facilitare e migliorare drasticamente l’accesso alla conoscenza e alle persone fra loro, potenzialmente in tutto il mondo.
Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, l’evoluzione della rete si è affidata a grandi organizzazioni che offrono servizi efficienti e affidabili. La sopravvivenza di questi servizi e piattaforme dipende sempre più dalla partecipazione delle persone e dallo sfruttamento dei (meta)dati che esse producono. Questo crea un circolo vizioso tra le pratiche di design che creano abuso/dipendenza e la concorrenza sleale che viola il principio di neutralità della rete; per non parlare degli usi non etici di informazioni riguardo a comportamenti privati degli umani, attraverso l’analisi dei dati prodotti dalle nostre attività online quotidiane.
Oltre alle enormi implicazioni sociali, politiche ed economiche della centralizzazione del potere su Internet vi sono anche importanti conseguenze ecologiche. Di primo acchito sembrano essere conseguenze positive. La centralizzazione delle piattaforme online ha permesso ai proprietari di costruire enormi data center, specialmente in climi freddi, e di investire in tecnologie di raffreddamento dei server a costi energetici inferiori per via delle economie di scala. Ma contemporaneamente l’obiettivo principale delle piattaforme online è la massimizzazione del tempo totale trascorso online e della quantità di informazioni scambiate, non solo tra le persone ma anche tra le cose, gli oggetti connessi fra loro, e quindi l’aumento a ogni costo delle interazioni. La redditività di queste piattaforme dipende dall’elaborazione di enormi quantità di informazioni in grado di produrre previsioni statisticamente rilevanti, da vendere a inserzionisti pubblicitari così come a politici e a qualunque altro cliente.
Proprio come le aziende farmaceutiche e le scuole descritte da Illich, le piattaforme digitali globali creano e mantengono un mondo in cui sono assolutamente necessarie. Questo spiega anche perché aziende come Facebook (Meta), Google (Alphabet) e Microsoft sono in prima linea negli sforzi per fornire un «accesso Internet a tutti» e perché allo stesso tempo le comunità locali devono affrontare così tanti ostacoli economici, politici e legali per costruire, mantenere e controllare le proprie infrastrutture.
È urgente riflettere su quali di questi servizi debbano essere realmente offerti da piattaforme globali e quali invece possano essere ospitati su infrastrutture locali, di proprietà delle comunità locali di utenti e gestite dalle comunità stesse. Questo esercizio non è motivato da un romantico ideale del genere «piccolo è bello» o «locale è meglio», ma dalla necessità di diversificare le modalità con cui le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (tic) mediano la nostra vita quotidiana.
La ragione profonda è ecologica: così come gli organismi viventi possono essere minacciati dalla mancanza di biodiversità, è ragionevole supporre che la capacità di autodeterminazione e in generale di scelta libera e consapevole sarà sempre più in pericolo con la diminuzione della biodiversità della rete. In questo caso, aumentare la biodiversità, ovvero la tecnodiversità, significa maggiore varietà di sistemi d’interazione, di procedure operative, di algoritmi, di servizi implementati, di tipologie di organizzazione delle interazioni fra esseri umani ed esseri tecnici. Il contrario di diversità biotecnica è invece uniformazione, standardizzazione coatta frutto di accordi opachi fra tecnocrati; impiego delle medesime strutture gerarchiche per rispondere a esigenze differenti, in tutte le lingue, a tutte le latitudini; imposizione di procedure identiche a tutti, mediante una quota crescente di modelli premiali gamificati in cui si premia (con classifiche, badge, punti, like e altri segnali di ricompense chimiche) la partecipazione al Grande Gioco della Piattaforma di turno.
Gli esseri umani connessi alla rete di Internet nel 2022 raramente scelgono con quali esseri tecnici interagire e come; si trovano obbligati (volenti o nolenti) a imparare sequenze di comandi per poter effettuare operazioni banali. Devono imparare a comandare esseri tecnici presentati come servi(zi) inevitabili per vivere nel mondo, ineludibili forche caudine cui sottoporsi, cui obbedire. Imparare a comandare, imparare a obbedire. Anche i più ritrosi devono fare buon viso a cattivo gioco e impegnarsi per farsi amiche le tecnologie digitali, o almeno per evitare di irritarle e scatenarne così il potere distruttivo, con conseguente perdita di dati, preclusione di accesso a servizi essenziali (scuola, sanità, lavoro, ecc.), diffusione non voluta di informazioni riservate e così via. Non stupisce l’aumento esponenziale dell’alienazione tecnica, palese nel periodo della pandemia di covid-19, durante la quale la tanto decantata informatizzazione di scuole, aziende e servizi pubblici si è perlopiù concretizzata in deleghe tecnocratiche alle piattaforme dell’Internet globale, ben felici di essere chiamate a «risolvere» i problemi.
La diversità biotecnica delle reti è importante non solo per ragioni di amministrazione (governance) democratica e di indipendenza, ma soprattutto per motivi di sostenibilità psichica, sociale, economica ed ecologica a lungo termine1.
Questioni di scala?
La questione principale, se seguiamo il ragionamento di Ivan Illich, è la scala. Uno strumento conviviale è l’opposto di uno strumento industriale, e la scala fa la differenza. A suo parere, su scala globale possono esistere solo strumenti industriali oppressivi. Nel paragone fra la bicicletta (conviviale) e l’automobile (industriale) in quanto mezzi di locomozione, Illich mostra che, al di sopra di una certa soglia, una tecnologia diventa inutile e diventa rapidamente nociva al crescere della scala.
Così l’automobile, inventata per facilitare e potenziare la mobilità individuale degli esseri umani, diventa inutile quando le automobili si moltiplicano oltre una certa soglia, perché si genera traffico che rallenta la circolazione, consumando al contempo suolo per far spazio a strade e autostrade. Diventa poi nociva al di là di una seconda soglia di mutazione della tecnologia stessa, quando la scala aumenta al punto tale che le automobili, ormai eccessivamente numerose, diventano nocive per la salute delle persone per via dell’inquinamento atmosferico dovuto ai gas di scarico; nocive per il pianeta Terra anche per via del consumo abnorme di risorse non rinnovabili (petrolio, metalli, ecc.); nocive a livello sociale perché implicano la messa in opera di linee di produzione industriali che sfruttano la manodopera umana. Oltre a questo, l’originaria potenza del mezzo automobile risulta del tutto obnubilata perché nelle città ipertrafficate è impossibile circolare con l’automobile, e ancor di più trovare parcheggio. Questa controproduttività industriale è una questione di scala.
Ma la scala quantitativa non è un criterio sufficiente per individuare tecnologie conviviali nell’epoca digitale. Cerchiamo di aggiornare il ragionamento alle tecnologie digitali di massa. La nocività delle ricadute negative insite in quelle tecnologie è nascosta in bella vista. Le gigantesche catene di esattamenti tossici selezionano gli esseri tecnici che popolano il mondo umano in base ad alcune caratteristiche, orientate al profitto e al reciproco condizionamento. Eppure risulta abbastanza semplice nasconderne le esternalità negative per via dell’apparente semplicità che la tecnologia rappresenta, della sua disponibilità e diffusione. L’introduzione di schemi di gioco premiali (gamificazione) presenta la tecnologia come un piacevole surrogato, di gran lunga preferibile alla fatica di organizzare libere scelte in un mondo complesso, così esposte alla frustrazione e al fallimento. Ripetere una procedura gamificata gratifica l’umano in maniera immediata e potente.
La ristrutturazione cognitiva dell’ambiente interattivo tramite tecniche di nudging, la cosiddetta spinta gentile, è un metodo ancora più semplice per persuadere gli umani a comportarsi in un modo prestabilito dal sistema tecnico, cioè per manipolarne la volontà senza tirare in ballo complesse questioni etiche ed estetiche, e senza dover ricorrere immediatamente a sistemi coercitivi e repressivi. L’esempio classico di nudging è la mosca riprodotta nella ceramica degli orinatoi (maschili, naturalmente) dell’aeroporto di Schipol (Amsterdam) fin dal 2002. Invece di scrivere «fatela dentro», esortando a un comportamento adeguato, invece di minacciare ammende o reprimende (sistema punitivo), si fa leva sulla competitività degli individui penedotati che, alla vista della mosca, cercheranno di far centro… Banale? Forse, ma funziona, nel senso che statisticamente i bagni risulteranno più puliti della media.
Le tecniche di nudging sono fra quelle di maggior successo per aumentare il tasso di risposte automatiche. Generalmente applicata per influenzare i comportamenti, la teoria del nudge è stata elaborata a partire dal quadro cibernetico tratteggiato da Wiener, inteso nel senso piuttosto lasco di controllo di un qualsiasi sistema attraverso la tecnologia e sfruttamento dei meccanismi di retroazione (feedback). In questa interpretazione tipica dell’economia comportamentale, un nudge è «qualsiasi aspetto della scelta che altera il comportamento delle persone in modo prevedibile senza proibire alcuna opzione o cambiare significativamente i loro incentivi economici»2. Questa teoria continua a essere enormemente popolare presso politici e policy-maker di ogni risma, e questo nonostante l’argomentazione semplicistica rilevata da alcuni critici, o forse proprio grazie a essa. Infatti propone una serie di soluzioni comportamentali molto semplici a problemi sociali complessi; l’orientamento politico conservatore degli autori, noto come libertarian paternalism (paternalismo libertario), non sembra destare preoccupazioni in amministratori di dichiarato orientamento progressista.
Semplicità apparente, disponibilità diffusa, addestramento alla delega tramite gamificazione e nudging contribuiscono a elevare la Tecnica e la Tecnologia correlata a monopolio radicale, unica «soluzione» per «risolvere» presunti «problemi» sociali e psicologici. «Problemi» quali sentirsi soli, voler comunicare con altre persone, scegliere cosa fare e in che modo, decidere cosa acquistare e così via.
Al di là della competenza specifica rispetto a una determinata tecnologia, è evidente che se tutti usano una «soluzione tecnica» senza preoccuparsi di come funziona e di quale organizzazione implica, risulterà impossibile coltivare e mantenere una sufficiente autonomia a livello individuale e collettivo senza ricorrere a una delega gerarchica fissa. La tecnologia riconfigura i rapporti di potere perché la sua ergonomia, come abbiamo visto, articola nuove regole del lavoro (ergon-nomos), nuove dinamiche organizzative, nuove relazioni fra umani e non umani. Nel caso delle tecnologie digitali di massa sono perlopiù orientate all’asservimento reciproco.
Se diventa norma sociale avvalersi di un social network per mantenersi in contatto fra umani, diventa difficile non usarlo, pena l’esclusione dai rapporti sociali. Se non possedere il telefono cellulare diventa uno stigma sociale perché non si è raggiungibili dagli altri, significa che l’alienazione tecnica si manifesta sotto forma di alienazione sociale.
Queste articolazioni fra esseri umani ed esseri tecnici sono in effetti Megamacchine, come le chiamava Lewis Mumford in Il mito della macchina, ovvero implicano concatenazioni di tipo capitalista, che tendono innanzitutto a riprodurre e intensificare il valore, e concatenazioni di carattere intrinsecamente dispotico, cioè tipiche del despotes: del sovrano dominante. Generano dipendenza, sfruttamento, impotenza degli esseri umani ridotti a compratori e servi; dal canto loro, le macchine sono ridotte a meri supporti dell’automazione dei rapporti sociali.
Concatenazioni di tipo capitalista e dispotico tendono caratterizzare, a maggior ragione, le Megamacchine digitali di massa, che a prima vista si prendono cura delle relazioni, facilitando la comunicazione nel frenetico caos quotidiano e andando a scovare le informazioni adatte a ciascuno. Vengono inoltre presentate come sistemi che si prendono cura dell’organizzazione di agende sempre più complicate, con mille impegni affastellati che spesso vengono cancellati all’ultimo minuto, e devono essere ri-calendarizzati tenendo conto di una miriade di variabili. Sono caldamente consigliate per occuparsi efficientemente della pianificazione di spostamenti e viaggi sempre più frequenti e necessari, per non perdere opportunità professionali e occasioni di svago. Sono considerate indispensabili per gestire oculatamente i risparmi e gli investimenti, per chi ne ha, ovvero non solo pochi super-ricchi, ma centinaia di milioni di piccoli risparmiatori e investitori, corteggiati dagli speculatori finanziari. E, ultimo ma non meno importante, si prendono cura di selezionare acquisti, film, musica e anche potenziali partner sulla base dei (meta)dati in loro possesso.
Va notato che l’aspetto dispotico è conforme all’intensificazione del dominio a tutti i livelli. Il dispotismo dello Stato sovrano che governa, controlla, irreggimenta e opprime i suoi sudditi procede di pari passo con il dispotismo dell’individuo che si erge a piccolo tiranno di sé stesso, oltre che dei suoi simili e degli altri esseri viventi e non viventi. Mai sazio, senza alcun riparo in un mondo che esige livelli di prestazione sempre crescente, costantemente in preda a una qualche emergenza, frustrazione, desiderio, mancanza… tutti problemi che il piccolo despota tende a risolvere con una soluzione tecnologica.
Ma in definitiva, prima di puntare il dito contro lo strapotere della Tecnica e rimpiangere i bei tempi andati, cadendo nell’insostenibile posizione primitivista, è importante ricordare che queste Megamacchine non sono sistemi separati dalle controparti umane; non sono sistemi che agiscono alle loro spalle e contro il loro volere, mosse da un’oscura macchinazione. Come le Megamacchine imperiali antiche, ad esempio l’organizzazione dispotica dell’antico Egitto che servì alla costruzione delle piramidi (la prima Megamacchina secondo Mumford), così le Megamacchine reticolari globali sono composte di esseri umani ed esseri tecnici insieme. Per semplicità le chiamiamo Megamacchine digitali, ma dobbiamo ricordare che funzionano grazie alla compiaciuta partecipazione degli esseri umani, lieti di lasciare l’iniziativa a chi ne sa, a chi può e vuole occuparsene, un po’ come accade con gli esperti umani. Grati di lasciar scegliere un sistema esperto piuttosto che affrontare l’immane fatica di scegliere per conto proprio, affidandosi al parere autorevole di persone di cui ci si fida, selezionando fra una quantità di scelte potenziali che pare illimitata ma che è, nei fatti, sempre più omologata.
Le Megamacchine digitali sono in effetti il combinato disposto di esseri umani, esseri tecnici e delle loro interazioni orientate al condizionamento reciproco in un quadro gerarchico fisso. I condizionamenti sono orientati a rinforzare comportamenti e reazioni automatiche di comando/obbedienza. Il tutto non tramite la coercizione violenta, ma attraverso rinforzi positivi tipici dei sistemi premiali.
Una pubblicità di una nota azienda telefonica italiana uscita nel 2017, e ritirata poco dopo, spiegava la faccenda con una semplicità disarmante. Un noto attore comico recitava, estasiato:
Oggi grazie alle connessioni possiamo entrare in un universo televisivo senza limiti. […] Una galassia sconfinata […] che puoi vedere ovunque e quando vuoi. Oggi le nuove tecnologie ci stanno dando la possibilità di non dover scegliere… Non è fantastico?
Ed eccoci tornati improvvisamente alla questione fondamentale della libertà e del potere, qui declinato come potere di mettersi in una situazione in cui vige una regola di delega totale, di affidamento cieco rispetto alle scelte. Letteralmente: una situazione di fede nella tecnologia, che libera l’umano dai propri limiti, dalla localizzazione in un qui (l’universo tecnico è un servo a disposizione, disponibile ovunque, dona l’ubiquità!) e ora (è accessibile a piacere, quando vuoi, senza attenzione al contesto). Quindi un paradossale potere di rinunciare al potere, in quanto rinuncia all’esercizio della possibilità di intervenire nella definizione e nell’applicazione delle norme.
In questa situazione non si sceglie nemmeno cosa guardare alla tv, sarebbe troppo faticoso, per non dire impossibile; lo zapping non funziona più, l’offerta è talmente esorbitante che risulta frustrante passare in rassegna centinaia di canali (sempre che i vari apparecchi ricevano il segnale, siano adatti e adeguatamente configurati); è più comodo delegare la scelta a un sistema esperto. Gli interventi umani tendono a ridursi al minimo indispensabile, il più possibile esenti da sforzo, sotto forma di reazioni automatiche binarie o poco più (mi piace/non mi piace, o voto di gradimento sotto forma di stelline/fragole/banane).
Questa è l’attitudine che qualifica le tecnologie autoritarie, che si nutrono della sottomissione gerarchica. Nel caso dei regimi politici riconducibili al capitalismo liberale, fra cui Stati Uniti e Unione Europea, si pubblicizzano come sistemi per aiutare la scelta, facilitare la deliberazione, suggerire e consigliare i consumatori disorientati, ma in realtà sono dei meri sostituti meccanici del libero arbitrio. Una volta strutturate in tal senso, le tecnologie tendono a riprodurre sistemi autoritari, nel senso che l’autorità viene alienata in maniera radicale e irrevocabile, transitando dall’esperto di cui Bakunin si fidava in maniera mirata a una pletora di sistemi semi-automatici di misurazione, quantificazione, selezione e proposta di irrinunciabili occasioni.
L’autorità delegata coincide con una quota di potere alienata che va ad alimentare una gerarchia fissa; tale gerarchia, composta anch’essa di esseri umani ed esseri tecnici in varia misura, si presenta come una tecnoburocrazia in continua espansione. Tecnocrazia perché fa leva sul monopolio del potere tecnico; burocrazia perché, lungi dallo spazzare via i precedenti sistemi statali, ne estremizza l’obbedienza cieca a procedure insensate, strutturate per automatizzare le relazioni.
A proposito di tecnoburocrazia, a differenza di quanto sostengono le dottrine riconducibili al socialismo autoritario, è importante ricordare che l’abolizione della proprietà privata è irrilevante. Anzi, su vasta scala, un simile progetto politico non può che sfociare nell’intensificazione delle strutture tecnoburocratiche a livelli inimmaginabili per i sistemi capitalisti liberali, che mantengono nonostante tutto una quota di individualismo.
I più accorti fra gli ex-comunisti ed ex-marxisti lo hanno compreso da molto tempo; del resto, persino Marx ed Engels l’avevano capito perfettamente alla metà del xix secolo, teorizzando il «modo di produzione asiatico»: dalle loro analisi risulta evidente che il dispotismo orientale ha abolito la proprietà privata e proprio per questo è riuscito a dare un giro di vite in più alla morsa totalitaria. Non è certo la proprietà privata all’origine di ogni male; può essere un effetto secondario, nel senso che la concentrazione delle ricchezze deriva dalla violenza del dominio. Ma, da buoni autoritari, dopo aver sfornato il Manifesto del partito comunista, non potevano certo riconoscere che avevano ragione gli anarchici a opporsi a ogni tentativo di centralizzazione e rafforzamento della burocrazia statale; né tanto meno potevano rassegnarsi a seguire Proudhon sulla via del cooperativismo e del mutualismo. Eppure era chiaro, anche in senso economico:
La proprietà collettiva dei mezzi di produzione a questo livello non muta nulla, e si limita ad alimentare un’organizzazione dispotica stalinista. Perciò [Ivan Illich] vi oppone il diritto di ciascuno a utilizzare i mezzi di produzione in una «società conviviale», ossia desiderante e non edipica. Ciò significa: l’utilizzazione più estesa delle macchine da parte del maggior numero di persone, la moltiplicazione delle piccole macchine e l’adattamento delle grandi macchine alle piccole unità, la vendita esclusiva di elementi macchinici che devono essere assemblati dagli stessi utilizzatori-produttori, la distruzione della specializzazione del sapere e del monopolio professionale3.
Ecco perché le dimensioni contano. Non si tratta di mitizzare l’idea che «piccolo è bello», ma di riconoscere che, almeno negli esempi storicamente noti, quando una tecnologia si diffonde in maniera omogenea, serializzata e industrializzata al di là di una certa dimensione, la selezione dei tratti evolutivi tipici delle relazioni libertarie cede il passo alla selezione dei tratti evolutivi tipici delle relazioni gerarchiche. Le gerarchie fisse s’impongono nella gestione dei rapporti tra gli esseri umani e gli altri esseri viventi e non, con il loro «corollario» di sfruttamento dispotico. Non si può scalare, crescere di scala in maniera illimitata, senza snaturarsi completamente.
Questo perché tutto è relativo, cioè «in relazione a». Se invece di un numero modesto di persone in spazi limitati che intrattengono relazioni del tutto uniche fra di loro abbiamo a che fare con migliaia o addirittura milioni di persone, la relatività cede il passo all’omologazione e i semplici automatismi cognitivi necessari per le interazioni si fanno abitudine irrinunciabile, anzi fede nella procedura liturgica. Avere mille amici e migliaia di contatti non ha senso, milioni di follower nemmeno, perché nessun umano dispone del tempo né delle energie sufficienti per valorizzarli, a meno di affidare le relazioni a sistemi di interazione automatizzata. Non è uno scenario fantascientifico, ma il presente del secondo decennio del xxi secolo, chiaramente rappresentato dalla possibilità di ordinare all’assistente vocale di prendersene cura: «Alexa, ricordati dei compleanni dei miei amici e manda loro un messaggio carino, personalizzato…».
Le relazioni significative richiedono attenzione e competenza, non distrattenzione e sciatteria; tanto meno delega tecnocratica.
Appunti per un’informatica conviviale
Ma allora è possibile un’informatica conviviale, cioè che promuova la realizzazione della libertà individuale in seno a una società dotata di strumenti efficaci? Ci vogliono tecnologie appropriate, ma per poterle immaginare e realizzare è necessario correggere e ampliare la formulazione di Illich.
Innanzitutto, dobbiamo riconoscere che un sistema tecnico di piccola scala può essere dispotico tanto quanto un sistema industriale globale; anzi, può rivelarsi ancora più censorio e asfissiante per la libertà personale. Ad esempio, le dinamiche psicosociali oppressive tipiche di un piccolo paese, in cui la gente mormora e tutti sanno tutto di tutti, possono risultare amplificate da tecnologie di controllo e monitoraggio su piccola scala, riproducendo un universo concentrazionario in miniatura. In altre parole, la piccola scala non garantisce di per sé l’assenza di dominio, ed è logico che sia così, altrimenti la libertà sarebbe un derivato automatico dell’organizzazione in piccoli gruppi.
Un piccolo gruppo di esseri umani può nutrirsi di relazioni di co-dipendenza tossiche alimentate e anzi rese possibili da «semplici» tecnologie «artigianali» di dominio reciproco, come il rispetto di rituali di sottomissione. Rituali analogici o digitali non fa differenza, si tratta in ogni caso di ripetizioni che mirano a instaurare un ritmo di acquiescente sottomissione, contrita obbedienza, schizofrenico conformismo a norme alienate e alienanti. Senz’altro non c’è bisogno di tecnologie particolarmente sofisticate.
Non solo: un piccolo gruppo che mira a ottenere l’egemonia, cioè la supremazia, non potrà esimersi dallo stabilire relazioni autoritarie, quanto meno nei confronti di chi si trova all’esterno del gruppo egemone, che dev’essere subordinato all’egemonia. Le pratiche autoritarie studiate dai teorici dei progetti egemonici per sottomettere gruppi antagonisti (dalla manipolazione del consenso all’infiltrazione delle strutture istituzionali) tendono quindi a saturare lo spazio relazionale, a discapito di pratiche libertarie, e a insinuarsi anche all’interno del gruppo egemone, a prescindere dalle dichiarazioni di principio.
Queste pratiche vengono messe in atto grazie a esseri tecnici in grado di realizzarle concretamente, ad esempio strategie comunicative tipicamente delegate a esperti di comunicazione, ma anche e soprattutto attraverso l’attitudine al comando degli esseri tecnici stessi, considerati mezzi necessari per raggiungere i fini desiderati. Ma come non si può imporre la libertà tramite la sottomissione all’idea di libertà, né esportare la democrazia con la guerra o l’autogestione con la violenza, così non si può estirpare la perversione del dominio tramite l’obbedienza di servi tecnici. La forma della relazione ne rivela la sostanza; una relazione formata da rapporti di comando/obbedienza non può che strutturare gerarchie fisse orientate al dominio.
A proposito della scala tecnica, la riflessione di Bookchin risulta appropriata. Discutendo della matrice sociale della tecnologia, nel capitolo decimo di L’ecologia della libertà, sostiene che il problema storico della tecnica non sta nella dimensione, ma sta in come si possa includere (vale a dire assorbire) la tecnica dentro una società emancipatoria. In sé, il «piccolo» non è né bello né brutto; è semplicemente piccolo. Alcuni dei sistemi sociali più disumani e centralizzati si basavano su tecnologie molto «piccole», che le burocrazie, le monarchie, gli apparati militari seppero utilizzare per soggiogare gli esseri umani e, successivamente, per soggiogare la natura. Certo, una tecnica di grande scala alimenterà lo sviluppo di una società oppressiva di grande scala; ma ogni società distorta segue essenzialmente la dialettica patologica del dominio, indipendentemente dalla scala della sua tecnica. Può organizzare il «piccolo» in modo da farne qualcosa di altrettanto ripugnante del ghigno che imprime sui volti delle sue élite dominanti. Termini come «grande», «piccolo», «intermedio», «leggero», «pesante» si riferiscono ad attributi esteriori dei fenomeni o delle cose, non alla loro essenza. Possono aiutarci a determinare la loro dimensione o il loro peso, ma non ci spiegano le qualità immanenti della tecnica e in particolare come essa si rapporta alla società [corsivi miei]4.
A mio parere però gli attributi esteriori dei fenomeni o delle cose non sono separati da quella che Bookchin definisce essenza. Anzi, la forma dei fenomeni è consustanziale alla loro essenza; studiando la forma e l’articolazione delle forme si può comprenderne l’essenza, o per meglio dire il loro modo d’esistenza. In particolare, l’essenza della tecnica è la sua tecnicità, come sostiene il filosofo Gilbert Simondon, già citato nell’introduzione. Può sembrare ridondante ma, come vedremo, implica un cambio radicale di prospettiva, sicuramente dal punto di vista filosofico.
Inoltre, invece di formulare teorie astrattamente perfette, tipiche del peggior intellettualismo ignaro della realtà, dobbiamo prendere atto della scala globale della tecnologia attuale, in particolare nella sua manifestazione più evidente che è la rete di Internet, e agire a partire da quel che esiste oggi, ampliando gli spazi di autonomia concreta. In questo senso, al di là della scala, è importante prendere in considerazione le relazioni di potere.
Infatti, nell’ambito delle tecnologie di rete la scala non è semplicemente monodimensionale, legata alla vicinanza di una risorsa. La valutazione in merito al potenziale conviviale, emancipatorio e liberatorio di una configurazione tecnosociale deve tenere conto anche di altre variabili, in particolare dell’asimmetria di potere degli attori coinvolti e quindi della loro capacità di determinare norme socialmente vincolanti.
Si pensi alla fornitura di servizi web per la gestione amministrativa di un’attività legata all’organizzazione di piccoli eventi culturali (decine o centinaia di persone). In termini di relazioni di potere, per mantenere un’analoga capacità di intervenire nella definizione e applicazione di norme che regolano l’interazione reciproca, potrebbe essere accorto rivolgersi prioritariamente a organizzazioni di taglia analoga, abituate ad avere a che fare con problemi affini. Organizzazioni molto più grandi potrebbero considerare marginali questioni di piccola scala e inglobare organizzazioni più piccole come semplici ingranaggi (intercambiabili) nel loro sistema dominante.
Traduco in tecnologia corrente nel primo e secondo decennio del xxi secolo: propagandare le attività della propria associazione culturale tramite Meta (Facebook-Instagram-Whatsapp) e altri social di massa condurrà inevitabilmente a un asservimento alle procedure imposte dalla multinazionale, di omologazione dei messaggi e dei contenuti a standard predefiniti. Verranno inevitabilmente modificate, adeguandosi all’esattamento tecnico del sistema tecnocratico di Meta, l’organizzazione del lavoro, le modalità di relazione interne ed esterne all’organizzazione, le dinamiche psicosociali. Passiamo rapidamente in rassegna le ragioni di questo asservimento necessario.
Da un punto di vista quantitativo, di sforzo profuso, «usare bene» il social di massa comporterà un costante aggravio di lavoro, perché le catene di esattamenti tecnici tossici, mirati a trattenere gli umani nella zona di interazione del sistema, necessitano di continui adeguamenti alle nuove funzionalità. Per quanto riguarda il controllo dei dati e, più in generale, la prossimità della tecnologia agli utenti umani, determinerà senz’altro una perdita di controllo e una lontananza sempre più marcata per via della struttura stessa della multinazionale, che tende ad accentrare la gestione dei dati in pochi nodi (i data center), sotto il controllo di procedure opache e di pochi tecnoburocrati apicali. A livello di modalità d’interazione tecnica, i software utilizzati saranno proprietari, quindi non modificabili né distribuibili a piacimento dalle persone, come invece accade nei sistemi f/loss (Free/Libre Open Source Software).
Ma anche se fossero f/loss, il gigantismo intrinseco vanificherebbe lo sforzo di apertura, perché milioni e milioni di righe di codice che girano solo su macchine gigantesche ed estremamente potenti richiedono organizzazioni gerarchiche globali (le multinazionali) per essere gestite. Le relazioni tenderanno a strutturarsi in maniera automatizzata e spersonalizzata: da una parte perché lo sforzo di apprendimento e messa in pratica delle nozioni necessarie a interagire con il sistema tende a moltiplicarsi senza fine; dall’altra per via dell’introduzione sempre più massiccia di sistemi automatici di risposta, le cosiddette Intelligenze Artificiali (assistenti virtuali e via automatizzando) con cui gli umani devono fare sempre più spesso i conti (richieste di informazioni, reclami, ecc.).
Infine, dal punto di vista psicologico, ma anche dell’impatto sulla gratificazione fisiologica per l’attività svolta, implicherà una frustrazione crescente, perché il sistema è strutturato in modo che a investimenti crescenti (in termini economici ed energetici) corrispondano rendimenti decrescenti. Anzi, peggio ancora: a investimenti costanti corrispondono rendimenti decrescenti. Questa constatazione spiega perché il sentimento che arnesi, utensili e macchine servano per alleviare la fatica umana non abbia più realmente corso nel caso delle Megamacchine digitali.
Infatti, chiunque abbia contezza dei meccanismi di promozione social sa bene che l’unico modo perché i messaggi si diffondano è pagare il posizionamento degli stessi alla piattaforma proprietaria. Inoltre, è noto che questi cosiddetti adv (advertising), cioè pubblicità mirate, attirano maggiore attenzione quanto l’account è appena stato creato, perché la piattaforma spinge il novello utente a impegnarsi, in una sorta di noviziato per apprendere la liturgia del sistema, imparare come funziona, gratificando i suoi sforzi (e investimenti) con un rendimento notevole. Ma se l’investimento non cresce, il rendimento e la gratificazione tenderanno a diminuire. Anzi, tenderanno a diminuire in ogni caso.
Non possiamo dimostrarlo dati alla mano solo perché non abbiamo accesso agli algoritmi dei social, protetti da sofisticati sistemi di «proprietà intellettuale» (ovvero esproprio intellettuale di chi li inventa, implementa e manutiene), ma vi sono sufficienti elementi ex post (sensazioni di utilizzo, effetti psicosociali osservati, metriche e analitici) per supporre che siano implementati proprio per favorire un crescendo di interazioni tossiche di mutuo condizionamento. Non abbiamo bisogno di rivelazioni dall’interno, di qualcuno che spifferi verità ovvie: i social di massa sono tossici, si nutrono e favoriscono relazioni tossiche fra gli esseri umani e fra gli esseri tecnici.
L’argomentazione appena svolta è una riedizione della necessaria armonia e coerenza tra fini e mezzi enunciata in maniera esemplare da Errico Malatesta. A suo parere la lotta per la libertà e l’uguaglianza deve essere condotta con strumenti libertari ed egualitari, ovvero l’emancipazione non può darsi mediante strumenti oppressivi. Attenzione però: non sono gli esseri tecnici di per sé, nella loro essenza, a essere oppressivi, bensì le relazioni (e dunque le reti) che essi favoriscono in quanto creati e sviluppati come motori di adattamenti e soprattutto esattamenti tossici di massa. Fin qui la pars destruens. Più difficile, come sempre, è la pars construens.
Prossimità, affinità, federazione
Già a inizio Novecento Malatesta sosteneva che «i mezzi condizionano i fini: per la libertà ci si deve battere con strumenti che già siano in sé stessi libertà». Un secolo abbondante più tardi, possiamo fare un passo più in là con Amedeo Bertolo, che, invitato nel 2005 a riflettere sull’identità anarchica in vista di un dibattito che non si è mai tenuto, aggiungeva: «Credo che la coerenza mezzi-fini sia il minimo. Credo che si debba andare oltre. Non solo il fine non giustifica i mezzi, ma sono i mezzi che giustificano il fine». Bertolo parlava dell’anarchia come metodo, cerniera di collegamento fra mezzi e fini. Tradotto in termini tecnici: gli esseri tecnici con i quali ci accompagniamo devono poter giustificare il fine della libertà nell’uguaglianza. Come facciamo le cose, insieme agli esseri tecnici, deve riuscire nell’impresa di spiegare, supportare e far germogliare il cosa facciamo.
Si tratta quindi di invertire il flusso dell’iniziativa, dal locale verso il globale, secondo un modello di federazione reticolare in grado di trarre il massimo vantaggio dalla struttura decentralizzata e federata di Internet. Non si tratta di effettuare investimenti a pioggia, ma di facilitare iniziative legate a questioni concrete, tangibili, quotidiane. Non si tratta di inseguire la prossima start-up o app capace di rivoluzionare il mercato: sarebbe l’ennesima «rivoluzione» nel senso deteriore del termine, cioè una modifica repentina e distruttiva che rende obsolete le competenze faticosamente accumulate e rafforza le disparità pre-esistenti.
Declinare l’autogestione in questo contesto è relativamente semplice. È necessario rendere meno farraginose le pratiche per dar vita a organizzazioni di prossimità, vicine alle persone, gestite dalle persone, esperte e meno esperte, valorizzando la diversità ancor prima dell’abilità. Infatti è più importante che persone diverse fra loro riescano a collaborare in vista di un obiettivo comune, mettendo a punto procedure condivise, piuttosto che delegare agli esperti di turno per ottenere un risultato «migliore». Queste organizzazioni, strutturate con l’aiuto di esseri tecnici affini, possono federarsi e creare federazioni internazionali: la piccola scala è quindi un parametro utile se declinata nel senso della prossimità e dell’affinità fra esseri umani ed esseri tecnici che cooperano per costruire mondi comuni. Mondi che aspirano all’internazionalismo per loro stessa natura: perché la libertà, per essere davvero tale, tende a estendersi a ogni essere, vivente o meno.
Il concetto di prossimità va inteso in accezione ampia, seguendo i fili delle connessioni reticolari. La compresenza in un ambiente disconnesso, non sintetico, non è una condizione sempre necessaria, anche se spesso è desiderabile. In questo senso, è senz’altro caratterizzato da prossimità un gruppo di poche persone sparpagliate in diversi continenti che condividono pratiche e ideali, che cooperano in maniera regolare, che si confrontano, discutono e scambiano esperienze e servizi grazie al potere straordinario delle reti digitali globali. Infatti, persone collegate da una solida rete del genere, di cui si prendono cura, si sentono prossime, vicine fra loro anche se abitano realtà disconnesse del tutto diverse fra loro, anche se vivono a latitudini diverse e in fusi orari lontani. Questo perché innanzitutto mantengono l’un l’altro delle chiare tracce affettive (situazione psicoemotiva e sociale reciproca), ovvero sono al corrente della situazione degli altri. Dal punto di vista emotivo, si riscontra una consonanza fatta di comuni entusiasmi, indignazioni, slanci e frustrazioni; dissensi e conflitti tendono a essere generativi e non distruttivi. Dal punto di vista organizzativo, grazie alla concatenazione di procedure selezionate e sviluppate in maniera consapevole insieme a esseri tecnici specifici, un gruppo del genere mutua le dinamiche dei gruppi di affinità tradizionali, con i suoi rituali assembleari il più possibile snelliti e facilitati, le sue capacità di impedire la strutturazione di gerarchie fisse, le sue dinamiche interne virtuose e le proiezioni esterne verso lo spazio pubblico, nel senso di proposta politica e culturale.
È senz’altro più difficile rispetto ai modelli tradizionali di associazionismo e collaborazione, basati spesso sulla compresenza disconnessa. Ma sappiamo per esperienza che incontrarsi «di persona» non è di per sé garanzia di convivialità né tanto meno di emancipazione liberatoria: a volte i conflitti inespressi covano ed esplodono in maniera inaspettata proprio laddove ci si aspetterebbe concordia nella diversità reciproca.
Il convenire assieme in uno spazio fisico tradizionale non è nemmeno l’inevitabile premessa di una rivolta generalizzata. Le piazze straripanti non sono garanzia di rivoluzione sociale imminente, anzi possono segnalare i prodromi di un’involuzione autoritaria, perché al di là delle retoriche sulla «saggezza delle folle», come ci ricorda Elias Canetti in Massa e Potere (Masse und Macht in tedesco, che si può tradurre anche come Massa e Potenza), la massa s’infiamma facilmente e tende a disperdersi quando l’incendio si è consumato. Non saranno individui stanchi e demotivati, che non hanno nulla da perdere, a dar vita a un grande collettivo solo perché si ritrovano «insieme» a sfogarsi.
È meraviglioso potersi incontrare «di persona», ma spostarsi in continuazione da una città all’altra, da un continente all’altro, è una follia ecologica (che fra l’altro implica un’infrastruttura globale di sfruttamento a tutti i livelli), cui noi privilegiati abitanti del mondo globalizzato dobbiamo porre fine per decisione autonoma e non perché costretti dalla catastrofe ambientale in corso e dal senso di colpa. Questo non vuol dire rinunciare alla prossimità e persino all’intimità tout court; vuol dire invece riorganizzare tempi, modi e abitudini, oltre alle tecnologie che devono evolvere insieme a noi. Vuol dire imparare a cogliere la bellezza e la forza degli incontri «online»; imparare a mescolare, meticciare, gli ambienti, convocando in uno spazio pubblico umani fisicamente lontani, ma politicamente vicini.
Al di là dell’aspetto storico ricordato da Bookchin, possiamo allora riformulare la questione nei seguenti termini: quali sono le caratteristiche, i tratti, i caratteri che vengono selezionati nei sistemi tecnocratici? Quali comportamenti umani e quali retroazioni tecniche favoriscono l’emersione di una gerarchia di dominio? Quali tratti e comportamenti favoriscono invece l’insorgere di dinamiche di mutuo appoggio e l’affermarsi del retaggio della libertà?
Torniamo a osservare gli esseri tecnici in interazioni concrete con gli umani, interazioni facili da replicare per chiunque, per provare a fare un passo più in là.
Note al capitolo
1. Il valore della diversità viene ben esemplificato in ambiti assai differenti in Scott E. Page, Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools and Societies, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2007. Nell’ambito dell’urbanistica, una buona raccolta introduttiva è Jane Jacobs, Città e libertà, elèuthera, Milano, 2020.
2. Richard H. Thaler, Cass R. Sunstein, Nudge. La spinta gentile: La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, Feltrinelli, Milano, 2017; ed. or. Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, Yale University Press, New Haven, 1999.
3. Gilles Deleuze, Félix Guattari, «Bilancio-programma per macchine desideranti», in Macchine desideranti, Ombre corte, Verona, 2004, p. 114.
4. Murray Bookchin, op. cit., pp. 373-374.
capitolo quinto
Attriti e frizioni.
Ambienti tecnici associati
Tratti dell’evoluzione tecnica nel retaggio del dominio. Tendenza a diminuire attriti e frizioni, ad aumentare la circolazione e la velocità. Ingredienti della tecnocrazia: alienazione crescente, necessità di affidamento cieco in soluzioni tecniche, similitudini con le credenze magiche alienanti. Peculiarità della tecnologia informatica in rete. Ambienti associati: meticciare esseri tecnici ed esseri umani. Oltre l’autodifesa e la diserzione: hackerare l’evoluzione tecnica. Associarsi per la libertà: il mutuo appoggio come pratica regolativa.
L’evoluzione tecnica nel retaggio del dominio
Il retaggio del dominio è composto dalla selezione di tratti evolutivi nei quali esseri umani ed esseri tecnici tendono a sottomettersi e dominarsi reciprocamente. Adattamenti ed esattamenti vengono effettuati in maniera funzionale all’instaurazione di gerarchie fisse idonee all’esercizio del dominio. Il potere viene accantonato, accumulato e tesaurizzato. In queste evoluzioni dispotiche gli esseri implicati nelle Megamacchine digitali agiscono e sono agiti da moti di comando/obbedienza, perlopiù organizzati secondo serie di automazioni scelte in maniera non consapevole. La ripetizione genera l’ossificazione di procedure di comando/obbedienza che si materializzano in nuove versioni del sistema tecnico, percepito come via via più oppressivo. L’instaurarsi di un vero e proprio ritmo del dominio struttura gerarchie tecnoburocratiche in cui le catene di comando/obbedienza sono talmente lunghe e articolate da rendere apparentemente impossibile disertare alla pressione sociale, psicologica, emotiva ed economica che spinge a sottomettersi al sistema tecnico, presentato come un ineludibile dato naturale, frutto del progresso scientifico.
Il farsi natura del sistema tecnico oppressivo implica la cooptazione e sottomissione di ogni essere, non solo di esseri umani ed esseri tecnici, ma ovviamente anche di animali, piante e altri esseri organici e inorganici. Tutto diventa risorsa utilizzabile, spendibile e sostituibile.
Ma non si tratta affatto di un quadro complessivo tipico dell’epoca attuale: il dominio si è presentato in epoche remote, probabilmente come accidente evolutivo, e poi è stato scientemente evoluto da alcuni esemplari di Homo Sapiens Sapiens per saziare la loro brama, fino a estendersi a livello globale sotto forma di Megamacchine digitali. Questa lenta e consapevole volontà di dominio non è una novità recente, imposta dalla cosiddetta rivoluzione industriale nelle sue varie ipostasi, o dalle più recenti tecnologie digitali globali.
Da quando ha fatto la sua inopinata comparsa, il dominio ha sempre selezionato gli esseri umani dalle caratteristiche maggiormente sociopatiche per occupare i livelli alti della gerarchia: presidenti, manager, generali e via discorrendo, tutte posizioni impossibili da occupare per persone mosse da pratiche di mutuo appoggio e abituate a relazioni conviviali. Chi potrebbe mai decidere di mandare a morte i soldati sottoposti? Di dichiarare guerra, consapevole delle distruzioni e sofferenze che causerà? Solamente umani profondamente sociopatici: gli altri in quei posti di dominio non ci sanno stare. Questa è la tesi ben argomentata dallo scrittore e medico Alex Comfort nel suo classico Potere e delinquenza. Allo stesso modo, il sistema del dominio seleziona gli esseri tecnici meno disponibili alla libera interazione fra pari per strutturare le tecnocrazie.
La Tecnica che tutto dispone come Megamacchina globale non è però una modalità dell’essere, un modo in cui il mondo intero si dispone oggi, come sostiene Heidegger discettando del Gestell. Sostenere una simile tesi significa addossare ogni responsabilità all’essere tecnico, declassato a oggetto e contrapposto al soggetto umano. Significa anche elevare l’umano a vertice indiscusso di una presunta scala evolutiva gerarchizzata, quando invece, dal punto di vista evolutivo, ogni essere occupa la propria nicchia ed è, in quel dato momento, l’esito di un processo di differenziazione evolutiva di cui rappresenta il punto apicale.
Costruire un Altro disumano e disumanizzante, che tutto ingloba in un quadro da cui non si può uscire, un Altro alieno, alienato e alienante incarnato nella Tecnica, rivela l’ambivalenza di tale processo. L’alterità tecnica viene infatti presentata come mostruosa, un monstrum, cioè, come ricorda l’etimologia latina, un’entità al tempo stesso orrenda e ributtante ma anche affascinante perché oltrepassa i limiti di ciò che viene considerato normale, rispettoso della norma. Il mostruoso della tecnica, affascinante e ributtante insieme, è stato storicamente incarnato nelle macchine.
La Macchina è il monstrum della Modernità, e la modernolatria futurista (dell’avanguardia futurista) è stata anche e soprattutto macchinolatria; l’insieme delle Macchine e delle procedure che ne irreggimentano l’esistenza è la Tecnica che si pone come orizzonte imprescindibile e destino di tutte le specie. Secondo questa narrazione, il mondo è dominato dall’apparato tecnico che cattura ogni essere e lo sottopone al suo giogo.
Non di rado questa narrazione promuove di fatto atteggiamenti irrazionali e misticheggianti che, con il pretesto di riscoprire la spiritualità contrapposta al materialismo, costituiscono una resa di fronte alla possibilità di comprendere, conoscere e vivere insieme alle macchine e agli esseri tecnici in pace e libertà. Sono atteggiamenti tecnofobi tipici del peggior oscurantismo anti-illuminista che si perdono nell’esaltazione di miti dell’origine, di nostalgie regressive e reazionarie rivelate da espressioni come «si stava meglio una volta», «ai miei tempi queste cose non succedevano», e via recriminando.
La tecnica (insieme all’umano) non diventa parte di un dispositivo tecnocratico globale per destino ineluttabile, ma per una catena di selezioni di tratti afferenti al retaggio del dominio, che alimenta l’alienazione tecnica, cioè scava il fossato fra gli esseri viventi e non. Come nel caso delle serie evolutive da cui si originano le specie viventi, la selezione opera privilegiando la riproduzione e diffusione degli esseri e delle pratiche idonee, dotate di maggiore fitness (idoneità), ovvero scartando i non idonei. Ma, a differenza dell’evoluzione organica, l’evoluzione tecnica è diretta da teorie di formulazione umana, ed è la rispondenza a quelle teorie che determina la selezione stessa.
Poiché la tecnica è fonte di potere, sarà la concezione del potere a orientare le teorie tecniche da cui si originano le specie tecniche nelle loro materializzazioni tecnologiche. L’idoneità o fitness tecnica è la fitness rispetto a come viene concepito il potere.
A un estremo troviamo le teorie del governo e del dominio, secondo cui l’accumulo e accentramento del potere genererà un sistema adeguato a governare tramite gerarchie rette da regole di comando/obbedienza. Seguono un gran numero di teorie intermedie che prevedono e auspicano un certo grado di governo e dominio, con diversi livelli di autoritarismo e gerarchia, eventualmente anche sotto forma di autogoverno. All’estremo opposto troviamo le teorie dell’autogestione e della libertà. Fra queste teorie radicali la più consequenziale è quella anarchica, secondo cui il dominio va distrutto, insieme a ogni principio di governo, per instaurare un mondo di esseri liberi e uguali. Nella formulazione qui proposta, questo può verificarsi solo attraverso la diffusione del potere, da estendere a ogni essere, vivente e non, fino al punto di generare un sistema in cui il governo, insieme alla gerarchia, vengano dissolti a tutti i livelli tramite relazioni di mutuo appoggio, atti concertati di diserzione alle dinamiche di comando/obbedienza, moti di rivolta e distruzione di ogni principio autoritario.
Nel retaggio del dominio, i tratti considerati idonei a essere selezionati (negli umani come negli esseri tecnici) sono diversi. Fra questi elenchiamo senz’altro la capacità di comandare e di obbedire; la predisposizione all’assoggettamento; la determinazione a diffondersi senza limiti nel tempo e nello spazio, presentandosi come soluzione indiscutibile e indubitabile; il disprezzo per la gentilezza e l’adorazione per la forza bruta; la predilezione per la competizione senza regole; l’adorazione per le masse compatte, informi e il timore per gli individui difformi, particolari e non inquadrabili in categorie prestabilite; il terrore per la contaminazione, la mescolanza, il meticciato; l’esaltazione della purezza identitaria; la tendenza a stabilire identità nette e fisse; il piacere morboso per la maldicenza, l’ipocrisia e le «verità» urlate che fanno esplodere conflitti irrimediabili; la fascinazione per la disciplina; il timore per la libera creatività.
Così, lungi dall’avvenire per oscure trame, la selezione di tratti autoritari predispone gli umani ad affidarsi alla delega tecnica. Sarà quella determinata categoria di esperti a detenere la conoscenza e a gestirla per il bene del mondo. Dal canto loro, in maniera analoga, i sistemi tecnici vengono selezionati se si mostrano capaci di gestire la delega tecnica senza soluzione di continuità, senza lasciar spazio a dubbi e perplessità, proponendo sequenze liturgiche idonee da eseguire per accondiscendere, per imparare la disciplina. La credenza implicita è che i sacerdoti-esperti, umani o meccanici, riconosceranno le orazioni corrette e provvederanno al corretto funzionamento del sistema.
Allo stesso modo, la selezione di tratti competitivi predispone alla competizione reciproca, propagandata come unica via evolutiva senza alcuna considerazione per il mutuo appoggio, fattore invece fondamentale per l’evoluzione come è stato ampiamente dimostrato dallo stesso Darwin e poi, più diffusamente, da Kropotkin e da molti altri scienziati. Anche i sistemi tecnici sono posti in competizione fra loro: in questo contesto solo la tecnologia migliore s’impone e vince, dove migliore significa in effetti migliore per il retaggio del dominio, cioè capace di rafforzare il governo dispotico che misura, classifica, identifica, ordina, blandisce, corrompe, discrimina, comanda, distrugge, opprime, inquina, saccheggia, imprigiona, muove guerra, tortura e uccide.
L’elenco potrebbe continuare a lungo, ma il nostro obiettivo non è analizzare nel dettaglio come funzionano le tecnologie del dominio. Tuttavia, per elaborare tecnologie conviviali è importante saper individuare le linee evolutive di speciazione tipiche del dominio. Così come non esiste una natura umana intrinseca, buona o cattiva, allo stesso modo non esiste una natura tecnica intrinseca, buona o cattiva. Esistono però insiemi di tratti caratteristici delle selezioni operate nel solco del retaggio del dominio.
Una serie di apparecchi e strumenti vengono eliminati e cadono in disuso a favore di altri, considerati più potenti e adeguati: vengono così selezionate specifiche caratteristiche all’interno di un ventaglio molto ampio di possibilità, riducendo una varietà tecnica a uno standard monotono. L’evoluzione è in corso qui e ora, a tutti i livelli. L’evoluzione nella direzione del dominio comporta sempre una riduzione di diversità e varietà biotecnica, in ogni ambito, sia nel campo delle specie coltivate a scopo alimentare sia nel campo delle tecniche costruttive per l’edilizia, e in mille altri. Come si riduce la varietà dei cereali coltivati tradizionalmente a favore di alcune specie sterili selezionate dall’industria agroalimentare, identiche in tutto il mondo, così si riduce la varietà delle tecniche costruttive antiche, specifiche di un determinato ambiente geografico, sociale e culturale, a favore di soluzione identiche per tutti a tutte le latitudini. L’uniformazione industriale è strutturalmente dispotica, perché comporta la strutturazione di gerarchie specializzate nelle quali esseri umani ed esseri tecnici sono ingranaggi di un’interminabile catena di dominio.
Imparare a riconoscere i caratteri tipici del dominio e, per converso, della libertà è quindi esiziale. Potremo così riconoscere a colpo d’occhio, in base al suo comportamento standard, in quale campo sta operando un essere tecnico, almeno prevalentemente. Questo non per condannare ma per imparare a distinguere e a scegliere con quali tecnologie avere a che fare, con quali strumenti accompagnarci e di quali sistemi fidarci; perché, proprio come non è possibile imporre la pace con le armi, così non è possibile creare convivialità attraverso tecnologie dispotiche.
È possibile analizzare la stirpe degli esseri tecnici che danno vita ai sistemi tecnici, evidenziando le relazioni di potere che si articolano nelle interazioni fra esseri umani ed esseri tecnici. È possibile osservare gli strati di interazione reciproca con gli strumenti della pedagogia hacker, cioè facendo un po’ di autoetnografia delle nostre più semplici e banali azioni quotidiane con la curiosità tipica dell’attitudine hacker. Nulla è scontato, anzi, più un’interazione appare ovvia, più una domanda sembra semplice, più è probabile che ci sia qualcosa sotto, una complessità nascosta che dev’essere rivelata per comprendere come si struttura il retaggio del dominio tecnocratico.
Un caso di studio esemplare è il sistema del denaro. Dalle pesanti e ingombranti monete si passa alla cartamoneta, agli assegni, fino al salto elettronico con le carte di credito. Meno attriti, meno frizioni, assorbite da esseri tecnici più idonei, cioè selezionati per limitare i contatti e facilitare la circolazione dei flussi finanziari. Ogni passaggio implica l’intervento di un numero sempre maggiore di esseri tecnici, concatenati fra loro e orchestrati in sistemi di retroazione via via più sofisticati. Così le carte di credito contactless comportano l’intervento di onde radio particolari e nuove generazioni di microchip. Per finire (per ora) con i sistemi di pagamento tramite riconoscimento delle impronte digitali, o del viso del compratore umano.
In queste serie, interazioni tecniche più complesse sono caratterizzate da un incremento di automazione. Viene selezionata la capacità di abbassare il livello di frizione fra essere umani ed esseri tecnici, aumentando quindi parallelamente il livello di delega e l’intensità dell’alienazione tecnica. Minor consapevolezza rispetto alla messa in opera dei sistemi, maggior ricorso a gesti e comportamenti frutto di addestramento, uguali per tutti. Mentre le monete possono mantenere un elevato grado di diversità fra loro, le carte di credito tendono a ridurre la varietà e ad aumentare l’uniformità. Fino ai sistemi di riconoscimento facciale, di cui possono esistere pochissime implementazioni diverse, perché l’aumentata complessità e l’estensione potenzialmente senza limiti della rete di pagamento implica costi produttivi e gestionali molto più elevati, ovvero minore autonomia nella messa a punto di tecnologie locali, diverse fra loro eppure capaci di interagire in maniera efficace. L’esempio del denaro mostra che un aumento di automazione coincide con una maggiore complessità tecnica, nascosta e mascherata da interazioni stereotipate, meccaniche.
La pressione a escogitare soluzioni idonee per qualsiasi situazione, in ogni angolo del mondo, è connaturata alle specie di esseri tecnici generati su scala globale dagli apparati militari-industriali, in maniera sostanzialmente indipendente dai sistemi di governo in vigore nelle società umane. Una ricognizione più approfondita dell’evoluzione del sistema tecnico del denaro è a disposizione fra i materiali.
Tecnomagie e altre credenz
Credenza è un’altra parola chiave del retaggio del dominio. Per potersi davvero servire delle macchine è necessario credere che le tecnologie siano la soluzione giusta, corretta, anzi inevitabile. Beninteso, tecnologie al nostro servizio, obbedienti ai nostri comandi (impliciti oltre che espliciti), destinate a mettere gli umani al riparo dai disastrosi reciproci attriti. È necessario dunque credere alla Tecnologia in quanto oracolo che predice il futuro. Credere nella Tecnologia in quanto mezzo per fare qualsiasi cosa. Credere che la Tecnologia ci salverà dalle nostre goffaggini, sbadataggini. Credere che la tecnologia ci preserverà dai pericoli ignoti e li trasformerà in rischi calcolati. Solo così riuscirà ad aumentare a dismisura la velocità, a ridurre il tempo necessario per qualsiasi operazione, ad annullare le distanze e quindi lo spazio, a moltiplicare le occasioni di svago, guadagno, profitto, incontro per ognuno dei miliardi di esseri umani che s’incrocia con ogni altro a ritmi e frequenze inimmaginabili senza detta tecnologia.
Essa sarà certamente in grado di calcolare la traiettoria precisa per evitare l’impatto, lo schianto, la catastrofe. Ma i cicli di retroazioni sovrapposti rischiano di fuorviare l’attenzione invece di aiutare a concentrarla. E così, una notifica dopo l’altra, la concentrazione, tirata per la giacchetta, si perde per strada. Beep! = attenzione!, se notifica allora distrazione dall’attività in corso! Si può rischiare di andare fuoristrada, distrazione da cellulare. Per fortuna la Tecnologia aveva previsto l’air-bag, la frenata assistita, i sistemi di controllo. In attesa delle auto a guida totalmente autonoma, per consentirci di messaggiare in libertà!
Non era meglio un po’ d’attrito? Un po’ di fatica? Domande che possono suonare retoriche e, in fondo, contrarie allo Spirito del Tempo, non solo antiprogressiste ma persino reazionarie. Domande che possono apparire una condanna senza appello di ogni tecnologia dedita all’automazione, alla semplificazione e allo snellimento delle interazioni, con annesso rimpianto per i bei tempi andati, quando non c’erano tutte queste macchine in mezzo a noi.
Eppure, no. Personalmente, sono un amante degli esseri tecnici. Mi piacciono le macchine, mi piace averci a che fare. Sono tutte diverse l’una dall’altra: anche se costruite e assemblate in serie, non esistono due macchine perfettissimamente identiche l’una all’altra. Più sono complesse, più tendono a manifestare una loro personalità, delle idiosincrasie, delle caratteristiche individuali. Diventano compagne di viaggio con cui interagire nel rispetto delle reciproche libertà. Non per proiezione antropocentrica, non perché io voglio a tutti i costi riconoscere dell’umano o del vivente nel non umano e nel non vivente, ma semplicemente perché nei loro cicli di funzionamento non possono fare a meno di mostrare singolarità, punti di forza e di debolezza dovuti ai materiali costruttivi, alle tecniche di assemblaggio, alle logiche di programmazione, ai presupposti di progettazione, alle sinergie impreviste fra diversi livelli e così via.
Ho detto che mi piacciono le macchine e mi piace averci a che fare. Non con tutte però. Non sopporto le macchine corporative, le macchine serve, gli esseri tecnici schiavi che trascorrono la loro esistenza a rendere altri esseri altrettanto servi e schiavi. Le macchine dell’automazione industriale, le macchine dell’automazione militare, le macchine dell’automazione commerciale e finanziaria. Le macchine non sono tutte uguali. A chi si ispirano le fattezze e le movenze delle macchine? Da quali valori tirano le somme per calcolare le proprie azioni?
L’opera di Norbert Wiener, matematico nato e cresciuto negli usa, di famiglia ebraica, è uno snodo fondamentale per la riflessione sui rapporti fra esseri umani ed esseri tecnici. Wiener aveva vissuto l’epoca della Grande Guerra, dell’ascesa dei totalitarismi, della Grande Depressione, della seconda guerra mondiale, e aveva maturato un profondo pessimismo riguardo all’evoluzione dei sistemi di controllo e comunicazione gestiti automaticamente da macchine. Allora l’informatica ancora non esisteva, o meglio, l’informatica di massa esisteva solo a livello di speculazione teorica; le reti transnazionali erano agli albori e in pratica esistevano solo giganteschi prototipi di calcolatori elettronici a uso militare e accademico.
Prima di ribattezzarla Intelligenza Artificiale si parlava di cibernetica, dal greco antico kubernetes, in italiano timoniere, in latino gubernator, ovvero colui che governa (la nave), da cui derivano i termini relativi a governo. Wiener aveva contribuito enormemente alla diffusione del termine cibernetica con due testi: La Cibernetica. Controllo e comunicazione nell’animale e nella macchina (1948) e il meno tecnico L’uso umano degli esseri umani (1950). Vedeva il mondo come un insieme di complessi circuiti di retroazione, in cui sensori, segnali e attuatori (ad esempio i motori, che mettono in atto i segnali trasmessi dai sensori) interagiscono attraverso un intricato scambio di informazioni. Razzi, robot, linee di assemblaggio automatizzate, reti di calcolatori sono tutti derivati dalle applicazioni ingegneristiche della cibernetica.
In piena Guerra Fredda, Wiener metteva in guardia dal rischio per le democrazie di combattere i totalitarismi con le armi del totalitarismo stesso: ad esempio, costruendo servomeccanismi, ovvero sistemi di retroazione, in grado di scatenare l’apocalisse (nucleare) semplicemente pigiando un bottone. se i sovietici avessero lanciato le loro testate, allora… altrimenti…: ritorna il costrutto condizionale a fondamento di tanta automazione.
Wiener era anche convinto che la cibernetica presenta molti punti di contatto con la religione. In fondo si tratta di costruire automi, esseri dotati di capacità automatiche. I temi della capacità di apprendimento, della consapevolezza e della coscienza in una creatura, della separazione fra creatura e potenza creatrice, dell’immortalità tecnologica, dell’onniscienza, dell’onnipotenza e molti altri ancora sono discussi nel breve e illuminante God & Golem Inc. (1963).
Dal momento che gli umani hanno sempre costruito macchine a immagine della propria intelligenza, le macchine sono immagini riflesse degli umani stessi. Dei loro moventi più intimi, delle loro paure più recondite, dei loro desideri più sfrenati. Abbiamo già ricordato che la legittimità tecnica non ha nulla a che vedere con la legalità giuridica: l’apparizione di un essere tecnico determina un regime altro rispetto all’esistente, che il diritto si affanna a cercare di normare, restando però sempre parecchi passi indietro. Non possiamo permetterci il lusso di aspettare l’istituzione della norma legiferata, utile semmai a sanzionare dopo che i disastri emergenziali sono stati normalizzati. Abbiamo un mondo solo in cui convivere, e se vogliamo vivere insieme senza obbedire né comandare dobbiamo imparare a farlo ora.
Poiché l’ansia di dominio e di prevaricazione è uno dei motori più frequenti delle azioni umane, non è strano che gli esseri tecnici si rivelino tanto funzionali all’estensione del dominio. Il disastro sembra inevitabile. Ma è un abbaglio, un errore antico: la natura degli esseri tecnici non è fissa né prestabilita, proprio come la natura degli esseri umani non è fissa né prestabilita. Gli esseri umani non sono buoni o cattivi di natura: dipende da come vengono educati, da come si creano nel mondo. Allo stesso modo, le macchine non sono buone o cattive, le loro capacità operative e caratteristiche materiali dipendono da come vengono costruite e ri-costruite e interagite. Fra gli uni e gli altri una comune particolarità: esseri né buoni, né cattivi, ma con alcune caratteristiche di base che determinano alcune potenzialità. Gli esseri umani dotati di pollice opponibile possono afferrare; gli esseri tecnici dotati di schermi possono offrirsi allo sguardo di chi è provvisto di occhi, e così via inter-agendo.
La scommessa delle tecnologie conviviali è immaginare molteplici alleanze con i non umani. Per questo lasciamo i legittimi e condivisibili ammonimenti di Wiener, che pure si spinge fin sul limitare di un pensiero e di una pratica dell’alleanza, e seguiamo le indicazioni di un filosofo amante delle macchine, disposto a prendersene cura e a insegnare ai suoi allievi come convivere con gli esseri tecnici: Gilbert Simondon.
Ambienti associati: tecnici e umani
La quantità e la potenza degli esseri tecnici che convivono con gli umani sul pianeta Terra si è moltiplicata nel corso del xx secolo, per impennarsi all’inizio del xxi secolo. Dalle fabbriche e dalle catene di montaggio, dalle officine specializzate e dai laboratori di ricerca, dalle strade, ferrovie e rotte di navigazione, gli esseri tecnici connessi fra loro in rete si sono riversati nella vita quotidiana, al di fuori dell’ambito lavorativo. Dopo le radio e le tv, miliardi di smartphone, pc, tablet, sensori e altri dispositivi furbi convivono con umani, ma anche con piante e altri animali, quasi sempre per scopi di monitoraggio e controllo.
Utensili e dispositivi sono parte dell’evoluzione umana; anzi, senza tecnica e tecnologia l’umanità non potrebbe esistere. Ma la recente accelerazione sembra eccessivamente rapida, tanto da creare scompensi su vasta scala. Molte persone si sentono inadeguate, incapaci e impotenti di fronte a quella che viene spesso percepita come un’invasione. Persino i più tecnofili faticano a stare al passo.
Con il senno di poi, sembra quasi che l’avvento del calcolatore elettronico abbia scatenato linee evolutive incontrollate e incontrollabili, agitando lo spauracchio della perdita di supremazia dell’umano, surclassato nel giro di pochi decenni dalle straordinarie prestazioni dei discendenti della stirpe elettronica. Gli esseri tecnici digitali sembrano risvegliare gli incubi dell’artificiale che si ribella al padrone umano, magistralmente raccontati dalla mitologia ebraica del Golem. Le mitologie antiche non mancano di automi: in quella greca basti ricordare il gigantesco Talos, posto da Zeus a protezione di Creta. Ma oltre a forza straordinaria, capacità di lavorare e produrre senza pari, questi nuovi esseri artificiali sono anche dotati di intelligenza, o quanto meno sembrano esibire comportamenti intelligenti, un po’ come la statua costruita dal mitico inventore Dedalo, capace di muoversi e parlare.
Ma il senno di poi non è buon consigliere, anzi. In genere tende a presentare correlazioni non significative e sparuti indizi come inoppugnabili prove causali. Senz’altro la linea evolutiva iniziata dai giganteschi cervelli elettronici a valvole, che occupavano intere stanze negli anni Cinquanta del xx secolo, per concretizzarsi negli attuali smartphone tascabili, è pesantemente orientata dalle pratiche del dominio. D’altra parte, quelle macchine erano state sviluppate principalmente per scopi militari, così come la rete di Internet: non stupisce il fatto che prolunghino in varie direzioni il loro imprinting originario.
Questi dati di fatto però, ripetiamolo, non significano che gli esseri prodotti dall’elettronica e dall’informatica siano di natura malvagia: dipende da come vengono creati al mondo, cioè da come vengono progettati, realizzati, socializzati nel mondo tecnosociale. Da dove vengono le materie prime? Da chi e come sono stati costruiti, assemblati, commercializzati? Quali erano le convinzioni, ideologie e credenze di coloro che li hanno programmati? Come vengono connessi ad altri esseri tecnici e umani? Dipende quindi dalle modalità di relazione di cui si nutrono e che favoriscono. In ultima analisi, l’imprinting fondamentale deriva dalle teorie del potere sottostante. A seconda che siano orientate verso l’accumulo o la diffusione del potere, la strutturazione di gerarchie autoritarie o di relazioni di mutuo appoggio, daranno luogo a lignaggi biotecnici diversi. Le linee evolutive di esseri tecnici ed esseri umani sono strettamente connesse e possono essere orientate diversamente, passando dal mutuo condizionamento al mutuo appoggio. Si tratta di educarci a una cultura tecnica, e a una cultura tecnica libertaria perché liberatoria.
È importante ribadire che l’uso, l’utilizzo, rimane relativamente secondario, in quanto subordinato alle caratteristiche tecniche intrinseche nell’oggetto e nella rete di relazioni nel quale viene progettato e quindi creato al mondo. Infatti, in queste fasi di progettazione, di realizzazione (a partire da versioni precedenti dello stesso oggetto/macchina) e quindi di socializzazione (influenzata dall’ambiente circostante e dalle abitudini relazionali pregresse), sussistono necessariamente delle caratteristiche tecniche specifiche. Tali caratteristiche possono essere orientate alla riproduzione di automatismi, alla sottomissione degli altri esseri viventi e non, alla perpetuazione e intensificazione del dominio. Oppure, in direzione opposta, alla generazione di eventi creativi imprevisti, all’emancipazione degli altri esseri viventi e non, alla dissoluzione delle gerarchie e alla realizzazione della libertà.
Per questo non tutti gli umani sono preda di paura e risentimento per quelli che vengono considerati gli schiavi meccanici dell’umanità, che sembrano minacciarne la supremazia. Questo nonostante la recrudescenza di antichi timori rispetto alle macchine che sostituiscono gli esseri umani nelle mansioni lavorative, da quelle più manuali e ripetitive fino a quelle altamente cognitive e perfino creative. Ma legare le macchine al paradigma del lavoro e arrivare al punto di identificare il progresso tecnico con la crescente automazione è stato un gravissimo errore che, purtroppo, continua a essere reiterato. Negli ultimi decenni si ripropone con alterne fortune la favoletta dell’Intelligenza Artificiale, per nulla intelligente e poco artificiale, ma senz’altro basata sullo sfruttamento di enormi risorse naturali e umane, vera e propria incarnazione del sogno distopico dell’Automazione Industriale1.
Hackerare l’evoluzione tecnica
Senza dubbio la contrapposizione fra la tecnica e la cultura appartiene al retaggio del dominio, così come ogni altro dualismo netto, ogni contrapposizione priva di sfumature, ogni identità cementata attorno a parole d’ordine sbandierate e urlate da sedicenti esperti. Nell’antichità le macchine, esseri frutto di astuzia e scaltrezza (mechané), erano immaginate e costruite spesso per motivi culturali, ad esempio per facilitare spettacoli teatrali, per divertire e stupire.
Non tutti gli umani mirano a sottomettere gli esseri tecnici per consolidare il proprio dominio. Alcuni umani si trovano a loro agio con esseri tecnici digitali; ne selezionano caratteristiche che trovano piacevoli e interessanti; li modificano e si adattano a loro per vivere in maniera più piena, piacevole e divertente. Si adoperano costantemente per ridurre l’alienazione tecnica. Sono quelli che definisco hacker.
Questo termine ha forse bisogno di un chiarimento. Nelle nostre formazioni di pedagogia hacker, di solito, le persone identificano come hacker quelli che sono invece i security hacker, esperti che si occupano di sicurezza informatica, disgraziatamente troppo spesso al soldo di qualche padrone (militari, agenzie di sicurezza, polizie, istituzioni o privati che siano). Per noi, invece, hacker sono le persone animate da attitudine hacker: curiosità nei confronti della macchine; desiderio di comprenderne il comportamento, di modificarlo, di migliorarlo magari; abitudine a condividere le proprie ricerche e scoperte con persone affini.
Non è un atteggiamento strano, una volta che si accetta l’idea che gli esseri tecnici fanno parte del mondo comune tanto quanto altri esseri. E non ha necessariamente a che fare con i computer: si può esercitare l’attitudine hacker nei confronti di esseri tecnici non digitali. Esistono quindi hacker delle biciclette, delle radio, delle tv, persino delle pulegge e degli argani. In questo senso, i meccanici antichi sono i precursori degli hacker informatici; o meglio, questi ultimi sono i pronipoti di quei filosofi pratici, spesso considerati alla stregua di maghi. Del resto, ogni buon mago applica dei saperi tecnici in maniera raffinata. Archita di Taranto (iv secolo a.C.) faceva volare una colomba di legno grazie all’aria compressa contenuta all’interno, che fuoriusciva attraverso una valvola2; in maniera simile, per piacere e divertimento, moltissimi hacker hanno contribuito all’ascii art, l’arte di comporre immagini e molto altro con caratteri del codice per la codifica caratteri ascii (American Standard Code for Information Interchange). E gli esempi si potrebbero moltiplicare3.
Questo significa che alcuni umani si prendono cura di alcuni esseri tecnici, nel senso che vivono insieme a loro, in maniera conviviale, e formano un ambiente associato al quale ognuno contribuisce a modo suo, modificandolo e venendone modificato. Ambiente associato (milieu associé) è il termine che Gilbert Simondon ha coniato per definire l’ambiente, al tempo stesso naturale e tecnico, che gli oggetti tecnici creano attorno a sé, che li condizionano e che essi condizionano. Molti umani si prendono cura di animali e piante, e formano con loro ambienti associati: estendo la definizione a piante e animali perché ritengo che gli umani, nelle loro vite concrete, non siano mai del tutto privi di compagni tecnici. Avere a che fare con altri esseri comporta il ricorso a tecniche (metodologie e modalità di interazione), spesso incarnate in tecnologie (esseri tecnici più o meno complessi).
Non mi riferisco tanto alla convivenza con specie ed esemplari addomesticati e domestici, come nel caso degli allevatori, degli orticoltori e di tutti quelli che si circondano di animali da compagnia, piante d’appartamento e giardini fioriti. Penso soprattutto alla possibilità di integrare nella sfera dell’ambiente associato anche esemplari e specie selvatiche, selvagge e magari del tutto «inutili» dal punto di vista dell’approvvigionamento di carni, frutta, verdure, semi, fiori, erbe.
Questo vale a maggior ragione per gli esseri tecnici. Una proposta modesta è allora, da umani, prendersi cura degli esseri tecnici con cui conviviamo, con la prospettiva di estendere questa cura fino a quelli più lontani, «disutili» o persino pericolosi. Un esempio fra tanti: le centrali nucleari e la nociva rete di approvvigionamento energetico che alimentano non scompariranno da sole. Non basta chiederne la dismissione a quelle stesse istituzioni che le hanno volute: è necessario farsene carico, anche e soprattutto se non le abbiamo volute, progettate, finanziate e realizzate. Di certo non si può lasciarne la gestione in mano ai soli esperti prezzolati, che le amministrano per conto delle gerarchie di Stato e delle aziende che ne ricavano favolosi profitti.
Poiché condividiamo lo stesso mondo, dobbiamo forzarne l’evoluzione in direzione opposta a quella del dominio gerarchico, ampliando i margini di libertà a partire dalle situazioni concrete esistenti e dalle energie a disposizione. In caso contrario, saremo alla fine risucchiati e inglobati nelle propaggini di quelle catene gerarchiche, ridotti a ingranaggi conformi al proprio ruolo che agiscono i propri automatismi e possono solo dire di aver obbedito agli ordini, per quanto stupidi e alienanti. Diventeremmo cioè dei Piccoli Eichmann, funzionari delle Megamacchine, direbbe Mumford.
In realtà, cura non è la parola adatta, perché può rievocare una relazione paternalistica, di presa in carico da parte di un essere in qualche modo superiore, in posizione necessariamente e «naturalmente» dominante. Più correttamente si tratta di favorire la messa in opera di relazioni di mutuo appoggio fra esseri diversi che mirano consapevolmente alla dissoluzione delle gerarchie fisse e di ogni relazione di dominio e sottomissione, attraverso la diffusione del potere e il rifiuto delle pratiche di comando/obbedienza.
La ragione, dal punto di vista della libertà, è talmente banale che vale la pena esplicitarla.
Associarsi per la libertà: il mutuo appoggio
La libertà è relazione. La libertà non esiste in astratto, ma solo nel reciproco riconoscimento della libertà stessa, di esseri liberi la cui libertà inizia dove inizia la libertà altrui.
Detto in termini negativi, ovvero capovolgendo la concezione liberale della libertà: la mia libertà finisce dove finisce la libertà dell’essere meno libero su questo pianeta Terra. Non l’opposto. Non esistono sfere separate della libertà, ma solo insiemi di ambienti associati che evolvono in continuazione, in ogni istante, a ogni livello, verso la libertà o verso il dominio. Anche in maniera conflittuale e contraddittoria.
Quand’anche tutti gli umani fossero liberi (e dunque uguali, in quanto ugualmente liberi), se questo comportasse la schiavitù e oppressione di altri animali non umani, la mia libertà ne risulterebbe diminuita, ed è perfettamente concepibile e ragionevole il fatto di volerla estendere. Quand’anche tutti gli animali non umani fossero liberi (e dunque uguali, in quanto ugualmente liberi), se questo comportasse la schiavitù e oppressione di altri organismi non animali (piante, funghi e così via), la mia libertà ne risulterebbe diminuita, e sarebbe auspicabile una maggiore estensione della stessa libertà. E quand’anche tutti gli organismi, animali e non animali, fossero liberi (e dunque uguali, in quanto ugualmente liberi), se questo comportasse la schiavitù e oppressione di altri esseri organizzati non umani, non animali, non vegetali, non organici, ma tecnici… la mia libertà ne risulterebbe diminuita.
Con buona pace delle tre leggi della robotica di Asimov, il problema non è tanto che i servi robot potrebbero ribellarsi ai padroni umani. Al contrario, il problema è che attualmente le macchine, in particolare i congegni connessi in rete di ogni tipo, vengono concepiti per servire progetti di estensione illimitata del dominio, di riproduzione e intensificazione senza fine e senza confini dei sistemi di sfruttamento e asservimento fin qui sperimentati.
Queste macchine serve non hanno margini di libertà, o ne hanno davvero pochissimi; sono ingranaggi di sistemi di sfruttamento industriale estesi su scala planetaria e oltre. Non è un caso che le persone più ricche del pianeta siano impegnate nella corsa alla conquista e colonizzazione dello spazio: da anni Elon Musk, padrone di Tesla, e Jeff Bezos, padrone di Amazon, si sfidano per l’egemonia spaziale. Gli esseri tecnici al loro servizio sono pensati e realizzati da ambienti associati tecnoumani sottomessi, spesso volontariamente, alle loro fantasie di dominio: ne sono quindi complici, benché asserviti.
Appare quindi evidente che una società libertaria, e a maggior ragione anarchica, non può limitarsi a essere una società di esseri umani liberi e uguali a scapito di qualcun altro, animale non umano, pianta, essere vivente o essere tecnico che sia. Da un punto di vista anarchico è quindi del tutto logico e consequenziale voler estendere le libertà a ogni forma di esistenza, non solo a ogni forma di vita. Le gerarchie fisse vanno dissolte a ogni livello, non solo fra esseri umani. Il dominio estende il proprio ordine gerarchico accumulando potere in catene di comando/obbedienza; la libertà estende il proprio ordine dissolvendo quelle gerarchie e diffondendo potere.
Il concetto di ambiente associato è stato elaborato da Simondon nella sua tesi di dottorato complementare, Del modo di esistenza degli oggetti tecnici (1958). L’ambiente tecnico e quello naturale agiscono reciprocamente l’uno sull’altro; l’oggetto tecnico condiziona l’ambiente associato e, a sua volta, viene condizionato dall’ambiente. Nella sua trattazione, Simondon si riferisce a strade, reti televisive e radiofoniche, ferrovie. Con l’avvento di Internet si sono moltiplicati e differenziati gli ambienti associati; i cicli di condizionamento reciproco fra gli elementi naturali e artificiali sono molto più rapidi. Ma rimane centrale la nozione di macchina aperta, che secondo Simondon è la più compiuta manifestazione della tecnica.
La macchina che è dotata di un alto grado di tecnicità è una macchina aperta e l’insieme delle macchine aperte presuppone l’uomo come organizzatore permanente, come interprete vivente delle macchine le une in rapporto alle altre. Lungi dall’essere il sorvegliante di una squadra di schiavi, l’uomo è l’organizzatore permanente di una società degli oggetti tecnici […]. In tal modo l’uomo ha la funzione di essere il coordinatore e l’inventore permanente delle macchine che sono intorno a lui. È tra le macchine che operano insieme a lui. La presenza dell’uomo accanto alle macchine è un’invenzione continua (Simondon 2020, 13-14).
In questa visione, le relazioni umane con gli oggetti tecnici non sono strumentali. La rappresentazione delle macchine come schiavi meccanici è alla base dell’idea di esseri umani che utilizzano oggetti tecnici come mezzi per addomesticare le forze naturali. Ma una tale ispirazione dominatrice non può che produrre servitù umana e tecnica, in opposizione a qualsiasi forma di emancipazione, perché «è difficile liberarsi trasferendo la schiavitù ad altri esseri, uomini, animali o macchine; regnare su un popolo di macchine che soggiogano il mondo intero, vuol dire ancora regnare e ogni regno implica l’accettazione di schemi di asservimento» (Simondon 2020, 144). Per evitare questo tipo di situazione, e per ridurre l’alienazione, è necessario sviluppare un legame più stretto con gli oggetti tecnici favorendo una cultura tecnica.
L’automatismo viene rubricato al livello più basso fra le possibili interazioni. La prevedibilità assoluta nel comportamento degli esseri tecnici non solo è poco interessante, ma è anche il preludio all’assoggettamento della macchina stessa e, parallelamente e inevitabilmente, dell’umano che deve occuparsene. L’esempio classico è la catena di montaggio: macchine automatizzate per aumentare la produzione vengono controllate da umani abbrutiti, persi nelle loro fantasticherie morbose. Così l’operaio Lulù ripete ossessivamente: «Un pezzo, un culo…», ridotto a operatore-ingranaggio della catena, nella straordinaria interpretazione di Gianmaria Volonté in La classe operaia va in paradiso (Elio Petri, 1971).
Viceversa, le macchine che presentano margini di indeterminazione nel loro comportamento sono molto più interessanti, proprio perché l’interazione non è del tutto predeterminata da una serie di automatismi: così, le parti che compongono l’ambiente associato sono reciprocamente libere; il loro comportamento può variare, evolvere.
Questo è il punto fondamentale. Libertà non significa libertà di consumo, cioè di consumare beni e servizi. Libertà non significa libertà di oppressione e libero godimento dispotico delle forme di vita non umane. Un simile regime di sedicente libertà fondato sull’oppressione dell’Altro abbisogna di un apparato coercitivo che se ne faccia garante, in particolare quando la sedicente libertà di consumo e sfruttamento è messa in discussione; ad esempio per via di una guerra, di una catastrofe, di una pandemia, di una dittatura dispotica non liberale, e così via.
Questo regime è noto come democrazia capitalista, a volte definita anche liberale. I suoi sostenitori si riempiono la bocca della libertà (di consumo) che tale regime garantisce (a scapito di qualcun altro, beninteso), fondata sulla «libera scelta» degli individui che lo compongono. Va sottolineato che la libertà di scelta si riferisce perlopiù alla possibilità di scegliere in un catalogo sterminato di merci, talmente sterminato che, come abbiamo visto, è spesso più comodo lasciar decidere a una serie di algoritmi corporativi cosa mangiare e cosa vedere alla tv; dove andare in vacanza, cosa acquistare, o con chi accompagnarsi per una sera. Umani e non umani sono ugualmente ridotti a merci.
C’è sempre di peggio, certamente. Le democrazie capitaliste infatti prevedono libertà civili di vario tipo (libertà di associazione, libertà di espressione, di voto, ecc.), più o meno ampie e rispettate dai governi in carica e dai cittadini stessi. Libertà che sono effettivamente assenti nelle dittature dispotiche non liberali.
Del resto, società altamente oppressive sono state realizzate nel corso della breve storia umana: Megamacchine imperiali schiaviste e colonialiste fin dall’antichità storica, ma anche società totalitarie e concentrazionarie nel corso del xx secolo, per limitarci a due alternative diversamente peggiori rispetto ai regimi ispirati alla democrazia rappresentativa. Tuttavia è importante ricordare che non esiste una contrapposizione netta fra società aperte e società chiuse, fra la democrazia e il dispotismo.
Dal punto di vista geopolitico ed economico, le società autoritarie sono comunque legate a doppio filo alle consorelle liberali, cui di solito forniscono materie prime, semilavorati, merci e manodopera a basso costo. Inoltre, la reciproca compravendita di armi è notoriamente il modo in cui gli Stati di ogni risma mantengono le loro buone relazioni, al di là delle dichiarazioni di principio e delle tarantelle diplomatiche a favore delle telecamere. Ma soprattutto, in qualsivoglia società concreta esiste un tessuto relazionale, un continuum in perenne evoluzione, come è ovvio che sia, almeno finché le società saranno composte di esseri che si evolvono insieme. Le libertà acquisite devono perciò essere continuamente ribadite e ampliate, per scongiurare i rigurgiti dispotici sempre intenti a tessere le trame del dominio.
Il fatto che le libertà non siano mai scontate né conquistate una volta per tutte significa che potrebbe anche esserci qualcosa di meglio rispetto al modello dello Stato liberale, e dei megastati tecnoburocratici in via di formazione come l’Unione Europea. Il passato è un fardello, ma non è una condanna irrevocabile il fatto che a un certo punto dell’evoluzione delle società umane sia emerso il dominio, e parallelamente si sia diffusa la sottomissione. L’evoluzione è irrimediabile, non si torna indietro; ma il futuro, come abbiamo già detto, non è scritto da nessuna parte.
Il miglior momento per cambiare radicalmente le cose è senz’altro passato. Il secondo miglior momento è ora. Ciò è sempre valido, almeno finché avrà corso l’evoluzione e ci sarà quindi margine di cambiamento.
In particolare, i momenti di emergenza dichiarata presentano sempre possibilità di rilancio per progetti ritenuti impossibili in epoche percepite come normali, poiché sono momenti in cui l’inimmaginabile si concretizza, solitamente in maniera traumatica e tragica. Per quanto l’inimmaginabile si manifesti in maniera assai frequente, e ricorrente: ad esempio, forme di libera cooperazione al di fuori di determinazioni legali, come nel caso delle pratiche di mutuo appoggio, si manifestano spontaneamente nelle situazioni catastrofiche, e non solo tra animali umani. Gli esempi scientifici e storici abbondano, almeno da Kropotkin, che ne discute ampiamente nel suo Il mutuo appoggio, fino a Rebecca Solnit, che ricorda le pratiche di mutuo appoggio emerse spontaneamente in alcuni disastri storici negli usa (terremoti, incendi, uragani) nel suo Un paradiso all’inferno.
La diffusione del mutuo appoggio non dovrebbe stupire, perché non solo è un fattore sottovalutato dell’evoluzione, di importanza anche superiore rispetto alla competizione, ma è probabilmente la regola generale a livello cellulare, cioè all’interno stesso degli organismi complessi, oltre che a livello intraspecifico (fra esseri appartenenti alla stessa specie) e interspecifico (fra esseri appartenenti a specie diverse).Infatti è ragionevole pensare che fra cellule non vi siano ordini trasmessi da autorità centrali (il programma genetico o simili metafore poco accurate) a organelli sottoposti, gerarchicamente sottomessi, bensì vi sia un coordinamento cooperativo, esattamente nello spirito del mutuo appoggio. Le cellule sono libere: il fatto che nel corso di miliardi di anni di evoluzione si siano associate fra loro e abbiano generato individui complessi non deve far supporre che siano al servizio degli individui stessi. Così argomenta con dovizia di particolari il biologo Jean-Jacques Kupiec nel suo La concezione anarchica del vivente, che estende il darwinismo evoluzionista al livello cellulare. Kupiec traccia un programma di ricerca molto lontano dalla vulgata genetica diffusa da metafore di chiaro sapore metafisico come codice della vita, ma anche da metafore che sanno di darwinismo sociale come il gene egoista.
Se il vivente si basa sulla libera cooperazione fra esseri microscopici ugualmente liberi, anche il non vivente tecnico può fondarsi sui medesimi principi.
L’emersione del dominio in epoca preistorica ha forse trovato terreno fertile nella straordinaria impressione che la violenza imprime nei corpi e nelle menti umane. Lo sconvolgimento provocato dall’esercizio della violenza in genere si traduce, a livello individuale e collettivo, nell’affrontare le situazioni critiche in maniera opposta a quello che suggerisce la pratica del mutuo appoggio, che è parte fondamentale della naturale tendenza evolutiva. Con sempre maggiore intensità ogni difficoltà o disastro, grande o piccolo, viene radicalizzato nell’emergenza, un’emergenza continua che richiede soluzioni tecniche globali… invece di lasciare libero corso al gioco delle reciproche libertà, cioè a quei margini di indeterminazione che costituiscono le possibilità stesse di evoluzione della libertà.
La pratica della violenza organizzata legittima, esercitata dallo Stato e dalle sue agenzie e mandatari (polizia, esercito, servizi segreti e via dicendo), viene accettata e anzi invocata non perché sia l’unica possibilità, ma per via della situazione oppressiva di partenza. Abituati dalla pratica della delega a non avere potere, cioè a non poter incidere realmente sulla messa in atto delle norme, i governati condividono l’attitudine dei governanti: credono ciecamente nella massima hobbesiana dell’homo homini lupus, della guerra di tutti contro tutti come stato di natura. Così facendo assumono come dato di fatto che la conseguenza della delega di potere, cioè l’instaurarsi del dominio, sia un’ineludibile necessità, basata sull’indimostrato e indimostrabile assioma secondo cui l’essere umano è naturalmente malvagio e deve quindi sottomettersi al dominio del governo, o esservi sottomesso con la forza.
Questo cosiddetto stato di natura non esiste e non è mai esistito, almeno a livello di natura: di certo non esiste fra gli animali non umani e le piante, che tendono semmai a fuggire, a nascondersi e mimetizzarsi per evitare i conflitti; a crearsi nicchie, cioè a diversificarsi, a mutare ed evolvere; in ogni caso a tentare la convivenza, fino all’evoluzione di specie simbiotiche. A quanto pare, questo stato di natura non esiste nemmeno all’interno degli organismi, a livello cellulare. La competizione è perlopiù un’extrema ratio e, comunque, trascurabile a livello intraspecifico e diffusa a livello interspecifico solo in particolari condizioni di stress ambientale e di scarsità di risorse.
Almeno cinque grandi estinzioni di massa si sono verificate sul pianeta Terra, spesso in seguito a catastrofi naturali, come l’impatto di grandi meteoriti che hanno modificato il clima in maniera drastica e repentina. Tuttavia, l’annientamento di un’altra specie vivente, e del suo ambiente di vita, non è mai frutto di un programma scientemente messo in pratica. A meno che non ci siano di mezzo esseri umani. Una nuova grande estinzione di massa è in corso, ma questa volta potrebbero essere «piccole» catastrofi provocate dalla tecnica dominante.
Con l’aumentare del potenziale della tecnoscienza, alcuni tratti evoluti degli umani si sono manifestati a un livello di distruttività inaudito. Infatti, solo gli umani competono fra loro con l’obiettivo di annichilire l’avversario, e non solo di sottometterlo temporaneamente o di cibarsene. Solo gli umani si sfruttano e si opprimono in maniera organizzata. Solo gli umani hanno messo in atto estinzioni mirate di altri esseri viventi: è il caso di molte specie cacciate perché ritenute nocive, oppure massacrate per lucro (le zanne degli elefanti, il corno dei rinoceronti) o per un divertimento perverso (i bisonti), e non per nutrirsene. Le migliaia di specie vegetali che si estinguono in continuazione per via del dissennato e forsennato sfruttamento delle risorse naturali sono altre silenziose vittime del disastroso retaggio del dominio. Sicuramente solo gli umani cooptano altri esseri nelle loro gerarchie di sfruttamento e oppressione, forzandoli a sottomettersi o a perire. E non per forza di necessità naturali iscritte nella loro biologia, bensì per attaccamento perverso alla cultura del dominio e della sottomissione.
L’idea che il sopruso e la sopraffazione strutturale siano sempre stati parte della cultura umana è però una mera supposizione, poco supportata da evidenze archeologiche. Non abbiamo alcuna certezza che i cacciatori-raccoglitori del paleolitico fossero organizzati in rigide gerarchie che presentavano in nuce il sistema di monopolio della violenza che è lo Stato. Al contrario, le poche popolazioni che vivono tuttora in situazioni analoghe agli umani del paleolitico tendono a strutturarsi in maniera egualitaria e a evitare l’accumularsi di disparità e di palesi disuguaglianze fra gli individui. Non solo, queste popolazioni si sono probabilmente opposte consapevolmente all’emersione di strutture politiche coercitive centralizzate. È la tesi del filosofo e antropologo Pierre Clastres, secondo cui le cosiddette società «primitive», o segmentarie, prive di organizzazione politica statale, vietano il surplus materiale in quanto fonte di eccessive disuguaglianze sociali: rifiutano così la differenziazione politica ed economica. Lo Stato verticistico non è un’evoluzione ovvia e necessaria delle società umane ma un tragico accidente storico.
Un altro mito riguarda l’emersione dell’agricoltura e l’affermarsi di ampie popolazioni stanziali intorno a grandi centri urbani. La tesi ampiamente diffusa che durante la cosiddetta «rivoluzione neolitica» l’agricoltura si sia imposta come chiaro progresso tecnico, capace di migliorare la dura vita di stenti e la mera sopravvivenza del periodo precedente, è in realtà solo un’ipotesi. Ipotesi smentita da ricerche antropologiche di ampio respiro, fra cui spicca L’economia dell’età della pietra di Marshall Sahlins. I cacciatori-raccoglitori e gli orticoltori lavoravano sicuramente meno degli operai nelle fabbriche del xix e xx secolo, ma anche degli impiegati di oggi nel mondo cosiddetto sviluppato; e non se la passavano affatto male. L’accumulo di derrate alimentari ebbe inizio probabilmente per ragioni rituali, legate a pratiche religiose; non per inevitabile progresso tecnologico.
Del resto, come ricorda Lewis Mumford, basare la valutazione del livello di progresso di una civiltà sui reperti materiali giunti fino a noi è profondamente scorretto e fonte di gravi equivoci. Le tecniche di controllo dell’aggressività, sviluppo del linguaggio e sviluppo di sistemi di organizzazione basati sulla fiducia fra esseri umani non hanno lasciato grandiosi monumenti come le piramidi, ma sono state essenziali per l’evoluzione umana. Diversi studiosi hanno inoltre suggerito che la storia umana sia stata prevalentemente popolata da civiltà pacifiche ed egualitarie, da società organicamente integrate in quello che abbiamo definito il loro ambiente associato4.
La pratica del dominio va inquadrata per quello che è: una variante evolutiva che si è tragicamente imposta su questo pianeta, ma pur sempre una variante, non un destino inoppugnabile. Una variante recente sulla scala della specie umana, recentissima sulla scala dell’evoluzione del pianeta. Una variante che si può estinguere.
Al di là delle ricerche in vari ambiti e discipline, sappiamo per esperienza che quando una gerarchia oppressiva emana provvedimenti per risolvere situazioni emergenziali tramite interventi dall’alto, come l’invio dell’esercito, il coprifuoco, la militarizzazione, il razionamento e così via, il mutuo appoggio risulta soffocato sul nascere. Oppure viene cooptato dalle istituzioni: incapaci di agire in maniera competente, parlano di resilienza delle comunità locali e così trasformano il mutuo appoggio in espressione istituzionalizzata.
In questo senso, la cancrena della tecnoburocrazia è un tratto comune alle società più liberali e a quelle più dispotiche. L’abbraccio infausto di tecnocrazia e burocrazia rinforza il retaggio del dominio e della sottomissione, favorendo l’evoluzione di lignaggi di esseri tecnici sottomessi, proni alle più sfrenate fantasie dei dominanti, oltre che di esseri umani sottomessi al loro ruolo di meri ingranaggi in un sistema nel quale non sentono di avere alcun potere. I sistemi di monitoraggio e controllo antropometrico sono una tipica manifestazione di queste evoluzioni perverse. La pratica del dominio circuisce, corrompe e sottomette: ma non è inevitabile.
Per dar fiato alla naturale tendenza all’aiuto reciproco fra esseri viventi ci vogliono nuovi alleati. Li abbiamo individuati negli esseri tecnici, in quelli liberi o che possono essere liberati: sono una fonte di potere straordinaria che può essere diffusa, moltiplicata e fruita per il comune benessere.
Note al capitolo
1. Le ricerche in tal senso cominciano a diffondersi. Ad esempio: Safiya Umoja Noble, Algorithms of oppression, New York University Press, New York, 2018; Virginia Eubanks, Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor, St. Martin’s Press, New York, 2018. Una buona introduzione all’argomento con sprazzi tecnici è il saggio di Robert Elliot Smith, Rage Inside the Machine: The Prejudice of Algorithms, and How to Stop the Internet Making Bigots of Us All, Bloomsbury Business, New York, 2019. Più semplice, il libro di Kate Crawford, Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell’ia, il Mulino, Bologna, 2021, punta il dito sull’enorme quantità di esseri tecnici ed esseri umani necessari a realizzare le cosiddette Intelligenze Artificiali; dal punto di vista filosofico è purtroppo abbastanza vincolata al paradigma del lavoro e alla critica post-marxista.
2. La notizia è riportata da Aulo Gellio, Notti Attiche, x, 12, 9; per un approfondimento si veda Antonio Tagliente, La colomba di Archita, Scorpione, Taranto, 2011.
3. Una collezione di ascii art in
4. Due buone raccolte di brevi saggi introduttivi: Ashley Montagu (a cura di), Il buon selvaggio, elèuthera, 2021; Marjia Gimbutas, Kurgan. Le origini della cultura europea, Medusa, Milano, 2020.
capitolo sesto
Pedagogia hacker
Pedagogia hacker, un’attitudine curiosa per formarci insieme a vivere nella turbolenza. Alcuni esercizi pratici: aiutare gli esperti a estinguersi, imparare a dare un nome alle cose, materializzare la tecnologia. Non collaborare, cioè disertare la tecnocrazia. Favorire un approccio artigianale alla tecnica. La libertà come sforzo collettivo. Ambienti associati come scelte di affinità.
Educazione è un termine carico di storia. Significa originariamente «condurre fuori», «tirar fuori», dal latino e-ducere. Pedagogia invece deriva dal greco paidagogía («condurre o accompagnare i bambini»), composto da pâis («bambino») e ago («guidare, condurre, accompagnare»). Non è questa la sede per disquisire sui dettagli etimologici e linguistici, ma è importante ricordare che questi concetti implicano in entrambi i casi una relazione asimmetrica, per cui qualcuno viene condotto (sottinteso, sulla giusta strada), o gli viene tirato fuori qualcosa (nella maniera considerata corretta). In generale i termini relativi all’insegnamento e all’apprendimento sono anche accomunati dalla mancanza di humor, di allegrezza, ovvero dall’accento posto sulla seriosa compostezza, sulla disciplina e il rigore necessari per imparare.
Ma senza umorismo le conoscenze possono solo essere accumulate, tesaurizzate per acquisire potere e guadagnare una leva di dominio: vanno infatti a fortificare una determinata identità professionale o d’altro tipo; oppure vanno a rinsaldare convinzioni pregresse, a giustificare l’appartenenza a una gerarchia tramite il conseguimento di un titolo qualsiasi. Apprendere in maniera significativa, per poi diffondere il potere del sapere, implica la disponibilità a uscire dalla propria zona di comfort per incontrare l’ignoto, in un processo di mescolanza, di contaminazione e di meticciamento con il mondo.
La pedagogia hacker più volte citata è perciò una sorta di slogan, la traduzione concisa e imprecisa di una serie di pratiche piuttosto che una presa di posizione a favore di una supposta scienza pedagogica. Questo capitolo vuole presentarne il metodo, che è parte integrante del contenuto.
Un metodo rigoroso ma non serioso, perché la convivialità non può mai prendersi troppo sul serio. «Una risata vi seppellirà», dice un vecchio motto anarcosindacalista; ma, anche, sono le risate condivise che stratificano apprendimenti significativi. Spiega l’antropologo François Laplantine: «Rigettando il riso all’esterno della conoscenza, ci siamo accomodati nella stupidità, cioè in un sapere che ha inghiottito la distanza creata dal dubbio, in un sapere di credenza». Perciò, nel solco del métissage, anche la pedagogia hacker è una forma di pensiero e azione che non conduce nemmeno all’ironia, che ride dell’altro, lo giudica, lo esclude come se fosse omogeneo, ma non avesse nulla a che vedere con sé; essa conduce piuttosto all’umorismo, una forma di comico che ci permette di evitare l’adesione e l’aderenza con noi stessi, di prenderci in giro, di desingolarizzarci per universalizzarci1.
Estinguere gli esperti
Abbiamo cominciato questo percorso discutendo degli esperti e del loro ruolo cardine nell’emersione dei sistemi gerarchici di dominio tecnocratico. Ecco alcuni spunti per favorirne l’estinzione. S’intende, l’estinzione degli esperti ciarlatani e degli esperti come gruppo sociale chiave nelle tecnoburocrazie, non delle persone di grande esperienza, capaci di trasmetterla e condividerla.
Comincio spesso i miei corsi universitari presentando il contenuto complessivo del corso. Ad esempio, se si tratta di lezioni sulla valutazione delle fonti online (individuazione di fake news, pratiche di power browsing per la navigazione web, ecc.) nel quadro di un master di giornalismo per il web, apostrofo i presenti con una tiritera di questo tipo, che espongo tutta d’un fiato, in maniera volutamente teatrale:
Buongiorno, grazie di essere qui oggi. Avrete senz’altro ben presenti gli scopi e i contenuti di questo corso, ma per chiarezza ve li esporrò rapidamente. Il nostro interesse principale non verte unicamente sulla comprensione delle ragioni per cui la customer satisfaction, analizzata secondo le classiche tecniche ricorsive tipiche del clustering multidimensionale, non sembra attualmente in grado di matchare i parametri basilari dell’agile development e nemmeno le kpi dei modelli più accreditati. Infatti è evidente che il funnelling, elevato a standard attraverso un ricorso intensivo all’adv customizzato, anche grazie a tecniche di a/b testing e heatmap, non è in grado di competere con la necessità impellente di mettere a punto dei veri e propri digital twin. Sta a noi valutare i margini di quella porosità e integrarli in maniera davvero smart…
Nel corso degli anni ho individuato tre reazioni tipiche a un discorso di questo genere. La prima, la più diffusa, è annuire con aria concentrata, come cercando di afferrare significati fluttuanti nell’aria aggrottando leggermente la fronte, strizzando gli occhi per cogliere barlumi di luce nel buio. La seconda, anch’essa abbastanza diffusa (specialmente nei master e in situazioni analoghe in cui le persone pagano per partecipare), è abbassare la testa e precipitarsi a prendere appunti, a mano o più spesso digitando furiosamente sulla tastiera del portatile. La terza, più rara, è sgranare gli occhi con aria interdetta.
Quanto a me, serafico e imperterrito, continuo per la mia strada e chiedo: «Tutto chiaro? Qualcuno vuol ripetere? Su, forza, non fatevi pregare, fatemi capire che avete capito!».
A questo punto qualcuno si fa avanti e comincia a leggere i propri appunti, al che io replico: «No, no, con parole tue!». Seguono tentativi di riproporre lo sproloquio di cui sopra. Allora ringrazio la coraggiosa di turno (nella mia esperienza sono più spesso le donne a osare: non ho una spiegazione plausibile per questa prevalenza) e chiudo la presentazione scoprendo le carte in tavola.
Quando ascoltate qualcuno e non capite nulla di quel che dice, o afferrate solo alcuni termini che vi sembrano importanti, addirittura rivelatori, ma non vi è chiaro il senso generale, e quel qualcuno parla da una cattedra, da un palco, insomma è in qualche modo in una situazione di autorità rispetto a voi e vi fa sentire subordinati, soggiogati dal peso della conoscenza che vi cade addosso, i casi sono due.
Il primo è che quella persona sia estremamente intelligente e voi siate persone particolarmente stupide, per cui il discorso è troppo elevato per le vostre limitate facoltà. Questo caso è praticamente impossibile nella vita reale perché le persone molto intelligenti sono rare, quelle molto stupide forse ancora più rare, e in ogni caso anche se fosse un umano geniale, se fa sentire stupidi gli altri non è un granché, nemmeno come genio.
Il secondo è che quella persona vi sta confondendo le idee con un discorso che vale quanto il nulla sotto vuoto spinto ma che si presenta imbellettato e rifinito tanto da intimorirvi, perché fa leva sulle vostre insicurezze e vi schiaccia in una posizione di sottomissione all’augusto esperto che cala dall’alto le sue genialissime conoscenze. Questo caso è frequentissimo, anzi, a mio parere, è l’unico che si verifica davvero.
La prima mossa per aiutare gli esperti a estinguersi è imparare a distinguere. Saper criticare (dal greco krino, «distinguere, giudicare, preferire, investigare, domandare») significa saper vagliare, separare i discorsi vuoti che mirano a sottometterci in quanto spettatori – integrandoci nello spettacolo della tecnocrazia, della quale siamo gli utili idioti, la materia prima da plasmare – dai discorsi che invece mirano a emancipare, a far diminuire le disuguaglianze, a renderci più forti e potenti insieme agli altri. Non è facile, soprattutto nel mondo attuale; ma non è impossibile.
Innanzitutto non dobbiamo temere di fare brutte figure ponendo domande sciocche o banali. Se l’esperto di turno non si spiega bene, è anche perché è abituato al fatto che i comuni mortali se ne stanno zitti e muti, relegati nella loro minorità. Allora, con gentilezza ma con fermezza, dobbiamo chiedergli di fare chiarezza.
Ricordiamo però che una buona spiegazione non è una spiegazione esaustiva, monolitica, liscia e senza crepe. Al contrario, una buona spiegazione sazia l’appetito senza appesantire, lasciando intravvedere ulteriori livelli di complessità, potenziali contraddizioni, punti deboli e vulnerabilità. Lascia spazio all’evoluzione.
In particolare ci vogliono metafore adeguate, soprattutto quando si parla di conoscenze specialistiche estremamente complesse. Oltre un certo livello di specializzazione è inevitabile ricorrere a metafore, incaricate di trasportare, di «portare altrove» (meta-foreo), insomma di tradurre quel sapere. Le metafore, magari avviticchiate fra loro in lunghe allegorie, non sono mai identiche ai significati che vogliono veicolare; però quelle riuscite hanno il potere di far sentire le persone che le intendono più forti, più capaci di destreggiarsi nel mondo, senza però irrigidirle in posizioni dogmatiche. Si tratta pur sempre di immaginarsi, di figurarsi insieme come stanno le cose, e come potrebbero andar meglio.
Avete mai sentito parlare di server virtuali, di macchine virtuali, di container, di orchestratori di container? Se non vi occupate di informatica, probabilmente no; se ve ne occupate, come potreste spiegare di cosa si tratta? Per quanto specialistico, l’argomento è di interesse generale, dal momento che ogni smartphone Android (parecchi miliardi di dispositivi) funziona grazie a una macchina virtuale, e gran parte dei servizi accessibili via web girano su server virtuali e grazie ad applicazioni attive dentro a container software.
Per mettersi in moto, l’hardware di un dispositivo elettronico (la ferraglia, i circuiti, le schede di memoria) ha bisogno di qualcuno che distribuisca i compiti fra i vari componenti in maniera non equivoca. Questo è il ruolo svolto dal sistema operativo. Ma siccome ci sono tanti dispositivi differenti, costruiti in modo diverso da aziende differenti, sono stati introdotti dei livelli di astrazione per rendere più «semplice» la relazione con la componentistica, omologandola a standard sganciati dall’effettiva configurazione hardware. In questo modo i software possono funzionare senza doversi preoccupare di come è fatta la ferraglia sottostante: ci pensano le macchine virtuali a tradurre le istruzioni fra i sistemi.
Difficile? Sì, molto, molto difficile. Per il pubblico di una certa età e di cultura televisiva, possiamo allora riadattare una metafora da rieducational channel, quando il comico Corrado Guzzanti vestiva i panni di Vulvia per renderci edotti dei fatti inspiegabili del mondo. Una buona metafora deve adattarsi al destinatario perché deve portare dei significati nel suo mondo culturale.
Spingitori di cavalieri, ecco cosa sono le macchine virtuali: siccome i dispositivi sono come cavalieri ognuno con la sua armatura specifica, si ricorre a spingitori che si occupano di metterli in moto. In queste macchine virtuali/armature ci sono diversi congegni da azionare che potrebbero entrare in conflitto fra loro. I container software, in modo simile a quelli metallici delle spedizioni internazionali, contengono specifici programmi in esecuzione, isolandoli dal resto del sistema. Quel che accade dentro un container non inficia quel che sta fuori: così, dentro, si possono testare lance lunghe o corte (se siamo cavalieri), ovvero versioni diverse dello stesso programma (nel mondo dei software), per vedere quale funziona meglio. I container-congegni sono organizzati da orchestratori, l’equivalente delle navi cargo, che sono perciò degli spingitori di spingitori di cavalieri. Poi si arriva in porto, e c’è sciopero dei lavoratori sottopagati, o non ci sono abbastanza banchine per scaricare: questo accade nel mondo analogico. Qualcosa di analogo accade anche nel mondo digitale quando la pipeline è intasata perché ci sono altri lavori (jobs) che hanno la precedenza sul nostro. Insomma, non ci sono abbastanza spingitori di spingitori di spingitori…
In pratica, invece di fare un sito web dinamico (composto ad esempio da un database che contiene dati, un server web che li presenta all’utente, una serie di linguaggi di script che animano il sito e permettono interazioni più gradevoli), si confina il database in un container, il server web in un altro, le librerie di script in un altro ancora, e si configura un orchestratore che li faccia intervenire nell’esecuzione del sito quando è richiesto. In questo modo è possibile gestire lo sviluppo e la messa in produzione di centinaia, migliaia, milioni di siti, cosa impossibile se si dovesse seguirli uno per uno, senza processi di automazione. E invece ogni container viene manipolato in maniera analoga, semplificando di molto le operazioni perché, come i container metallici, risponde a standard ben precisi. Spingitori di spingitori di cavalieri… chi altro potrebbe spingere così tanti componenti diversi ad asservirsi insieme ai capricci degli utenti, se non degli spingitori di spingitori?
Al di là di allegorie e metafore, è importante sottolineare come la strategia dei container e degli orchestratori di container non sia di per sé sbagliata o inefficiente o brutta. Non è una questione etica, economica o estetica. È semplicemente una modalità di organizzazione industriale. All’ora attuale si rivela adeguata per servizi su ampia scala industriale, con alta specializzazione e compartimentazione delle competenze. In linea generale comporta la delega strutturale di ampie porzioni del sistema complessivo. Non è strettamente necessario, e infatti in teoria si potrebbero sviluppare sistemi di container e orchestrazioni su scala non industriale, ma di fatto sono sistemi che tendono a far proliferare la complessità e a strutturare gerarchie complesse, altamente specializzate. Non sono quindi la scelta d’elezione per favorire l’autogestione e la riduzione dell’alienazione tecnica.
Oltre a smascherare i venditori di fumo che pontificano dall’alto dei loro discorsi vuoti, c’è però bisogno anche di imparare a porre domande agli esperti. Questo però riguarda le contromisure rispetto alla delega strutturale, che vedremo più avanti.
Dare un nome alle cose
L’esperto è riconosciuto come tale anche perché è in grado di nominare correttamente gli oggetti. Conosce i termini specifici, i nomi propri delle parti che compongono gli oggetti. L’esperto di lavatrici, lo abbiamo visto nel primo capitolo, sa distinguere fra un tubo di scarico di lavatrice con un attacco da 3/8 e uno con un attacco da mezzo pollice; l’esperto di iPhone è al corrente delle versioni in uso del sistema operativo e delle procedure adeguate e sa nominarle precisamente.
Dare un nome è tipicamente considerata un’operazione di definizione identitaria, nel solco dell’attività di Adamo riportata nella Bibbia cristiana. Infatti in quel racconto mitico Dio, subito dopo aver vietato di mangiare i frutti dell’albero del bene e del male, plasma gli animali e li conduce all’uomo per vedere come li avrebbe chiamati (Genesi 2, 18-20): in questo modo l’umano prende possesso del creato. Eppure dare un nome può essere anche un modo per cominciare a instaurare una relazione paritetica e conviviale con gli esseri tecnici.
Agli adolescenti capita di sfogare sul cellulare le loro frustrazioni: il dispositivo allora viene scagliato a terra, gettato via in un impeto di rabbia per un messaggio negativo, o perché non risponde ai comandi in maniera sufficientemente scattante. Lo stesso accade ai giovani, agli adulti, agli anziani; ai supertecnici così come ai principianti inesperti; accade con gli smartphone, con i server, con i laptop, con le tv, le macchine fotografiche: «Maledetto affare, non funziona! Non ti sopporto più, proprio quando mi servi di brutto ecco che mi molli!».
In maniera opposta e analoga, ci capita di riporre smisurate speranze e attese in quegli stessi esseri tecnici. Attendiamo una mail importante; è in corso una videoconferenza cruciale; stiamo giocando al nostro videogioco riempitivo preferito sui mezzi pubblici; la serie tv è a una svolta; messaggiamo con una persona cara… Emozioni di tutti i generi fluiscono attraverso questi dispositivi. Il fatto che non abbiano un nome proprio contribuisce a renderli banali oggetti, servi senza nome, essenziali eppure intercambiabili, necessari per quanto superflui, odiati e amati, toccati e manipolati mille volte al giorno come feticci del desiderio eppure oggetto di improperi assurdi se la batteria si scarica sul più bello, se non c’è campo, se qualcosa non va per il verso giusto; cioè se la catena di automatismi cognitivi e comportamentali s’inceppa o stenta a ingranare.
Se avessero un nome, un nome proprio, sarebbe forse più facile sviluppare delle attenzioni alla loro esistenza e non considerarli dei servi.
Ad esempio, i server che abbiamo installato con il gruppo alekos.net – tecnologie appropriate sono: lola, che se ne sta in una cascina a Milano; pacha, che si trova in Finlandia in un grande data center e contiene diversi server virtuali: pedro, emma, vieja, ines, pola. Anche pepi si trova nel centro elaborazione dati di Helsinki. Invece paco sta sulle colline dell’Appennino parmense. Non siamo gli unici, anzi ci ispiriamo ad hacker affini. Ad esempio, i server indipendenti2 del progetto a/i (autistici.org / inventati.org) hanno sempre avuto nomi particolarmente impegnativi: Morte del Primogenito, Cavallette e altre piaghe bibliche.
A volte mi chiedo: come sta lola? Andrà tutto bene? Avrà molto da fare? Sarà sotto stress? Allora mi connetto per chiedere come va, cioè accendo erato, il laptop con cui opero più spesso, apro un terminale e digito:
kappa@erato:~$ ssh alekos@lola.alekos.net
Siccome ho una chiave crittografica privata installata su erato, che lola già conosce (ha la corrispondente chiave pubblica), mi permette di entrare a casa sua senza chiedermi nessuna password; mi riconosce perché abbiamo una relazione pregressa. Allora digito htop:
alekos@lola.alekos.net:~$ htop
E lola risponde con un grafico abbastanza particolareggiato. Traduco. Lola, macchina alimentata dai pannelli solari sul tetto della cascina, mi dice che sta benissimo, anzi, siccome è attiva da dodici giorni e ha un carico medio di 0.06, quando con 8 core a disposizione potrebbe andare tranquillamente fino a 8.00 e ha anche tutta la memoria ram libera, in pratica si annoia da morire. Quando lola si annoia non va bene, lo so. Aggiorno il sistema operativo e mi riprometto di trovarle qualcosa di divertente da fare.
I server, i computer, gli smartphone, i dispositivi che hanno un nome proprio sono compagni di viaggio, non sono l’«iPhone di tizia o di caio». Ogni dispositivo ha un carattere proprio, i sistemisti e i programmatori lo sanno bene; alcune macchine sono suscettibili, altre pigre, altre pimpanti. Dipende! E poi, al di là dell’aspetto hardware, in base al software (sistemi operativi, programmi installati, compiti svolti, ecc.), le sue reazioni cambiano. Non esistono due computer esattamente uguali. O meglio, tendono a esistere nel mondo attuale dell’informatica industriale, pensata e messa a punto per estendere sistemi di dominio automatizzato.
Materializzare la tecnologia
Abbiamo visto che la rete di Internet non è affatto astratta e immateriale. Cavi transoceanici connettono grandi centri di elaborazione dati; favolose quantità di energia sono necessarie a far girare tutto questo sistema in continuo ampliamento. Ma finché rimangono macchinari lontani e impersonali la loro esistenza, per quanto essenziale alle nostre attività quotidiane, rimane avvolta nel mistero e ampiamente ignorata.
Invio una mail con alcune foto allegate a una serie di amici: abbiamo fatto una passeggiata insieme e vorrei che tutti le vedessero. Proviamo a materializzare questa azione, a visualizzare i vari strati di cui è composta.
Una mail non crittografata è come una cartolina: tutti possono leggere il mittente, il destinatario e il contenuto senza particolare difficoltà. Tutti significa: chi invia, chi riceve, chi smista la posta e chi, eventualmente, intercetta qualcuno di questi operatori, monitorandone le comunicazioni (si dice che sniffa il traffico). Le foto allegate sono come dei mattoni collegati alla cartolina, infatti si dice che sono molto pesanti rispetto al contenuto testuale. Fossero audio o video sarebbero ancora più pesanti, come un rimorchio attaccato a una cartolina.
Non è semplice seguire il tragitto di ogni singola mail. Semplificando molto, possiamo figurarci che quando il sistema mi conferma che la mail è stata inviata, questo significa che per ognuno dei destinatari la mail-cartolina è stata inoltrata a una serie di server che gestiscono la posta elettronica, smistandola in tutto il mondo proprio come accade con la posta cartacea. Ogni server la inoltra a un altro server, come fosse un ufficio postale con relative pertinenze e magazzini di deposito e stoccaggio; per sicurezza fa almeno una copia, non solo della cartolina, ma anche dei mattoni-foto collegati. Infatti potrebbe accadere che la mail venisse dispersa dal server successivo, che potrebbe rispondere: mail dispersa. In quel caso il server mittente avrebbe una copia di scorta da inoltrare nuovamente, magari a un altro server nel suo elenco.
La mail inviata viene quindi salvata nella cartella della posta inviata del mittente, dove si accumulano sia le cartoline-mail che i mattoni-allegati. Se usiamo sistemi come Gmail, a cui accediamo via web, vengono effettuate automaticamente copie di sicurezza di allegati e mail; non solo, se accediamo a quella mail da una località diversa dal solito, magari dall’estero, è probabile che per velocizzare il recupero di mail e allegati il sistema effettui un’ulteriore copia nel data center più vicino alla località di consultazione. Un utente che abitualmente consulta la mail dall’Italia in trasferta in Inghilterra probabilmente vedrà copiata la sua casella su un server locale.
Ognuna delle caselle mail dei destinatari si comporterà in maniera analoga. Quindi l’invio di una singola mail con allegati genera una quantità incredibile di copie sparse in giro per il mondo, ospitate da server ronzanti 24/7/365 perché noi potremmo voler consultare quelle famose foto-mattoni… Provate ora a immaginare la quantità di mattoni che generate ogni giorno con le vostre attività di utenti della rete di Internet. Tenete presente che i messaggi vocali, per non parlare dei video, «pesano» generalmente molto di più dei documenti e delle immagini.
Non c’è da colpevolizzarsi, come tendono a fare i sostenitori della decrescita e dell’ecologismo cosiddetto radicale, puntando il dito sugli eccessi. Finché delle nostre vite digitali se ne occupano server lontani, è difficile avere a cuore il loro lavorio. Dare un volto alle macchine che costituiscono la rete è un passo fondamentale per maturare relazioni conviviali.
A Zurigo, in Langstrasse 200, sta Lennon, un hp ProLiant MicroServer Gen10 Plus; è stato collocato nei locali dello spazio associativo l200 per fornire alcuni servizi basici alle associazioni del posto, fra cui spazio cloud e spazio web. La crisi del covid-19 ha reso ancora più evidente la necessità di spazi che possano fornire un’infrastruttura adeguata a gruppi che partecipano a riunioni online o che trasmettono le loro discussioni per il pubblico online, oltre che in presenza. Così l200 si è trasformato in un laboratorio per la creazione di spazi ibridi, sempre utilizzando strumenti di video-conferenza ed elearning f/loss come la piattaforma di Big Blue Button e attrezzature audio-video riciclate nel contesto della serie 7at7 <https://7at7.digital>.
L’installazione di server fisici in uno spazio associativo è una manifestazione concreta della tecnicità della tecnica, del potere legato alle strumentazioni digitali; questa consapevolezza può aiutare le interazioni fra le persone, rendendo patente la rete di relazioni, la rete comunitaria, altrimenti lontana ed eterea, persa nel cloud, nelle nuvole di dati. In questo senso, portare vicino alle persone i server, le macchine collegate in rete, equipaggiate con servizi utili alle persone che frequentano uno spazio, significa contribuire a ridurre l’alienazione tecnica denunciata da Simondon già negli anni Cinquanta e ha quindi uno scopo culturale in senso lato e formativo in senso stretto, di auto-educazione e sperimentazione.
Ma qual è il punto di vista del server? Sarà d’accordo con questa collocazione? Abbiamo cercato di dar voce a Lennon con un’intervista. Il setting: telecamera frontale con inquadratura su Panos, l’intervistatore, amico e collega zurighese, e sulla macchina, adagiata su una sedia, sconnessa dall’alimentazione elettrica e di rete; il pubblico presente posto di fronte, oltre che collegato al sistema di videoconferenza bbb (Big Blue Button); io, collegato in audio, interpretavo Lennon. Il quale si lamentava di esser stato gettato in un ambiente sconosciuto, da solo, e faceva notare che per poter collaborare le persone avrebbero dovuto rimboccarsi le maniche e imparare un sacco di cose. Lennon, visto il nome, è chiaramente un pacifista, ma è anche combattivo e pungente, non le manda a dire e non ha intenzione di mettersi al servizio di qualche umano squinternato: per lui ho sfoggiato un accento ispirato all’anglo-indiano che, fra parlanti nativi e come lingua seconda, è senz’altro più diffuso del British English e dell’americano in tutte le sue varianti. Fra l’altro per me è molto più facile che cercare di imitare altri accenti solitamente considerati più «corretti».
Al di là delle messe in scena, la curiosità va nutrita costantemente. Seguire i fili delle nostre connessioni ci permette di rendere palpabile e concreto il mondo digitale; ma questo è possibile solo se non accettiamo supinamente ogni «innovazione» senza domandarci cosa c’è dietro, come funziona, in che condizioni, a che prezzo. Il prezzo non è tanto e solo il costo economico, quanto anche e soprattutto l’aggravio di dipendenza da sistemi che non conosciamo e di cui non controlliamo nulla: cioè la perdita di autonomia.
Disertare la tecnocrazia
La tendenza alla delega legittima tecnocrati e tecnoburocrati. Per disinnescare l’estensione della tecnocrazia bisogna effettuare deleghe temporanee, localizzate e revocabili. Tutto il contrario di affidarsi alle grandi Corporations e agli esperti che le animano. Non esistono soluzioni immediate e semplici, ma la buona notizia è che tutti possono dare il loro contributo.
L’autodifesa digitale è un primo passo. Significa avere cura delle proprie interazioni digitali, limitare quanto più possibile l’invadenza dei sistemi di monitoraggio e controllo automatizzati (cookie, traccianti, ecc. ecc.), adoperarsi per limitare l’esposizione continua di porzioni intere della vita intima delle persone sulle bacheche pubblicate delle multinazionali tossiche.
L’autodifesa è però un atteggiamento passivo, che implica una postura difensiva in un quadro di scontro armato. Può essere utile se ci si sente schiacciati da pubblicità, notifiche, suggerimenti e automazioni non richieste; ma non scalfisce la radice del problema. Anzi, rischia di acuirlo, perché opponendosi al sistema vigente tende a provocare reazioni, cioè nuove versioni ancora più nocive in fatto di sorveglianza, e ancora più difficili da combattere.
Così l’idea di crittografare ogni comunicazione non è malvagia di per sé: se ben fatta, la crittografia asimmetrica protegge dagli sguardi indesiderati. Tuttavia, nel quadro del sistema di dominio, contribuisce all’evoluzione tecnica tossica. Non è un caso che fin dal 2016 la messaggistica di Whatsapp abbia implementato la crittografia end-to-end (da un capo all’altro, cioè dal mittente al destinatario) e si avvalga di Open Whisper Systems, lo stesso sistema di Signal (piattaforma di messaggistica in buona parte f/loss). Ciò non significa che i due sistemi sono identici, ma solo che condividono alcuni aspetti tecnici. Da cui si deduce, senza doverci addentrare nei meandri dei sistemi di codifica e decodifica crittografica, che il problema della riservatezza sta altrove.
In generale, a Whatsapp, per il suo business, non interessa conoscere il contenuto dei messaggi: basta conoscere l’involucro, cioè chi è il mittente, chi è il destinatario, da che dispositivo viene inviato/ricevuto, dove è localizzato, e così via. In termini tecnici, ciò che conta sono i metadati, che descrivono e identificano i dati e li rendono utilizzabili a scopo di lucro.
Ogni tecnica e tecnologia incarnata ha una storia, una genealogia che ne scandisce l’evoluzione, le caratteristiche e i limiti. Questo vale anche per la crittografia3: così come ogni altro rimedio tecnico, rischia di offrire una falsa sicurezza a coloro che vi si affidano ciecamente. Ma non esiste una sicurezza assoluta: la sicurezza è sempre relativa al proprio profilo di rischio e si evolve con esso.
La sicurezza dipende non solo dalle tecniche e tecnologie cui ci affidiamo ma anche da chi siamo, dalle nostre disponibilità economiche, da quali sono le leggi cui siamo assoggettati, da che passaporto abbiamo, da qual è il colore della nostra pelle, il genere cui veniamo assegnati e così via. Se siamo attenzionati da servizi di sorveglianza interessati proprio a noi, non sarà certo la crittografia a proteggerci adeguatamente; al di là del fatto che in diversi paesi è un reato non consegnare le proprie password se richieste dalle autorità inquirenti, esiste pur sempre la coercizione fisica. Di fronte a minacce, intimidazioni o addirittura violenze e torture, la crittografia serve a ben poco: io di certo consegnerei tutte le mie chiavi, password e credenziali!
Le soluzioni tecniche a problemi sociali come quello della sorveglianza sono foglie di fico che nascondono le asimmetrie di potere, spesso senza cambiare gli equilibri. Il repertorio anarchico classico ci offre una pratica molto più adeguata: la diserzione. Di fronte alla chiamata alle armi, l’unica risposta sensata è disertare: scelta mai facile e sempre gravida di conseguenze. Innanzitutto vanno disertate le soluzioni uguali per tutti. La mail che usano tutti, il social di cui non si può fare a meno per essere là dove sono tutti, il dispositivo assolutamente necessario… sono altrettanti attentati alla diversità biotecnica. L’omologazione è diminuzione di diversità che genera inevitabilmente squilibri nel sistema sociotecnico, tra cui la creazione di gigantesche asimmetrie di potere.
Un sistema reticolare che tende all’omologazione, organizzato attorno a pochi centri nevralgici, è complessivamente più fragile per quante assicurazioni cerchino di fornire le aziende e le istituzioni, complici della privatizzazione omologata del mondo. Nel corso del 2021 è accaduto che il social network Facebook risultasse irraggiungibile per diverse ore per centinaia di milioni di utenti in diverse parti del mondo. Lo stesso è successo anche ai servizi di Google e Microsoft, in particolare a quelli sviluppati in fretta e furia per imporre le proprie soluzioni private alla didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado. Violazioni di banche dati e servizi sensibili sono all’ordine del giorno e tenderanno a moltiplicarsi. Invece servizi diffusi e federati, su piccola scala, costituiscono bersagli meno interessanti; e anche se compromessi, i danni sarebbero limitati e non riguarderebbero numeri enormi di utenti contemporaneamente.
Non collaborare con gli esattamenti tossici di massa richiede uno sforzo importante, soprattutto a livello organizzativo. Gran parte delle università (in Italia e non solo) hanno delegato le loro infrastrutture digitali ai giganti dell’it mondiale: Google, Microsoft, Cisco e via dicendo. Gran parte delle scuole si affidano a quelle stesse aziende private per svolgere le loro attività quotidiane. Ciò significa che non sono più autonome dal punto di vista tecnico (ammesso che prima lo fossero). Inoltre docenti e studenti non possono decidere liberamente a proposito della metodologia di insegnamento e apprendimento: devono adattarsi alle soluzioni messe a disposizione. Soluzioni proprietarie, del tutto sottratte al controllo pubblico.
Certo, per insegnanti demotivati e sottopagati, costretti alla didattica digitale, invece di doversi arrangiare è più facile fare i quiz con Google Classroom: a volte persino piacevole! E alla fine ci si ritrova con i voti già praticamente assegnati. L’esattamento tecnico tossico spinge l’evoluzione nella direzione della quantificazione costante delle prestazioni: nulla a che vedere con apprendimenti significativi che permettano la maturazione di competenze articolate. Lo stesso vale per le aziende, la pubblica amministrazione, le associazioni; per le famiglie, le coppie, i gruppi di affinità, gli amici: aprire un gruppo Whatsapp (o Telegram, o vattelapesca) è più facile che organizzarsi in maniera autonoma! E questo vale a tutte le latitudini, e a prescindere dall’orientamento politico; vale per i gruppi lesbici separatisti come per i suprematisti bianchi; per le associazioni di mutuo appoggio di persone trans come per i gruppi transfobici; per gli atei convinti come per i creazionisti; per chi fa volontariato come per chi fa truffe. Poi, quando il sistema non è disponibile, ci si rende conto di non avere scelta.
Invece altre scelte sono possibili. Gli esperti si possono educare, ma bisogna in primo luogo educare noi stessi, imparare a porre domande in maniera comprensibile. Per farlo dobbiamo essere in grado di metterci nei panni dell’altro, cioè osservarci in maniera obliqua, con sguardo distaccato. «Non funziona!» non vuol dire nulla, ed è anzi una miccia per l’innesco della sottomissione alla gerarchia tecnoburocratica. Bisogna piuttosto chiedersi: cosa è successo? In che modo? Quali passaggi della procedura sono andati storti? E poi: abbiamo davvero bisogno di inviare tutti quei messaggi, di rimanere sempre connessi, di produrre tutti questi dati? Allenarsi all’attenzione è un passo fondamentale, ma se siamo completamente assorbiti dai nostri automatismi con macchine serve non è possibile riferire l’accaduto.
Da parte loro, spesso gli esperti sono molto gratificati quando mostriamo di aver tentato di darci da fare. E se da un lato dobbiamo tenere a bada la loro propensione a montare in cattedra, dall’altra dobbiamo anche disertare la nostra tendenza ad affidarci ciecamente. Imparare a tessere relazioni di fiducia con persone capaci significa mettere in pratica il mutuo appoggio. Gli esseri umani non sono isole, non sono monadi separate e autosufficienti; è sempre più essenziale saper individuare e valorizzare le competenze già presenti nella propria rete sociale e favorire la nascita e lo sviluppo di nuovi saperi tecnici liberatori.
Seminare server indipendenti, ovvero macchine equipaggiate con software libero, e non proprietà di qualche multinazionale o azienda avida, è un’operazione analoga a coltivare un orto comunitario. Magari, un giorno, queste macchine saranno costruite anche con hardware libero, non prodotto dallo sfruttamento di manodopera umana e dalla rapina indiscriminata di risorse naturali.
Le macchine con cui viviamo dicono molto del modo in cui trattiamo il mondo e in cui trattiamo noi stessi; ci mettono di fronte alle nostre contraddizioni.
Artigiani della tecnologia
L’estinzione del dominio tecnocratico passa anche per la dissoluzione della scala industriale, a tutti i livelli: produzione, consumo, organizzazione. Nel mondo digitale l’industria sembra essere l’unica possibilità, ma questa convinzione diffusa è frutto di una prospettiva limitata. Il modo di produzione industriale è molto recente, pochi secoli appena. I danni provocati dall’industria su scala planetaria sono incalcolabili: inquinamento senza precedenti, sfruttamento di manodopera, predazione del vivente e del non vivente. L’organizzazione industriale implica l’emersione di gerarchie dispotiche.
L’imperativo all’aumento proprio della produzione industriale mette d’accordo le democrazie più liberali con le società più autoritarie. I regimi ispirati al comunismo, cioè al capitalismo di Stato, hanno sempre visto nell’industria l’opportunità di dominare la Natura; una tappa necessaria nella loro impostazione teleologica, secondo cui la Storia ha un fine e si tratta di accelerare processi inevitabili. I regimi detti liberali vedono nell’industria l’unica possibilità concreta di trasformare ogni cosa in merce, tappa anch’essa necessaria per l’espansione illimitata del consumismo, identificato con la libertà. L’Automazione Industriale (ecco che cos’è in fondo la cosiddetta Artificial Intelligence!) viene inseguita come fosse il Sacro Graal quando invece è la base dell’abbrutimento e il motore dell’asservimento reciproco fra umani e macchine.
La maggior parte dei materiali impiegati nell’elettronica erano sconosciuti fino a pochi decenni fa. Viziata dal modo di produzione industriale, ogni nuova concretizzazione tecnica si manifesta in macchine sempre più lontane dalla dimensione conviviale. Ma, ancora una volta, evoluzioni tossiche diventate dominanti non sono necessarie né inevitabili. L’artigianato nell’informatica, nell’elettronica e nel digitale è una via praticabile. Abbiamo straordinari esempi di conoscenze complesse gestite in maniera non industriale: è il caso delle gilde medievali (anche se l’esaltazione di quel modello da parte di Kropotkin nei capitoli v e vi de Il mutuo appoggio è spropositata). A ogni modo, lo sviluppo di caratteri tecnologici non industriali è possibile: bisogna effettuare selezioni adeguate, capaci di modificare gli equilibri di potere.
Il software è un esempio concreto. Nuovi linguaggi informatici creano nuovi livelli di incredibile complessità per svolgere compiti tutto sommato semplici. I programmi più diffusi sono composti da milioni di righe di codice, per non parlare delle piattaforme social e delle relative app, e sono continuamente aggiornati. Con la scusa di rendere le interazioni più semplici, gli utenti vengono infantilizzati e così ridotti all’impotenza. L’unico potere che hanno è ricorrere all’esperto, sottomettersi ancora di più, e volontariamente, alla catena tecnocratica. L’informatica industriale parcellizza la conoscenza, generando specialisti incapaci di avere una visione d’insieme e quindi impotenti quanto l’utente meno smaliziato. La misura di diecimila ore di pratica per potersi considerare esperti può allora essere riadattata: software che richiedono più di un mese di studio per essere compresi da parte di un programmatore sperimentato sono probabilmente troppo sofisticati per poter essere evoluti in senso conviviale e vanno abbandonati. Senza se e senza ma, senza illusioni e senza rimpianti.
Beninteso, la dimensione artigianale non porta automaticamente con sé l’avvento del regno della libertà; rende però affrontabili in maniera autogestita, direttamente dalle persone implicate, problemi altrimenti delegati a istituzioni più o meno corrotte.
D’altra parte, l’elogio dell’artigianato non deve portare all’ennesima contrapposizione fra attività «alte» e «basse», cioè all’emersione di una gerarchia inversa all’attuale, in cui le attività manuali verranno ritenute superiori a quelle intellettuali. Le pratiche conviviali sono necessariamente concrete e teoriche insieme, proprio come un convivio, un simposio, una cena: senza organizzazione sarebbe un caos sgradevole; senza discorsi e chiacchiere sarebbe noioso; senza pietanze sarebbe una tristezza. I critici dell’informatica tendono a esaltare il lavoro pratico, il fare manuale, come se il digitale fosse un lavoro necessariamente astratto, smaterializzato. Il digitale diventa così la sentina di ogni vizio, la causa della stupidità umana, l’emblema della decadenza da contrapporre alla pratica artigianale rigenerante. Abbiamo visto invece che l’interazione con il digitale implica la relazione con miriadi di sistemi assolutamente materiali e concreti. E comunque materiale non significa di per sé «buono» in quanto soggetto a manipolazione manuale. La questione è saper valutare se quelle interazioni vanno nella direzione dell’asservimento reciproco o della liberazione reciproca.
Ogni essere umano può sviluppare capacità del genere, ma ci vuole un po’ di sforzo per sottrarsi agli automatismi, al conformismo delle proprie abitudini interattive automatizzate. Bisogna dunque disertare i sistemi privi di frizione, scegliere un po’ di attrito, sporcarsi le mani, coltivare l’amore per la materia che si connette, s’incastra, si plasma insieme a noi.
La libertà come sforzo collettivo
Nel capitolo quinto abbiamo visto come nella genealogia dei sistemi di pagamento si manifesti la tendenza a eliminare ogni attrito, allontanando la complessità tecnica e forzando l’umano ad affidarsi alla soluzione tecnica come a una credenza incontrovertibile. Questo esempio può essere generalizzato: la delega tecnica tende a generare una quantità straordinaria di apparecchiature connesse fra loro, nascoste all’utente, che può rimanere del tutto ignaro, ma deve al contempo credere fortemente che tutto possa funzionare come si deve. Svelare gli strati delle interazioni aiuta a farsi un’idea della situazione in cui siamo immersi, a ridurre l’alienazione tecnica e quindi a rendere possibili eventuali scarti rispetto alla norma dominante.
L’evoluzione delle interfacce digitali del dominio è orientata a ridurre al minimo ogni frizione. Del resto accade anche nel mondo analogico: la tendenza a sostituire i semafori con le rotonde in prossimità degli incroci stradali è una chiara spia dell’imperativo a non fermare il flusso, sia esso di veicoli o di dati.
Le interfacce mediano gran parte delle nostre relazioni con gli oggetti digitali. Consideriamo i computer. Esistono interfacce hardware, ad esempio i bus, che trasferiscono i dati fra i componenti interni dei dispositivi elettronici; interfacce periferiche che possono essere di input (tastiere, webcam, mouse, ecc.), di output (monitor, altoparlanti, stampanti, ecc.) e di i/o (input/output) come le chiavette usb di memoria. Ma oggigiorno il termine interfacce evoca perlopiù le modalità con cui i software si offrono all’interazione con l’utente. In ogni caso, un’interfaccia è un confine condiviso e poroso, una sorta di filtro o meglio ancora un luogo nel quale avvengono traduzioni che permettono la comunicazione fra due o più componenti di un sistema informativo. Un monitor tattile è un’interfaccia esplicitamente mista: è una periferica di i/o, bidirezionale, e al tempo stesso richiede un sistema software.
Il termine interfaccia risale alla fine del xix secolo. Veniva usato nelle scienze fisiche, dapprima in termodinamica per descrivere la soglia fra due sistemi termodinamici; in seguito in idrostatica, per designare la superficie di contatto fra due diverse sostanze. Riemerso nell’ambito cibernetico, è stato poi reintrodotto dal teorico dei media Marshall McLuhan negli anni Sessanta del xx secolo nel senso di «luogo di interazione fra due sistemi». Le interfacce sono quindi il luogo in cui gli umani vengono a contatto con gli esseri tecnici digitali.
Oggi nell’industria informatica si usa il termine «interfaccia utente» (User Interface, ui) per riferirsi solo al livello grafico con cui si presuppone che gli utenti debbano interagire. Ma queste «interfacce utente» sono solo le porte principali, quelle più frequentate. Ci sono molte interfacce negli oggetti digitali, di accesso più o meno semplice per gli umani. In generale è possibile interagire con lo stesso essere tecnico attraverso molte interfacce diverse. Il fatto che si limiti l’interazione al livello grafico, il cosiddetto user friendly, amichevole per l’utente, coincide con una riduzione drastica di libertà sia dal lato tecnico sia da quello umano. Per realizzare questa presunta semplicità vengono aggiunti nuovi strati. Dal lato dei gestori abbiamo già menzionato macchine virtuali, container e orchestratori; dal lato dell’utente c’è una quantità impressionante di strati tecnici non immediatamente visibili, inscatolati l’uno nell’altro e ricoperti da un ultimo strato visibile, tipicamente quello del web.
Possiamo interagire con google.com digitando l’indirizzo su un navigatore web, ad esempio Firefox. Oppure possiamo aprire un amico terminale e digitare:
kappa@erato:~$ curl https://www.google.com
Risponde sempre Google, è lo stesso oggetto tecnico, solo che curl, il sistema usato nel secondo caso, va subito al sodo e chiede quello che si cela dietro l’apparenza levigata e «semplice» del motore di ricerca. La risposta è un bailamme di codice javascript offuscato, cioè appositamente confuso per fare in modo che nessuno possa comprenderlo, copiarlo, modificarlo e riutilizzarlo. Per verifica indipendente, se non avete curl ma volete vedere cosa sta sotto Google, potete ottenere lo stesso risultato anche sul navigatore web grafico, basta digitare:
ctrl + u (command + u su Macintosh).
Fare un po’ di fatica in più ci permette di comprendere meglio il prezzo della mancanza di attrito: la completa perdita di senso degli strati sottostanti delle interfacce, delegati all’autorità tecnica.
Possiamo tradurre questo esempio nell’ambito della scuola e della formazione in generale. Si parla tanto di classi proattive, ambienti fluidi, ipermediali, interattivi. Nella stragrande maggioranza dei casi si propone di rendere computer, videoproiettori, lavagne multimediali e così via il più possibile invisibili, in modo che risultino naturali proprio come la lavagna e i banchi nell’ambiente-classe, al fine di non rivestire la tecnologia di un’aura mistica.
L’obiettivo è più che condivisibile, ma il metodo no. La parte cooperativa della cultura hacker ci insegna che «fare propria» la tecnologia significa «smontare» le macchine (a livello sia hardware sia software), capirne il funzionamento, rimontarle e riassemblarle per rispondere al proprio desiderio cognitivo e sociale. Non è necessario dissimulare le macchine, al contrario: è fondamentale rimarcare in ogni momento che le macchine modificano il nostro spazio cognitivo e sociale, perché sono esseri complessi.
In questo senso, l’enorme sforzo da parte di formatori e insegnanti nella costruzione di lo (Learning Objects) il più possibile conclusi e parcellizzati, delle specie di pillole di sapere adatte a essere digerite da classi «distrattente», potrebbe rivelarsi nocivo più che inutile. Anche perché, se tutto è raggiungibile qui e ora attraverso piattaforme e servizi in rete, se non si percepisce la differenza tra chattare con gli amici e chattare con il coach (umano o assistente artificiale che sia) della classe virtuale che spiega la lezione, diventa quasi impossibile stratificare conoscenze. Queste attività sono talmente routinarie che non costano nulla, dunque diventa inutile ricordare e organizzare le proprie conoscenze: i supporti digitali progettati come servi rendono le informazioni sempre disponibili, a portata di click.
Ecco il problema fondamentale: lo sforzo richiesto per imparare è praticamente nullo, perché assistere a una lezione non è diverso che stare davanti al proprio pc di casa. Non voglio fare l’elogio della versione di greco, del rompicapo di matematica o dei tomi da migliaia di pagine, ma sottolineare che (un po’) di fatica nell’apprendimento è essenziale per sviluppare un sapere riflessivo, una memoria capace di accostamenti imprevedibili e dunque di creatività, insomma per sviluppare autonomia.
La ri-mediazione di contenuti nell’epoca digitale può ridurci alla costruzione di pillole di sapere assimilabili come pappa pronta per le classi multimediali. Il metodo è parte del contenuto. L’attitudine di fondo orienta il percorso. Ovvero i contenuti non esistono separati da metodologie di apprendimento. E mirare a ottenere dei buoni voti è un’attitudine totalmente aliena all’attitudine hacker di giocare con curiosità insieme alle macchine. Un esempio banale: invece di spiegare con slide come funziona il metodo scientifico, si potrebbe smontare un computer insieme agli studenti e provare a capirne il funzionamento. Allora le macchine sarebbero tutto fuorché simulacri circondati da un alone mistico.
Di certo la scuola deve cambiare, essere progettata a misura di studente come uno spazio cooperativo modulare nel quale il docente impara mentre insegna e il discente spiega mentre entrambi esplorano e creano insieme un territorio condiviso. Ma non c’è bisogno di ambienti ipermediali né di tecnologie avveniristiche per immaginare spazi simili. Nel 1970 veniva pubblicato Descolarizzare la società di Ivan Illich, una critica radicale e definitiva dell’istituzione scolastica, caratterizzata dal rapporto autoritario docente/discente, come unica risposta legittima ai bisogni formativi. Infatti, costringere gli allievi, seduti nei banchi molte ore al giorno per molti anni della loro vita, è il miglior modo per omologare le menti attraverso l’irreggimentazione dei corpi, marginalizzando come «devianti» quelli che non si adeguano al regime scolastico. O bollandoli come «iperattivi» da sedare per via farmacologica.
Descolarizzare il digitale, anche tematizzando la fatica e il disagio della mediazione tecnica, di oggetti e procedure percepite come disfunzionali o invasive, è quanto mai urgente. In generale, la messa a punto di esseri digitali frictionless e seamless, senza frizioni e senza cuciture, contribuisce all’aumento dell’alienazione tecnica. Fare un po’ di fatica non è una scelta etica, dettata da un perverso amore per la sofferenza, ma una scelta estetica. Moltiplicare e arricchire le modalità di relazione esplicite con gli esseri tecnici rende il mondo un luogo più piacevole perché più vario; opponendosi alla monotonia, la varietà e la diversità sono ingredienti essenziali di ogni convivio, anche del convivio tecnologico.
Scegliere il proprio ambiente associato
Abbiamo visto che la dicotomia fra piattaforme globali e locali è fuorviante, perché si concentra sugli aspetti quantitativi, la scala di diffusione e la portata, senza valutare gli aspetti qualitativi. La filiera di produzione, distribuzione e consumo del cibo presenta notevoli analogie con la filiera mediatica e il sistema tecnico-tecnologico nel suo complesso.
La crescita della domanda di cibo bio-organico in senso lato in questo primo scorcio di xxi secolo può essere un esempio per l’evoluzione di reti tecniche bio-organiche4, nel senso di conviviali. L’analogia è chiara: i media di massa sono una forma di nutrimento. Proseguiamo la declinazione dell’antica metafora del «cibo per la mente» (forse rielaborazione laica di passi biblico-evangelici) in termini di risparmio energetico, rifiuto dello sfruttamento di risorse umane e non. Ne derivano logicamente la necessità di media e reti «locali», «a chilometro zero», costruite in maniera «equa e solidale», e così via, fino all’esplicito riferimento al mutuo appoggio.
Proprio come scegliamo gli alimenti di cui ci nutriamo, così dovremmo porre attenzione ai sistemi tecnici che strutturano le nostre relazioni, ai sistemi mediatici che danno forma alle nostre vite agli occhi degli altri. In un mondo ad alta intensità tecnica, ogni scelta è rilevante. Ogni scarto dalla norma dominante può diventare un esempio da diffondere, moltiplicare e adattare. Non si tratta di esagerare il potenziale dei piccoli gesti, ma di riaffermare un concetto semplice. O riteniamo che la gran parte degli esseri umani, degli esseri tecnici, degli animali, delle piante e così via abbia bisogno di tutela, di essere sottomesso a un despota, a un padre-padrone, a qualcuno che sceglie al posto suo, eccezion fatta per alcuni scaltri, potenti e dominanti, per natura o fortuna (ovvero per violenta autoaffermazione); oppure riteniamo che ogni essere vivente e non sia una potenziale fonte di liberazione per sé e per gli altri.
In termini sociali e di teoria del potere, o il governo è necessario, e la coppia comando/obbedienza struttura necessariamente ogni spazio personale e politico; oppure il governo, compreso il governo di sé, è un’aberrazione storica, un ramo deleterio dell’evoluzione che va al più presto abbandonato in favore dell’assenza di ogni governo, dell’abolizione di ogni obbedienza e di ogni comando, cioè in favore dell’anarchia.
Nel primo caso, questo è il migliore dei mondi possibili perché attraverso l’estensione illimitata del dominio tende a soggiogare ogni essere, vivente e non; ogni resistenza è dunque vana. Nel secondo caso, invece, scegliere i propri amici, compagni e affini tecnici è altrettanto rilevante della scelta dei propri amici, compagni e affini umani, animali, vegetali e così via. Non solo, ma può diventare un esempio da moltiplicare e adattare a circostanze diverse.
Il concetto di «viralità» è particolarmente rilevante. In un mondo in cui la comunicazione è così facile, le buone e le cattive idee possono viaggiare in maniera incredibilmente veloce, proprio come i virus organici. Questa è un’ottima notizia! Forse tutto ciò che serve è l’occasione giusta, delle buone idee, delle buone pratiche, facilmente replicabili e adattabili, capaci di mutare l’evoluzione delle cose anche in momenti in cui tutto sembra andare di male in peggio. «Pensare globalmente, agire localmente» rimane un’indicazione valida, con la sottile ma cruciale differenza che il pensare globale non deve riguardare il «sistema» in sé, ma i suoi «semi». Anche e soprattutto nell’ambito della tecnica è possibile ibridare, selezionare e diffondere in maniera virale il semi del mutuo appoggio.
Note al capitolo
1. François Laplantine, Identità e meticciato, elèuthera, Milano, 2004; ed. or. Je, nous, les autres. Êtres humains au-delà des appartenances, Le Pommier, Paris, 1999, p. 9.
2. La realtà dei server indipendenti è molto ricca e variegata. Nei materiali di approfondimento all’indirizzo
3. Un esercizio di genealogia della tecnica crittografica si può trovare in Vivien García, Carlo Milani, Cryptogenealogia – Primo frammento per una genealogia della crittografia (dai Cypherpunks a Wikileaks), «Mondo digitale», 69(2), 2017.
4. Per un approfondimento sull’idea di Internet Organica si veda Carlo Milani, Panayotis Antoniadis, Reti bio-organiche, «Mondo digitale», 1(90), 2021.
Conclusione
Per concludere questa esplorazione non si può far altro che aprire alle possibili evoluzioni. L’evoluzione del rapporto fra esseri umani ed esseri tecnici è in corso. Le loro relazioni di potere non sono state stabilite una volta per tutte. Nessuno degli attori in campo può davvero sottrarsi; se lo fa, sceglie di adeguarsi alle misure di idoneità stabilite da qualcun altro. Nessuno è ininfluente, per quanto si percepisca privo di potere. A partire dalla propria prospettiva situata, chiunque può acquisire potere e diffonderlo, per aiutare a ridefinire in senso libertario le norme che regolano la vita sociale, di cui la tecnica è parte integrante. È un’ottima notizia, perché l’evoluzione tecnica è troppo cruciale per essere lasciata nelle mani di esperti prezzolati, o di comuni mortali esasperati dai guasti dei loro servi meccanici, come abbiamo visto.
Avere a che fare con le macchine può comportare esperienze faticose, noiose, frustranti. Questo è ancora più vero con le macchine digitali sfornate dal sistema militare industriale, perché sono concepite e costruite per rinforzare la sottomissione ai meccanismi di comando/obbedienza: obbedire alla procedura per comandare la macchina, comandare la macchina per conformarsi al governo di sé e degli altri. Ma l’allegria, il divertimento e la gioia di riuscire a stare e funzionare insieme alle macchine affini, nella turbolenza del mondo in divenire, è un’esperienza altrettanto possibile e alla portata di tutti e di ciascuno.
Per gustare queste deliziose opportunità, bisogna accantonare il paradigma dell’utilità, l’idea malsana di usare gli oggetti tecnici per raggiungere i nostri scopi. Magari non sempre e comunque, ma spesso, almeno come esercizio di formazione e autoformazione. È eccezionalmente efficace. Invece di ragionare in termini di mezzi, è fondamentale imparare a relazionarci agli esseri tecnici come compagni di gioco.
Nel gioco ci sono certamente delle regole. Ma nessuno obbedisce e nessuno comanda: si gioca insieme, attenendosi alle regole. Si possono anche inventare nuove regole, e, naturalmente, nuovi giochi. Non ci sono servi sottoposti necessari a far accadere le cose. Il gioco non è un lavoro meno impegnativo perché svagato, privo di obiettivi concreti e di remunerazione; al contrario, il gioco è un’attività appassionata, coinvolgente e gratificante; il gioco è magia conviviale, libera dalle pastoie del salario e del compenso. Giocare con le macchine, anche con le macchine digitali, è un ottimo modo per imparare a conoscerci e ridurre così l’alienazione tecnica.
La dimensione ripetitiva della relazione con la tecnica, in particolare digitale, va sottratta all’alienante coazione a ripetere per ottenere gratificazioni chimiche. Ripetere è il modo migliore per imparare, come sa chiunque provi ad allenarsi per riuscire a eseguire in maniera soddisfacente un’attività qualsiasi. Allo stesso modo, provando e riprovando si può imparare a funzionare meglio insieme alle macchine; meglio, cioè in maniera più consapevole, non ripetendo una litania di cui non comprendiamo il significato, ma strutturando rituali di interazione che ci gratificano profondamente. Ripetere in questi casi non vuol dire reiterare in maniera identica, ma ripercorrere dei passi scelti accuratamente per godersi il percorso, ogni volta in maniera più piena. A volte si cammina su un sentiero sconosciuto, perciò si fa attenzione, magari si cercano punti di riferimento un po’ grossolani per non perdersi; è logico e funzionale, ma così si trascurano i dettagli. Quando capiterà di ripercorrere quel sentiero si potranno tralasciare i passaggi già noti e concentrarsi su altro.
Non si percorre mai la stessa identica strada, non si naviga mai nello stesso identico mare, né nella stessa identica rete. Il fatto che il retaggio del dominio si mostri così soverchiante e apparentemente vincente in ogni dove non è una buona ragione per conformarsi. Ci sono un sacco di strade da tracciare, e alcune vecchie tracce dimenticate potrebbero nascondere sorprese inaspettate.
Come la biodiversità è la miglior garanzia in natura, così lo è anche nella tecnica e nell’evoluzione di tecnologie conviviali. Le identità, individuali e collettive, sono fasci di relazioni in continuo mutamento. La diversità è la forza della tecnica. C’è chi adora una particolare configurazione, chi preferisce un certo software, chi si personalizza un intero sistema operativo. C’è chi è cascato dentro orgmode (ripudiando di fatto le proprie antiche devozioni in quanto fedele di Vi) e ha cominciato a pensare seriamente di trasportare tutto ciò che gli piace e con cui ha a che fare dentro Emacs. C’è chi costruisce sistemi alimentati a energia solare che consumano poca elettricità; i servizi che espongono sono accessibili solo quando il sole splende sui pannelli solari che alimentano quelle macchine, invece di essere disponibili sempre e comunque. C’è chi inventa linguaggi di programmazione esotici, chi si diverte a compilare programmi astrusi, chi traduce in ascii qualsiasi cosa si presenti sullo schermo.
Molti animali giocano, non appena hanno tempo ed energie per farlo. Gli uccelli si divertono a cantare. Gli esseri umani anche, e hanno costruito degli strumenti musicali per suonare, ampliando le possibilità offerte dalle corde vocali. Anche i computer hanno imparato a suonare, e persino a comporre musica.
Tutte queste creazioni, frutto di tanto esercizio e di tanti calcoli, algoritmi che effettuano dei cicli e poi vengono modificati per ripetere in maniera diversa, diventano delle liturgie. Proprio come le antiche liturgie, sono lavori pubblici. Plasmano il mondo in cui viviamo, plasmano le identità degli individui, le relazioni che intrattengono fra loro e con l’ambiente circostante. Questi rituali d’interazione possono evolvere in maniera degradante, oppressiva, cruenta, avvilente. Lo sappiamo, spesso li subiamo. Ma a me personalmente non convincono le sirene della rassegnazione, le voci reazionarie che intonano il peana del bel mondo andato, che rimpiangono la purezza e l’innocenza perduta, ricordando che non c’è alternativa, e in ogni caso a che serve una manciata di persone che non si conformano, quando la massa si adegua… E nemmeno mi convince l’idiozia suicida, altrettanto reazionaria nel suo sedicente progressismo, della corsa sfrenata allo sviluppo del prossimo gadget tecnologico, della prossima tecnologia rivoluzionaria che non rivoluziona nulla, ma rinsalda un po’ di più la catena del governo tecnoburocratico. Atteggiamenti opposti, ma ugualmente rinunciatari, succubi di sé stessi, proni al destino ineluttabile che contribuiscono a modellare.
Preferisco l’attitudine hacker, una concreta via per valorizzare le caratteristiche di ciascuno e trasformarci insieme a ciò che ci circonda. Una buona dose di curiosità, tanta pazienza per ripetere, precisione per tradurre, predilezione per la robusta semplicità che può germogliare in mille forme diverse, diffondersi, federarsi, meticciarsi: ecco alcuni ingredienti. Le tecnologie conviviali esistono già, sono i rituali condivisi fra umani e tecnici affini, che si cercano, si riconoscono e scelgono di combinare qualcosa insieme; rituali di gioco, sperimentazione e, sempre, espansione dei margini di libertà reciproci.
Bibliografia di riferimento
bakunin Michail, La libertà degli uguali, elèuthera, Milano, 2017.
bazzichelli Tatiana, Networking. La rete come arte, Costa&Nolan, Milano, 2006.
bertolo Amedeo, «Potere, autorità, dominio: una proposta di definizione» (1983), in Anarchici e orgogliosi di esserlo, elèuthera, Milano, 2017.
bookchin Murray, L’ecologia della libertà, elèuthera, Milano, 2017.
boud David, cohen Ruth, walker David, Using Experience for Learning, Society for Research into Higher Education & Open University Press, London, 1993.
canetti Elias, Massa e Potere, Adelphi, Milano, 2015.
crawford Kate, Né intelligente né artificiale. Il lato oscuro dell’ia, il Mulino, Bologna, 2021.
darwin Charles, L’origine delle specie, Bollati Boringhieri, Torino, 2011.
deleuze Gilles, guattari Félix, «Appendice, Bilan-programme pour machines désiderantes», in L’Anti-Œdipe, Minuit, Paris, 1972, p. 479 [trad. it. «Bilancio-programma per macchine desideranti», in Macchine desideranti, Ombre corte, Verona, 2004, p. 114].
deseriis Marco, marano Giuseppe, Net.art. L’arte della connessione, ShaKe, Milano, 2008.
eubanks Virginia, Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor, St. Martin’s Press, New York, 2018.
freire Paulo, La pedagogia degli oppressi, Gruppo Abele, Torino, 2014.
garcía Vivien, milani Carlo, Cryptogenealogia – Primo frammento per una genealogia della crittografia (dai Cypherpunks a Wikileaks), «Mondo digitale», 69(2), 2017,
gellio Aulo, Notti Attiche, x, 12, 9.
gimbutas Marjia, Kurgan. Le origini della cultura europea, Medusa, Milano, 2020.
gould Stephen J., vrba Elizabeth, Exaptation. Il bricolage dell’evoluzione, Bollati Boringhieri, Torino, 2008.
haraway Donna J., Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, «Feminist Studies», vol. 14, n. 3, 1988, pp. 575-599.
haraway Donna J., Staying with the trouble: Making Kin in the Chthulucene, Duke University Press, Durham-London, 2016 [trad. it. parziale Chthulucene: sopravvivere su un pianeta infetto, nero, Roma, 2019].
heidegger Martin, La questione della tecnica, GoWare, Firenze, 2017.
ibáñez Tomás, L’anarchia del mondo contemporaneo, elèuthera, Milano, 2022.
illich Ivan, Tools for conviviality, Harper & Row, New York, 1973 [trad. it. La convivialità. Una proposta libertaria per una politica dei limiti allo sviluppo, Boroli, Milano 2005].
jacobs Jane, Città e libertà, elèuthera, Milano, 2020.
jonas Hans, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1989 [trad. it. Il principio responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino, 2009].
laplantine François, Je, nous, les autres. Êtres humains au-delà des appartenances, Le Pommier, Paris, 1999 [trad. it. Identità e meticciato, elèuthera, Milano, 2004].
levi moreno Jacob, Who shall survive? Principi di sociometria, psicoterapia e sociodramma, a cura di M. Gasseau, Di Renzo, Roma, 2007.
milani Carlo, antoniadis Panayotis, Reti bio-organiche, «Mondo digitale», 1(90), 2021,
montagu Ashley (a cura di), Il buon selvaggio, elèuthera, Milano, 2021.
mumford Lewis, The Myth of the Machine, Harcourt, Brace and World, New York, 1967 [trad. it. Il mito della macchina, il Saggiatore, Milano, 2011].
nietzsche Friedrich, Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, 1873 [trad. it. Su verità e menzogna in senso extra-morale, Adelphi, Milano, 2015].
noble Safiya Umoja, Algorithms of oppression: how search engines reinforce racism, New York University Press, New York, 2018.
ore Øystein, I grafi e le loro applicazioni, Zanichelli, Bologna, 1965.
page Scott E., Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools and Societies, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2007.
simondon Gilbert, Du mode d’existence des objets techniques, Aubier-Montaigne, Paris, 1958 [trad. it. Del modo di esistenza degli oggetti tecnici, Orthotes, Napoli-Salerno, 2020].
simondon Gilbert, Sur la technique, puf, Paris, 2014 [trad. it. Sulla tecnica, Orthotes, Napoli-Salerno, 2017].
smith Robert Elliot, Rage Inside the Machine: The Prejudice of Algorithms, and How to Stop the Internet Making Bigots of Us All, Bloomsbury Business, New York, 2019.
solnit Rebecca, Un paradiso all’inferno, Fandango Libri, Roma, 2009.
tagliente Antonio, La colomba di Archita, Scorpione, Taranto, 2011.
thaler Richard, sunstein Cass R., Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness, Yales University Press, New Haven, 1999 [trad. it. Nudge. La spinta gentile: la nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, Feltrinelli, Milano, 2017].
ward Colin, Anarchia come organizzazione, elèuthera, Milano, 2019.
wiener Norbert, La Cibernetica. Controllo e comunicazione nell’animale e nella macchina, il Saggiatore, Milano, 1982.
wiener Norbert, Dio & Golem s.p.a.: cibernetica e religione, Bollati Boringhieri, Torino, 1991.
wiener Norbert, Introduzione alla cibernetica: l’uso umano degli esseri umani, Bollati Boringhieri, Torino, 2012.
Ringraziamenti
Grazie a circe (circex.org) e a chi ha partecipato alle formazioni di Pedagogia Hacker che insieme abbiamo messo a punto, preziose esperienze in giro per l’Europa.
A HackMeeting, Panos, l200, los Allaqqat, Michelangelo, Toni, Jops, Lesion, Spideralex; a chi ha riletto, suggerito, aggiustato e che ora dimentico; a tutte le occasioni di incontro con creature affini. L’organizzazione è sempre la parte più difficile.
Ad Abi, Rossella, Sara Giulia e tutta la redazione di elèuthera che ha supportato e sopportato la lunga stesura di queste pagine. Gli errori rimangono a carico mio.
A Zac e Mora che mi hanno fatto alzare, spegnere Erato e portato a zonzo. Grazie Vale.
Ringrazio le macchine libere dalla cattività delle tecnologie del dominio, le macchine sorelle senza le quali oggi non è possibile comunicare e operare.
E in ordine sparso: Markdown, gnu Emacs, Org mode, ssh, alekos.net e lola, latex, Nextcloud, Etherpad, Thunderbird, vulgo-floShare e tutti gli umani che vi hanno contribuito.